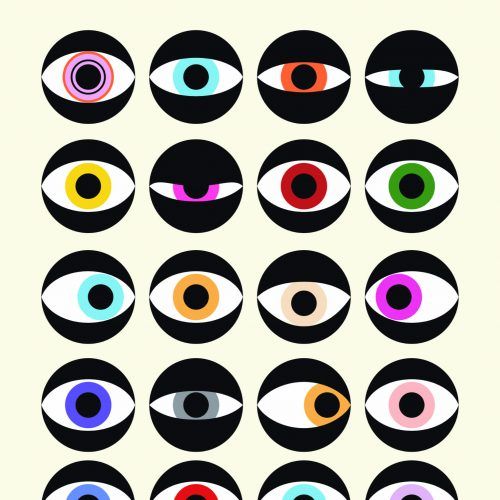La teoria più affascinante che ho sentito ultimamente riguardo ai sogni è dello psicologo Robert Epstein. Sostiene che i sogni non ci appartengono e che ci vengono trasmessi da qualche altra dimensione. Lo dimostrerebbe il fatto che, al risveglio, non li ricordiamo più se non per pochi secondi. Basta il tempo di andare in bagno e, anche chiudendo gli occhi per cercare di trattenerne qualche brandello, quelli sono già svaniti, lasciandoci con, al più, la sensazione che avevano suscitato.
Perché non ricordiamo i sogni? Perché non possiamo suscitarli? Perché non possiamo decidere prima di addormentarci che sogni fare, come se fossero un programma televisivo che si può scegliere?
Secondo Epstein insomma, i sogni non possono sedimentare nella memoria ed essere ricordati perché non sono prodotti dalla nostra mente ma provengono da altrove. Come uno streaming televisivo insomma, una volta terminata la trasmissione dei dati non ne rimane traccia sull’hard disk biologico, cioè nel nostro cervello.
Io ricordo pochi dettagli dei sogni che ho fatto e che faccio. Amo molto dormire proprio perché so che vivrò in un’altra dimensione totalmente surreale per qualche ora. Quando ne trattengo alcuni dettagli (probabilmente solo dei fermo immagine) ne cerco il significato in antichi o più moderni testi sull’interpretazione dei sogni. Cerchiamo significati ovunque ed è un paradosso che lo facciamo nell’esperienza più surreale che possiamo vivere e non nel contingente e nel reale, cioè nella vita cosciente. Ma quanto cosciente è, poi?
Salvador Dalí utilizzava una tecnica per catturare immagini dal suo subconscio mentre si addormentava. Si sedeva su una sedia tenendo in mano un pesante mazzo di chiavi sopra un piatto capovolto posizionato sul pavimento. Mentre si addormentava, le chiavi cadevano facendo rumore e svegliandolo, permettendogli così di ricordare e annotare le immagini oniriche che aveva appena sperimentato. In altri frangenti l’ho sentito descritto diversamente: al posto del mazzo di chiavi usava un cucchiaio, che svolgeva sempre la funzione di scivolargli di mano e di svegliarlo.
William S. Burroughs restava con gli occhi chiusi dopo il risveglio, come se le palpebre potessero impedire alle immagini oniriche di sfuggire ed essere dimenticate. Quindi ne annotava i dettagli che riusciva a ricordare.
Il rapporto col ricordo dei sogni sembra il racconto di un inseguimento, in cui non si raggiunge mai ciò che si insegue: è troppo veloce ed effimero e, quando crediamo di averlo afferrato, svanisce fra le mani come una nuvola di polvere.
Forse per questo siamo sempre stimolati a inseguirlo, specie quando è un sogno di rara bellezza o quando pensiamo che contenga indizi e indicazioni. Pensiamo (o penso, parlo per me) che siano l’espressione di una voce più saggia che insegna, conosce, consiglia. Ma non riesco mai ad ascoltarla con chiarezza, oppure parla una lingua incomprensibile.
Più che chiedersi perché scompaiono o perché non li ricordiamo, dovremo forse chiederci perché ci sembra così importante ricordarli.
Da sempre l’umanità cerca di interpretare i sogni. Ho il sospetto che la loro natura così surreale abbia sempre suggerito alla mente che dovessero essere latori di un messaggio da decifrare. Più assurdi e irreali sono, più immaginiamo che nascondano qualcosa: qualcosa che non si può dire esplicitamente, e allora usa la metafora. Ho anche letto che ogni sogno è una metafora e che, se si sogna che qualcuno muore, l’atto del morire non è mai riferito a quella particolare persona ma è allegorico di qualcosa che nella vita personale sta morendo o che si teme che possa morire. I sogni insomma sarebbero rielaborazioni figurate (forse allegoriche?) del vissuto reale, opera del cervello che non riposa mai. Dato che diamo funzioni a ogni cosa, quella dei sogni sarebbe quella di mettere ordine nelle esperienze reali o di far pulizia degli scarti e dei detriti, da cui l’importanza di dormire a lungo: non solo per riposare le membra ma anche per permettere una pulizia più approfondita. Da questo punto di vista sono spacciato, dato che dormo 4-5 ore al giorno. Ma procediamo.
Se l’unico strumento che hai è un martello, tutto il mondo ti sembrerà fatto di chiodi. È un detto a cui penso spesso, e per me indica la pericolosità dell’avere un unico punto di vista. Guardando le cose da una soggettiva ossessiva non le si vede bene. Io ho un martello, e si chiama tempo. Specifico meglio: cerco di capire come tutto si possa ricondurre all’influenza che il tempo ha sulla mia vita. Del resto vivo – come tutti – immerso nella dimensione temporale, quindi mi sono scelto bene il mio martello.
Dico questo perché riflettendoci mi sono accorto che la mia speculazione sui sogni ruota proprio attorno alla loro capacità di sospenderlo, invertirlo, comprimerlo, dilatarlo.
I sogni fanno una cosa che io non posso fare: giocano con il tempo.
I sogni insomma indicano desideri repressi e portano in superficie paure e speranze. Denudano un universo emotivo che è normalmente sopito o a cui è data poca voce nella fase cosciente. Nel sonno possono esprimersi ed esplodere in complesse azioni e nella negazione della fisica. Nei sogni voliamo, ringiovaniamo, moriamo senza morire, facciamo le cose che non avremmo il coraggio di fare davvero, siamo intimoriti da quelle che non ci spaventano nella realtà, o a cui nemmeno pensiamo.
I sogni sono insomma la nostra immagine nascosta: non quella speculare, ma quella che non vediamo e che non vogliamo vedere.
I sogni sono la faccia oscura della Luna.
Dicendo “oscura” non intendo che siano un’espressione maligna: dico solo che appartengono a una dimensione che non può essere osservata né evocata. Se non in sogno.
Dicevo: il tempo. Nei sogni il tempo non ha uno svolgimento lineare e non assomiglia all’esperienza cosciente che ne abbiamo. Il tempo nei sogni si dipana, si riavvolge, accelera, decelera. Segue una logica illogica. Eppure tutto ha senso nei sogni perché, quando vengono sognati, prevedono l’abbandono a una razionalità diversa, che risponde a leggi non fisiche.
Il tempo è una dimensione fisica, quindi cede il suo dominio solo in una dimensione non fisica, e quindi onirica. Nel sogno il tempo perde la sua fisicità e non può più ordinare le cose in una costruzione logica. Lo spazio stesso, una dimensione ancillare del tempo, è stravolto: è compresso e dilatato, è capovolto e invertito. Nello spazio deli sogni ci sta tutto mentre lo spazio reale risponde a un principio di scarsità: le cose devono rispettare una legge che impone che ognuna occupi uno spazio, e che non possano compenetrarsi senza modificare la propria struttura. Nei sogni possono farlo: possono mutare, diventare altre cose, dare forma ai pensieri.
I pensieri che stanno nella mente, a ben vedere, rispondono alla stessa logica: pare che ve ne possano stare un numero infinito, anche se poi non li si può evocare tutti contemporaneamente. Ogni giorno pensiamo decine di migliaia di pensieri: da qualche parte staranno, per esempio in uno spazio infinito, che li contiene tutti.
Spazio e tempo sono le due dimensioni in cui siamo immersi e sono le stesse che sono stravolte nel sogno. Ecco che il sogno è una fuga dalla dimensione fisica: sogniamo per non essere corpi materiali, sogniamo per ritornare a una dimensione infinita da cui forse proveniamo.
La stessa da cui secondo Epstein riceviamo il segnale della trasmissione del nostro sogno, la stessa da cui proveniamo e a cui cerchiamo di tornare ogni notte, o almeno quando dormiamo.
In un altro numero de Il Pensiero Lungo ragionavo attorno a un’illuminazione che ebbi un giorno, come sempre passeggiando: che cioè la veglia fosse il sogno e il sogno fosse la vita reale. Che il risveglio fosse un addormentamento e che il l’addormentamento fosse il ritorno alla vita reale. In questo sovvertimento speculare, ciò che è sognato è reale ma non viene ricordato e ciò che è reale è sognato, e resta impresso nella mente. Per questo ricordiamo al risveglio/addormentamento chi siamo, mentre dimentichiamo chi siamo nel sogno, cioè la nostra reale natura.
In verità, ne convengo, forse la mia è una risposta ad almeno due domande:
- Qual è la nostra reale natura?
- Si può fuggire al dominio della fisica?
Più i vari corollari, riassumibili nella domanda:
È possibile esistere in un dominio non fisico?
Non lo so. Non so se la dimensione in cui scrivo queste parole sia quella reale o se sia un elaborato sogno che poi dimentico quando sogno davvero, dato che in sogno non ho memoria: non ricordo di aver scritto queste parole e a malapena ricordo chi sono. In sogno non ci sono specchi, non posso controllare di essere davvero io, forse sono una presenza fantasmatica.
Il fatto che nei sogni non si ricordi e che non si ricordino i sogni dice però anche un’altra cosa: non esistono i ricordi perché non c’è il tempo, cioè la dimensione in cui collocarli.
Alla fine sogno (sogniamo) per vivere in una dimensione che non ha tempo e spazio, e che ci ricordi che siamo fatti di infinito, o di quello che più ci si avvicina: il cosmo.
Concludo con una scoperta. Delle parole che Carl Sagan disse riguardo al nostro esser fatti di stelle (starstuff, diceva lui) – ho appreso – se ne ricorda comunemente solo la prima parte. Vale la pena ricordarle per intero per dare un’idea della profondità del suo pensiero:
L’elemento che costituisce il 62% di noi in termini di quantità (solo il 9,5% in termini di massa) è l’idrogeno, e non è stato creato nelle stelle. È più antico delle stelle. L’idrogeno è ciò che rimane della materia che esiste da quando la materia esisteva. Siamo ‘starstuff’, ma siamo anche ‘pre-starstuff’. I nostri nuclei di idrogeno? La maggior parte è rimasta invariata dal momento in cui l’universo ha smesso di essere una zuppa di quark ed elettroni. Praticamente tutti i nuclei di idrogeno nell’universo risalgono a quando l’universo aveva MINUTI. Compreso ciò che è in noi.
Quindi conteniamo sia cioè che esiste dalla creazione dell’universo “fisico”, sia ciò che esisteva prima che questo fosse creato, cioè l’idrogeno.
Siamo vecchi come l’universo e anche di più, quando ancora non esisteva il tempo, assumendo che esso abbia avuto inizio alla creazione dell’universo. Che mi pare un inizio su cui si può concordare.
Forse sono giunto a una conclusione: i sogni sono fatti di idrogeno.