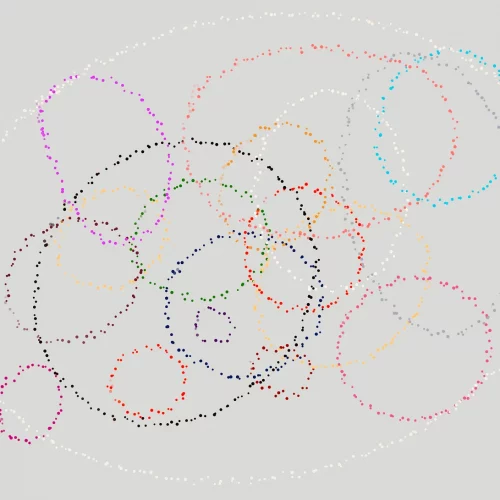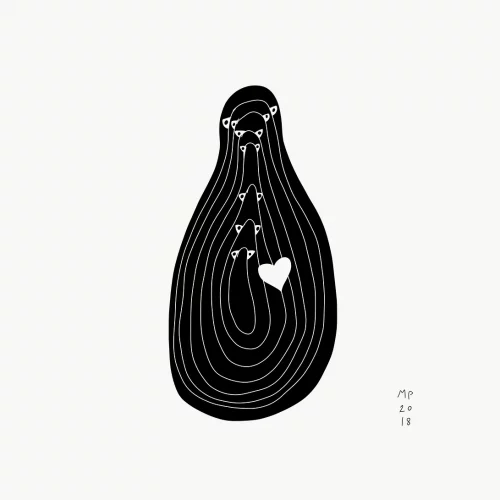Una volta mi capitò di vedere un film vecchissimo, in bianco e nero. Non ci sarebbe niente di strano se quello che avessi voluto fare fosse vedere un film in bianco e nero, per giunta raro. Il fatto è che ero convinto di partecipare a una conferenza sulla genitorialità. I miei figli erano piccoli e volevo mettercela tutta per essere un buon padre.
Vidi tutto il film chiedendomi cosa c’entrasse con il tema della serata e cercando di coglierne un messaggio nascosto. Non aiutava il fatto che riguardasse un gruppo di borseggiatori spinti al crimine da una vita di stenti. C’era in effetti un ragazzino in questo film, quindi — forse — potevo rintracciare nel rapporto fra lui e il borseggiatore esperto che doveva addestrarlo una qualche forma di relazione fra anime che si stanno formando e spiriti guida. Poteva avere un senso, ma era davvero faticoso coglierlo, specie perché sembrava davvero tirato per i capelli.
Non potevano semplicemente proiettare un film che parlasse esplicitamente di padri, madri, figli e figlie? Perché tutta quella fatica? Confidavo nel successivo dibattito. Quella cosa da cinema d’essai, quella pratica così desueta del “Seguirà dibattito”.
Ovviamente non ci fu nessun dibattito. Me ne andai chiedendomi dove fosse la conferenza a cui dovevo partecipare e anche se fosse mai esistita o me la fossi sognata.
Questo è solo uno dei tanti episodi di cose senza senso a cui ho partecipato e che ho collezionato durante la vita. Siccome conservo anche a questa età non più giovane la convinzione che il mio tempo sia infinito, non vi ho dato molto peso. Non ho, insomma, pensato di aver perso del tempo. So di averlo perso, ma una parte della mia mente (per ora ancora dominante) ha deciso che non è che non avessero senso: il fatto è che non l’avevo ancora colto.
A tutt’oggi non so che senso avesse nella mia parabola esistenziale quel film. Lo derubrico a quell’altro insieme di esperienze fatte e portate a termine, anche se non ne capivo il motivo. Perché restare a questa riunione? Perché non andarmene dalla visione di un film noioso? Perché non smettere un libro che non mi interessava? Perché non andare invece a fare un bagno in spiaggia al tramonto? Questa è facile: perché non vivo al mare.
Comunque: ho sempre sospettato che un senso, un giorno, si sarebbe palesato.
Non ho l’urgenza di capire tutto, e nemmeno il bisogno. Sono convinto che una certa dose di mistero sia vitale. Non capire tutto è un’esperienza nella quale sono perfettamente a mio agio.
Leggevo un articolo di Davide Etzi sulla crisi del lavoro, o meglio: sulla crisi del senso che la società contemporanea associa ormai al lavoro. Non sappiamo più a cosa serva lavorare, al di là della sempre più labile sicurezza economica offerta come contropartita. Il proposito di ciò che facciamo lavorando (per almeno un terzo della vita adulta, quindi non per poco) si è frantumato.
Ci stiamo insomma chiedendo che senso abbia tutto ciò. Torna il senso, o la ricerca di un senso. E io sono partito a scriverne qui dicendo che non lo capisco e che, forse, non mi interessa nemmeno trovarlo. Ma sono impreciso: in verità ho detto che non pretendo di capirlo adesso. E che spero di capirlo un giorno. Non ero finito a vedere quel film in bianco e nero per lavoro, ma per caso, aspettandomi di partecipare a una conferenza. Non stavo perdendo tempo produttivo. Ero un flâneur della mia stessa esistenza.
Facciamo esperienza (viviamo) per costruire memorie con cui cercare di capire il senso — ancora — della strada percorsa, fiduciosi di aver intrapreso la direzione giusta. La memoria sono le briciole che lasciamo dietro di noi, pensando che, ritornando a raccoglierle, la strada che prima si illuminava passo a passo sarà chiara e segnata. Capiremo perché l’abbiamo iniziata.
Ora non sono più tanto convinto che la cosa funzioni in questi termini. La memoria mi sembra piuttosto organizzata come un contenitore di biscotti frantumati: li riconosci come tali, ma sono parti, non unità.
Le memorie sono riferibili a parabole esistenziali definite ma non complete. Di un giorno di 28 anni fa ricordo 15 minuti, e nient’altro del resto. È fisiologico che sia così: non posso ricordare ogni dettaglio, anche perché sarebbe inutile farlo. Mi trascinerei appresso una quantità inutile di dati.
Però ricordo quello che conta, o dovrebbe essere così.
Ma perché lo ricordo? Ecco, in questa domanda – o nella sua risposta – colloco il senso.
A volte mi piace ricordare di quando un giorno, tornando dalla stazione, alzai gli occhi a guardare un fregio su un edificio pubblico a cui non avevo mai prestato particolare attenzione. Aveva qualcosa di familiare: mi ricordava un disegno che avevo fatto mesi o settimane prima. La cosa interessante è che se mi avessero chiesto di descrivere il soggetto o lo stile di quel particolare fregio avrei risposto “Fregio? Quale fregio?”.
Eppure l’avevo memorizzato da qualche parte, e lui era riaffiorato dall’inconscio, o dalla memoria. Il che non significa solo che l’avevo visivamente memorizzato ma anche che la mia mente era stata in grado di tenermi all’oscuro di quell’unità di memoria, e aveva deciso di farla riaffiorare un giorno di 20 anni dopo, non si sa per quale motivo (per farci un disegno, ecco perché).
Siamo insomma tenuti all’oscuro di dettagli salienti da noi stessi. I ricordi, del resto, sono autonomi: se li evochi non ascoltano, decidono loro di riaffiorare quando sentono un profumo che gli ricorda il ragù della nonna o una canzone ascoltata anni prima. E sarebbe anche facile che funzionasse così: la memoria suscitata per associazioni, insomma. Non è sempre così, perché ce n’è un’altra, più profonda, che raggiunge la superficie autonomamente. O per la quale è più difficile scoprire le associazioni che l’hanno evocata.
Ma tornando all’inizio: la memoria illumina il senso? Non so. Di certo so che è fatta di pagine che, messe insieme, sono un libro personale, e forse, riarrangiate in altro modo, sono una mappa del futuro. Potrebbe essere.
Dicevo: cercare un senso. Il senso è una questione molto personale. Il senso non è il significato. Dire “Che senso ha?” è diverso da dire “Cosa significa?”, anche se nel linguaggio parlato sono espressioni quasi identiche.
Il significato ha un valore oggettivo e condiviso: una casa è una casa e chiunque, se dico “casa”, capisce cosa intendo. Ma il senso della casa è un concetto più sfumato e personale. È legato all’esperienza, agli affetti, ai dolori, al radicamento o allo sradicamento. Ha un senso filosofico ed esistenziale..
Se ne deduce che il senso è soggettivo. È imprevedibile. Eppure l’abbiamo sempre più appaltato ad altri, alla società, ai media, ai politici. Pensiamo che loro sappiano dare un senso alle cose. Abbiamo smesso di cercarlo individualmente.
Dico in genere, io provo ancora a farlo. Ho capito per esempio che di ciò che, dall’esterno, è indicato come gravido di senso — ciò che devo assolutamente sapere — in genere non sopravvive alla notte. Domani ci sarà un nuovo senso, afferibile a tutt’altro ambito.
Il senso di oggi ha domani come scadenza.
Allora, non me ne si voglia, ma me ne frego di questo senso esogeno. Cerco quello endogeno, che è poi il senso del senso: quello interiore. Quello che collima o meno con la personale visione del senso delle cose.
Wittgenstein diceva che i limiti del linguaggio sono i limiti del nostro mondo. Oltre quei limiti c’è qualcosa che non può essere detto, solo mostrato. A quei confini si ferma il linguaggio e la realtà. Eppure ciò che non riesco a dire esiste comunque, solo che non so dirlo, e quindi per me non esiste, non ha senso.
La memoria in fondo è un linguaggio personale. È interpretabile dal solo possessore di quella memoria e spesso nemmeno da quello.
***
Onkalo è un deposito geologico situato a 500 metri di profondità nella roccia della penisola di Olkiluoto, in Finlandia. Lì si sta costruendo da anni il primo sito permanente per lo stoccaggio sicuro delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari.
L’obiettivo è tenerle isolate dal mondo per almeno 100.000 anni. La prospettiva è però quella di evitare che chi vi si avvicinerà in un futuro remoto — quando presumibilmente non esisterà più nessuna lingua parlata oggi — capisca che deve starne alla larga.
Il problema non è solo l’isolamento di materiale radioattivo che impiegherà tempi ancora più lunghi a decadere e diventare innocuo ma, prima ancora, è un problema di linguaggio.
Sappiamo che con buona approssimazione, in un tempo così distante nel futuro, non si parleranno le nostre lingue ma non si può nemmeno lontanamente prevedere quali nuove lingue si parleranno.
Hanno pensato di rendere l’intero ambiente in superficie estremamente inospitale oppure di mettervi all’ingresso un’iconografia molto comprensibile: un volto che urla, immagino ispirato dall’Urlo di Munch. Eppure, anche questa espressione facciale — per noi inequivocabile — avrà lo stesso significato fra 100.000 anni? Magari significherà felicità e spensieratezza, chissà. E tutti si infileranno nel deposito di scorie radioattive.
È un problema di linguaggio e dei suoi confini. La realtà, in altri termini, è condizionata dal linguaggio (che la esprime) e dal tempo (che la definisce, costringendola). Il significato ha un valore temporale, basti pensare a quante cose considerate inappropriate decenni fa oggi lo sono. E viceversa.
Con i linguaggi costruiamo universi di segni e sensi e con le memorie ne conserviamo le unità minime, pensando di capirle, un giorno.
Un giorno, in futuro. Nel flusso del tempo e nella variabilità del senso delle cose.
Che senso ha avuto quel film? Non lo so, e dicendo che non lo so non sto dicendo che non fosse importante. Dico solo che non l’ho capito. Ancora.