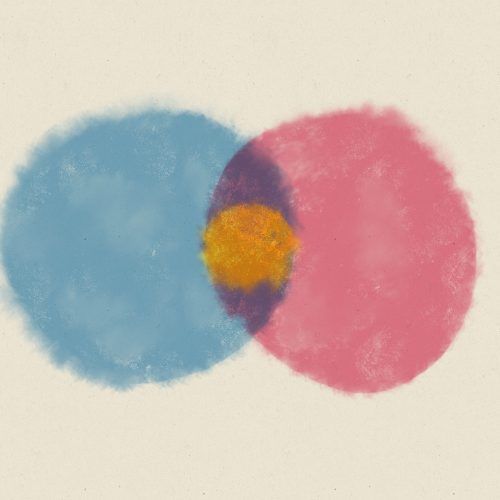Ho un caro amico che ogni tanto chiamo “selvaggio”. Lo definisco tale in un ambito specifico e con una accezione assolutamente positiva. L’ambito è quello professionale: lui è un architetto e l’essere selvaggio descrive il suo approccio all’architettura e alla professione. Il fatto che, per me, lui sia un selvaggio non ha una declinazione negativa, infatti lui non se la prende affatto quando lo chiamo così. Ci ride sopra e non lo fa con sufficienza né per gentilezza: lo fa perché, voglio pensarlo, anche lui si ritiene un selvaggio, oppure non pensa sia offensivo che io lo definisca così.
Per me il suo essere selvaggio ha più a che fare con l’energia che mette nell’atto creativo piuttosto che nell’esito. Quello che crea non è selvaggio nel senso di non educato e civile: lo è eccome. È l’atto della creazione a essere selvaggio.
Il suo modo di progettare – non solo l’architettura ma anche la vita – è energico e sfrontato. L’ho sempre guardato con ammirazione per la naturalezza con cui sembra ignorare che esistono regole e schemi e codici e linguaggi. Mi spiego meglio: conosce alla perfezione la statica e gli stili, la tecnologia e la tecnica ma il suo gesto creativo pare sempre poterne fare a meno. Mi piace pensare che sia una specie di araba fenice che ogni mattino si risveglia ed è rigenerata. Non ricorda il peso portato il giorno prima e gli anni precedenti: è l’esito di una partenogenesi notturna ed è pronta a volare.
Lui invece è pronto a progettare e teorizzare. È attratto dalla natura della sua terra, la Sardegna. Col tempo ho capito che non si trattava di un legame culturale o non solo: era più qualcosa di genetico, di primitivo: ce l’aveva dentro, la sua terra. Non so se io ho dentro la mia ma lui pare sempre portarla con sé, selvaggia pure lei e primitiva. E mi ripeto: uso questi termini con il desiderio di chi vorrebbe poterli applicare a sé stesso.
Forse narrare brevemente le nostre storie può far capire meglio di cosa parlo.
Lo incontrai per la prima volta all’università, in Erasmus. Al contrario di me, figlio di architetto e, almeno fino a quel punto, architetto per osmosi – dato che mi era stata somministrata da quando ho memoria – lui non ne sapeva niente. Aveva scelto quella facoltà perché era a Venezia, e Venezia lo attraeva. C’era da disegnare e poi era distante dalla sua isola. A sua detta, vi arrivò non sapendo neanche bene cosa si studiasse in quella facoltà. Di studi classici e vorace di vita, lo incontrai che era già qualche anno che la studiava. Io ero predestinato all’architettura: non ero stato in alcun modo consigliato di proseguire su quella strada ma non mi dispiaceva e non mi immaginavo a fare altro. Mi piaceva e mi piace tuttora, anche se alla fine la pratico poco o diversamente da come immaginavo.
Ma se io fossi un romanziere dovrei specificare che, in quel preciso momento della storia, ero io quello che doveva fare l’architetto e pure con un certo successo. Almeno nella mia giovane e inesperta testa.
Poi la vita prende altre strade, e tu ti ci adatti. Il fatto è che, al tempo, non immaginavo che cosa ne sarebbe stato di lui. Lo trovavo molto intelligente ed entusiasta e trascinante. Non avrei saputo dire se l’architettura gli interessasse davvero ma c’era qualcosa che mi legava a lui. Ora capisco, dopo qualche decennio, che lui è diventato quello che avevo pensato sarei stato io.
Di certo sto caricando questa vicenda di un significato eccessivo, ed è probabile che ce lo veda solo io ma la prima volta che lo incontrai (e ricordo benissimo dove e in quali circostanze – anche se non sono importanti nel racconto) le nostre strade si incrociarono e la mia deviò. È stupido forse pensare che accadde proprio allora ma più ci penso e più credo sia andata così. Nessuno dei due lo sapeva e nemmeno dipende né da me né da lui ma accadde, ora lo so. Allora capii – col senno di poi, e cioè me ne accorgo solo ora – che era lui quello destinato a diventare quello che pensavo sarei diventato io.
Io dovevo fare l’architetto inteso in senso classico: quello che progetta, quello che costruisce, quello che disegna le città.
Oggi è lui che lo fa e pure bene e con grande successo, e io sono architetto in modo diverso: studio le città da un altro punto di vista. Non le disegno ma le immagino, ne analizzo le dinamiche, le fotografo e ne scrivo. Sono diventato una cosa diversa e non me ne dispiace affatto. Per molti versi siamo diventati esattamente quelli che dovevamo diventare e se oggi sono qui a scrivere queste righe è perché ogni passo fatto sin a ora mi ha portato esattamente a scriverle.
Siamo i risultati precisi di scelte pregresse.
Oggi amo ancora l’architettura ma sono giunto a non amarne affatto il processo. Amo l’atto progettuale creativo ma molto meno quello esecutivo. Ci sono troppe variabili coinvolte, il processo è lungo in maniera straziante e fare l’architetto è difficile. Forse troppo per me. Decisamente troppo per me.
Quando me lo chiedono, rispondo che amo l’architettura ma molto meno farla. Amo vedere il risultato e fotografarlo e dargli valore (quando ne ha) ma non amo tutto ciò che ha portato a quel risultato, pur comprendendolo e rispettandolo. Anzi: proprio perché lo comprendo.
Ma parlavo di altro, cioè dell’essere selvaggio.
Lui lo è e ogni volta che ho avuto occasione di parlare con lui – ci vediamo qualche volta all’anno e parliamo a lungo, a volte per ore e ore – ho cercato di capire come riuscisse a essere ciò che è, cioè un selvaggio. La risposta è che non deve sforzarsi di esserlo, perché lo è e basta.
Lui canalizza una forza primitiva e le dà forma, ecco quello che fa. Lui sa dominare una certa energia brutale e la plasma con la ragione, le dà una forma economica, le conferisce un senso statico ed estetico. Quindi potrei dire che lui sa come imbrigliare certe forze creative telluriche, traducendole in oggetti umani e abitabili, estetici e sofisticati. Non vi è quasi traccia della natura selvaggia che li ha originati ma io so che c’è, perché lui è selvaggio.
Se lui è selvaggio, io sono civile, anche se non sono sicuro che sia il preciso opposto. Per civile intendo che sono educato, ma in una maniera particolare. Mi spiego meglio: avendo sempre vissuto l’architettura e il farla e il soffrirla pure, io iniziai a fare l’architetto essendo già vecchio. Avevo già visto quante e quali cose potevano andare storte. E spesso lo facevano, come se si divertissero a farlo.
Lui ne era ignaro, e per questo – oltre alle sue indubitabili, non trascurabili ed evidenti qualità professionali – la affrontava come chi la inventa ogni giorno, perché il carattere lo porta a essere riflessivo in altri ambiti ma non in quello creativo. Se una cosa si può pensare – voglio immaginare abbia sempre pensato – allora si può fare. Io invece pensavo che una cosa la si può pensare e quindi fare, a patto che si verifichino le condizioni a, b, c e pure 1, 2 e 3.
Forse mi autosabotavo, forse giustificavo le mie inadeguatezze dimostrando quanto fossero complicate le condizioni a margine, eppure lui mi dimostrava che si poteva fare.
Semplifico molto e non voglio sminuire le difficoltà che ha saputo superare. Merita tutto quello che ha e forse merita anche di più, e queste mie parole sono un modo indiretto per dirglielo.
Ormai otto anni fa ripresi a disegnare, o forse dovrei dire che iniziai, dato che non mi ero mai dedicato particolarmente a farlo.
Il disegno o la pittura sono strumenti espressivi incredibili per purezza e potenza: eliminano ogni filtro e permettono all’interno di diventare esterno. Si possono disegnare mostri o composizioni astratte, realtà immaginate o macchie di colore, si possono usare decine di tecniche diverse, si può canalizzare un flusso di coscienza purissimo e dargli una forma.
Ma parlavamo di me.

Disegnando ho avuto una rivelazione: ero selvaggio anche io, o almeno potevo attingere alla mia natura selvaggia. Delle centinaia di disegni fatti da allora so indicare con certezza quelli che sento più vicini alla mia essenza, e sono quelli più primitivi, più brutali, più imprecisi e forse elementari. Ma sono anche i più espressivi, o almeno per me lo sono.
Allora ho capito che l’essere selvaggi significa trovare il codice primario, il nostro kernel. Il linguaggio di base, quello che sapremmo parlare anche se dimenticassimo tutte le parole.
Dopo aver dimenticato il linguaggio umano possiamo disegnare. Possiamo disegnarci.
Ho disegnato sogni, ho disegnato immagini della memoria, ho disegnato quadri che avevo visto e dimenticato, ho disegnato l’interno della mia mente e i ricordi che conserva. Non ho avuto e non ho regole e mi esprimo con tecniche e linguaggi diversi.

Non riuscivo a esprimermi con l’architettura (perché non ne ero in grado, lo ammetto) ma ci riesco col disegno. E alla fine, mi dicevo, ho scoperto che i selvaggi parlano un linguaggio più puro perché originale e io volevo capire proprio quello. Volevo tirarlo fuori dalla mia testa e vedere che forma aveva.
Un giorno ho letto una frase di Wittgenstein. Diceva:
I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo.
È breve e apparentemente semplice. Per me significa che il linguaggio definisce ciò che si può conoscere, perché il linguaggio nomina, e ciò che non può essere nominato non può essere conosciuto. Eppure esiste, solo che non c’è modo di dirlo. Sta fuori dalla mia capacità di dirlo, è oltre certi confini.
Allora mi sono detto che il disegno serviva a quello: a superare i confini e lasciare che fossero altre le parole a uscire dalla mente e a prendere una forma: erano segni, colori, campiture.
Disegnando sono un selvaggio. O ritorno a esserlo, o ricordo di esserlo.
Mi piace essere selvaggio. Mi piace essere quello che sono, che non è quello che faccio né la posizione che occupo nella società. Essere selvaggi significa essere a prescindere da tutto, nonostante tutto. È un ritorno all’origine.
Non so se ci sono arrivato ma continuo ad andare verso quel punto. Capirò chi sono, o forse il senso non è questo: il senso è muoversi e procedere, il senso è il viaggio, non la destinazione.