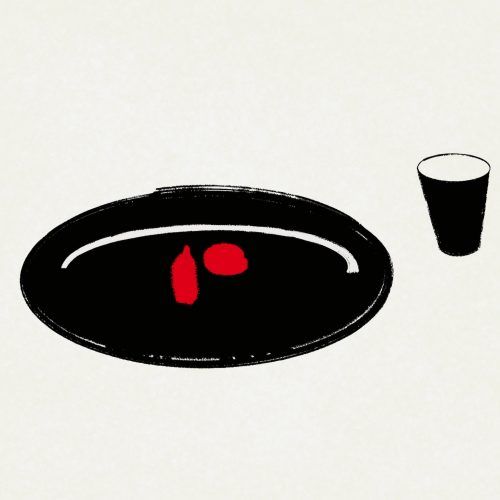Per parlare di magia dovrei innanzitutto definire che cosa intendo per magia. Potrei farlo anche per negazione, cioè per cosa non intendo essere magia. Vediamo un po’.
La magia non è quella dei maghi – per quanto possano esserne una rappresentazione efficace, anche se folcloristica – e non è nemmeno quella del paranormale o di ogni piega o accezione abbia preso l’inspiegabile. La magia non ha nemmeno una connotazione negativa come molte di queste sue manifestazioni hanno.
La magia è la forma dell’inspiegabile, è ciò che si vede attraverso gli squarci che si aprono nella realtà, se si ha la fortuna o la pazienza di guardare, senza passare oltre distrattamente.
Ciò che non è magico è quindi tutto ciò che è spiegabile, razionale e oggettivo. Donata Columbro in un interessantissimo articolo ne dà una definizione molto contemporanea, rintracciando il fascino che la contemporaneità ha per l’oggettività sia nell’evoluzione delle scienze che in un comodo modo per non assumersi responsabilità: quando si afferma che qualcosa è oggettivo e lo è per la scienza, allo stesso tempo ci si libera dalla necessità di avere un’opinione al riguardo, e ci si ritrae in un luogo sicuro, protetto dall’evidenza della realtà fenomenica. “È oggettivo” in questo senso significa che “è così, e lo è non perché l’abbia deciso io”. La responsabilità di decretare l’oggettività delle cose è delegata quindi alle macchine, siano esse gli strumenti dello scienziato o i computer o gli esiti di una ricerca.
L’oggettività più convincente si nutre di numeri e la matematica ha sommamente la reputazione della scienza più oggettiva e precisa: qualcosa che può essere rappresentato con i numeri non lascia alcuno spazio all’alone che lo circonda, a una certa aura di irrazionale che non c’entra del tutto con la cosa stessa, eppure che le appartiene. Non è un caso che la statistica abbia questo potere: è fatta di numeri e non può essere imprecisa, no?
In questo senso la macchina fotografica è l’esempio perfetto del meccanismo che, riproducendo il reale, cattura la sua verità, cioè la sua oggettività. O almeno: così è comunemente inteso, erroneamente però.
Questa concezione ha infatti creato più equivoci che altro perché la macchina fotografica non è affatto obiettiva e, rappresentando, opera per interposta persona del fotografo, una selezione degli elementi del reale. Li “compone” (e non è un caso che si parli di “composizione fotografica”) secondo ordini e gerarchie visive che non c’entrano con la realtà ma piuttosto con il significato che le si vuol dare, che è – guarda caso – soggettivo.
La macchina fotografica però è anche uno dei pochi strumenti che riesce a cogliere certe manifestazioni del magico, in particolare in una sua forma particolare, cioè il surreale. A volte la composizione di un fotogramma ha geometrie sghembe e rivela dettagli apparentemente irreali: pone gli oggetti ritratti in relazioni tra di loro incongruenti, perché nella realtà non esistono. Distorce il reale e ne restituisce un’immagine diversa.
La macchina fotografica costruisce un significato mentre la realtà è e basta, e non ha un significato.
L’apparecchio fotografico non definisce l’oggettività delle cose e quindi non è lo strumento che possa restituire un’immagine oggettiva: non è una macchina sufficiente.
Non è nemmeno quello che interessa, perché la magia non sta nell’oggettivo o di certo non ne è rivelata. La magia è un’allusione a un’altra dimensione e semmai la macchina fotografica permette di cogliere le pieghe del reale in cui si manifesta.
Gli squarci nella realtà – mi piace pensare e non sono nemmeno originale nel pensarlo – permettono di vedere in altre dimensioni. Non riesco a non credere che vi sia qualcosa del pensiero magico anche nelle intuizioni dei fisici che fondarono al fisica quantistica: l’idea di altri universi paralleli è un’elegante risposta a una suggestione che non credo sia venuta solo da una carenza del calcolo. Non deve essergli stata suggerita insomma solo da uno strumento razionale ma origina da qualche altra intuizione.
Un’interpretazione estesa della teoria della neurotrasduzione suggerisce altre interessanti letture del fenomeno magico. Questa teoria postula la modalità con cui il cervello potrebbe “trasdurre” o convertire l’informazione elettrochimica in stati di coscienza. In altre parole, cerca di spiegare come i processi fisici e chimici nel cervello (come i segnali neuronali) si trasformino in esperienze soggettive di coscienza. Il nostro cervello non sente gli odori né vede i colori ma interpreta i segnali che i sensi raccolgono rispetto a odori e colori. Il processo è simile a quello di un microfono che traduce in un segnale elettromagnetico qualcosa che ha natura diversa, come le onde sonore. Le onde non sono interpretabili dal cervello ma il segnale sì, ed è chiamato suono. Una realtà fenomenica e oggettiva può insomma diventare soggettiva e cosciente (stati di coscienza) attraverso questo portale/interfaccia.
Come può servire a interpretare segnali che provengono dalla realtà fenomenica, questa interfaccia potrebbe decodificare o almeno accorgersi di segnali che provengono da altre dimensioni. C’è molta magia in tutto ciò, se non altro perché l’esistenza di altre dimensioni non è stata dimostrata, almeno che io sappia. Ma queste mie parole sono ipotesi non scientifiche, sono suggestioni.
Queste altre dimensioni danno se non altro l’idea che vi sia dell’altro, che non sia tutto qui, che – a ben pensarci – è dove risiede il potere dell’arte, nelle sue forme specifiche di pittura, musica, cinema, scultura, danza, fotografia. L’idea insomma che l’arte usi l’apparenza reale (la sua presenza materiale) per dire altro o per alludere ad altri significati. Ad altri mondi, insomma.
L’artista quindi non esprime solo un’idea che conserva e sviluppa dentro di sé ma è un creatore di mondi, o è un trasduttore. Decodifica il segnale che arriva da altrove e gli dà una forma.
Non è detto che questo segnale sia comprensibile (spesso l’arte non lo è) ma l’importante è che venga captato.
A volte non serve nemmeno essere artisti (cioè creare) per accorgersene. La pareidolia, ossia il vedere immagini ove non ci sono (come vedere draghi nelle nuvole) è un processo visivo e mentale conosciuto e riconosciuto ma può anche essere interpretato come la percezione di un’altra realtà che si manifesta, sotto altre spoglie, celandosi. Si può obiettare che nella realtà quella è una nuvola e non un drago ed è spiegabile anche che il cervello sia ingannato dalla lettura di quell’immagine (il neurotrasduttore percepisce rumore e lo scambia per suono) ma è altrettanto vero che quella potrebbe essere un’altra realtà.
Concludo: la magia può essere una manifestazione dell’inconoscibile, dell’altra dimensione o anche di realtà non razionali, poco conta. Non deve essere spiegata perché non c’è né il linguaggio né la fisica per farlo, o almeno non ancora. L’importante è accettare che esista, pur all’interno del pensiero più positivista. Ammettere che non tutto può essere spiegato è una condizione molto scientifica, del resto. Forse la scienza specificherebbe che non tutto può essere spiegato per ora, ma poco conta. Nell’inspiegabile c’è il prossimo materiale di indagine della scienza.
Non stupisce che il pensiero magico sia ritenuto inferiore o visto con sospetto, eppure è spesso equivocato e paragonato alla religione o alle spiegazioni animistiche dell’origine del mondo.
La magia non è una spiegazione, è una presenza. In altre parole esiste ed è percepita.
Non spiega la creazione del mondo, non spiega la condizione umana, non è fondazione di alcuna religione. È una presenza a cui si può dare questo nome: magia.
In una bella intervista a David Perell, Ted Gioia lamenta che la dimensione magica sia quasi scomparsa dall’arte. Eppure, spiega, ha ispirato tantissima arte. Nel solo campo musicale moltissimi artisti hanno scritto o composto canzoni che gli sono apparse in sogno: Bob Dylan o il riff di Satisfaction, che apparve in sogno a Keith Richards che lo registrò di notte senza che ne avesse memoria il mattino dopo.
Secondo lo psicologo Robert Epstein, il sogno è la forma che assume il flusso di informazioni che proviene da altre dimensioni. Che non appartenga a questa realtà è dimostrato dal fatto che, aperti gli occhi, scompare. “È uno streaming”, dice, “ecco perché ce lo dimentichiamo al risveglio: non è memorizzato in nessun luogo del cervello”. E non è nemmeno memorizzabile, anche perché per Epstein la memoria non esiste, ma questo è davvero un altro, gigantesco, discorso. Magico, forse.