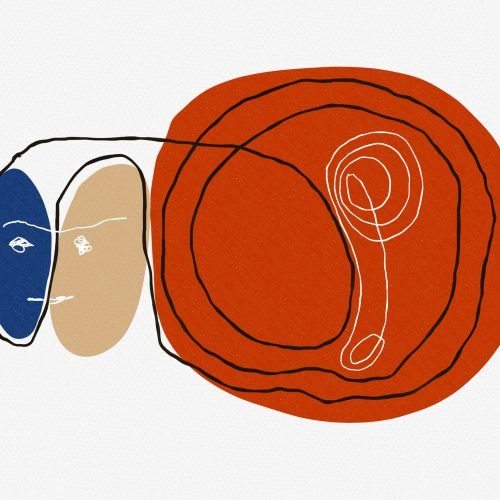Osservo una macchia che mi sono procurato mangiando un po’ di cioccolato mentre guardavo la TV. Farlo – quelle rare volte che lo faccio – sdraiato scompostamente, è uno dei tantissimi piaceri epicurei che mi procuro, oltre a quello di scrivere ogni settimana qui.
Della macchia mi accorgo solo dopo. Gli occhi sanno cogliere dettagli particolari: essendo l’unica parte del cervello esterna alla scatola cranica, funzionano come il cervello, o sono governati dalle stesse leggi. Una di queste è quella della conservazione dell’energia, o piuttosto dell’utilizzo razionale dell’energia: come il cervello (a cui appartengono), ne usano il minimo indispensabile, e il cervello è l’organo più energivoro che possediamo.
Dovendone insomma usare il giusto e non di più (il corpo è sempre ottimizzato come se vivessimo in un passato ancestrale in cui ogni energia è vitale alla nostra sopravvivenza – e per molti versi è ancora così), gli occhi notano la macchia e il cervello ne prende nota. La notano perché è l’unico dettaglio fuori posto. Prima (dell’assunzione della cioccolata) la maglietta aveva un tono uniforme e non attirava lo sguardo del cervello. Ogni tanto controllava che il tono di blu fosse sempre blu e che fosse uniformemente disposto sulla sua interezza. Poi, il rumore nella matrice, il dettaglio fuori posto: la macchia. Ora gli occhi non riescono a vedere altro e cadono sempre lì. Il cervello è furiosamente concentrato su quella macchia, a occhio e croce grande come un cinquecentesimo della maglietta.
Ci sono dettagli che attirano l’attenzione: diventano in breve ossessioni attorno a cui il cervello ruota vorticosamente. Pare non sapere pensare ad altro. “Forse non è una macchia, controlliamo”, e controlla. “È indiscutibilmente una macchia”. Allora pensa alla sua origine. Era già lì e l’ho notata solo ora o me la sono procurata in un preciso momento? Deve essere stata la cioccolata mangiata prima. Si calma ma solo per un po’, perché poi ritorna sulla macchia, dato che la sua origine ha placato solo per pochi secondi l’affanno di averla sempre in vista, esattamente nel campo visivo. Poteva essere scomoda da notare, sul gomito o sulla caviglia ma no, è lì. Ogni volta che guardo il cellulare o dove metto i piedi camminando il cervello la rileva. Ogni volta ne è sempre più irritato.
La macchia è il punctum, è l’oggetto di attenzione maniacale, è un miserabile dettaglio attorno a cui tutto inizia a gravitare.
La macchia mi ha fatto pensare a noi, a me stesso, nonché alla potenza dei particolari. Non tutti li notano ma alcuni notano solo quelli. Io sono un buon osservatore e credo che i dettagli descrivano meglio dell’immagine complessiva una persona, un luogo, un libro, una musica. È una forma di ossessione – ne convengo – ma sono i dettagli a salvarti, sono i dettagli a fare la differenza.
Il cervello, si diceva, rileva quelli perché sono i dettagli a fornirgli informazioni vitali. I nostri antenati hanno imparato a notarli in un mondo uniforme e apparentemente noioso: una prateria, un deserto, una ombrosa foresta. Ove tutto appare omogeneo, il pericolo è rappresentato dal glitch: la fronda che si sposta, un rapido movimento di un’ombra, un bagliore improvviso. Tutto ciò che emerge dal placido consueto può essere motivo di allarme.
Oggi i dettagli raramente alludono a un allarme: lo fanno ancora ma statisticamente sono rilevanti perché fanno breccia nell’uniformità del reale. Ecco perché noto la macchia, ecco perché osservo la barba poco curata o il rossetto sbavato. Il cervello lavora in economia, e quindi assume che se lo sfondo della visione non cambia, allora può considerarlo come statico, rilevandone un’immagine e conservandola mentalmente per operare un confronto: se niente si muove nella scena della vita, allora niente cambia, non vi sono pericoli o eventi da rilevare e quindi può destinare meno o nessuna energia all’osservazione specifica.
Che meraviglioso organo il cervello: elabora solo le informazioni essenziali, anche perché non potrebbe processare in continuazione ogni elemento del reale che gli occhi (o le orecchie o il tatto o l’olfatto) portano alla sua attenzione. Non ha sufficiente potenza di calcolo e non gli resterebbe nessuna energia per dedicarsi alla produzione del pensiero, cioè alle speculazioni sull’origine della macchia e sulle conseguenze che la sua esistenza sul tessuto della maglietta potrebbero portare.
Al centro del cervello c’è l’Io: il cervello opera per la sua conservazione, cioè, in altri termine, per la conservazione di se stesso.
A tal proposito, lessi una volta questa frase:
Pensavo che il cervello fosse l’organo più meraviglioso del mio corpo. Poi ho capito chi me lo stava dicendo.
- Emo Philips
Potremmo anche operare un’identità fra cervello e Io: sono la stessa cosa? Il cervello è un organo, l’Io è un’entità più sfuggente e non è un organo. Alberga in quell’organo e per i più positivisti è il risultato di processi biochimici che chiamiamo, per semplicità, “coscienza”. La sto facendo molto, troppo semplice ma il punto è un altro.
Ci arrivo lateralmente, citando David Foster Wallace, in quel discorso celeberrimo che fece agli studenti del Kenyon College. Quello dell’acqua e dei pesci. È lungo e articolato (lungo, per Wallace, è un concetto elastico) ma normalmente, o proprio per la sua lunghezza, viene citato solo nelle sue prime righe, quelle, appunto, del vecchio pesce che chiede ai due giovani pesci “Com’è l’acqua?”. Un inizio perfetto, non c’è che dire.
Ma quel discorso dice molte altre cose e oggi l’ho letto tutto, arrivando a un punto che mi ha fatto riflettere sulla macchia e sull’Io e sull’umanità. Dice Wallace:
Tutto nella mia esperienza immediata sostiene la mia profonda convinzione di essere il centro assoluto dell’universo; la persona più reale, vivida e importante in assoluto. Raramente pensiamo a questo tipo di egocentrismo naturale e basilare perché è socialmente ripugnante. Ma è così per quasi tutti noi. È la nostra impostazione predefinita, programmata nel nostro sistema alla nascita. Pensateci: non esiste un’esperienza che abbiate mai avuto in cui non siate stati il centro assoluto. Il mondo, come lo vivete, è davanti a VOI o dietro di VOI, a sinistra o a destra di VOI, sulla TUA TV o sul TUO monitor.
Il tutto diventa ancora più interessante quando il fulcro si sposta su quello che definirei il pensiero automatico: tutto ciò che facciamo perché così si fa, in assenza di giudizio ed elaborazione. Perché consuma meno energia, direi.
È inevitabile essere giudici di ciò che vediamo: come si diceva, ha a che fare con la propria sopravvivenza, è normale che la misura di tutto sia l’Io.
Altrove lessi (o sentii) che il comando base dell’essere umano è sopravvivere. Ogni ulteriore e più raffinata istruzione può essere ricondotta a quella unica: fai ogni cosa che garantisca la sopravvivenza dell’essere che ti ospita (ossia che ospita l’Io, la mente e il cervello, se li si vuole considerare come entità separate).
L’acqua è insomma il reale, e al reale non pensiamo affatto: lo osserviamo, forse, ma sempre filtrandolo con la nostra esperienza.
Quello che trovavo più interessante, e quello attorno a cui ho scritto altrove, è che la macchia è la perturbazione del campo, è il dettaglio fuori posto, è quello che rende reale il reale, perché lo rende notevole, cioè degno di nota.
La macchia è quello che ci fa accorgere che nel reale qualcosa vibra, che il reale cambia, che c’è perturbazione.
Mentre meditavo, una sera ho provato a pensato a un concetto e al suo opposto, contemporaneamente. Mi sono stupito a constatare che, almeno per concetti semplici, non è così difficile. Si può pensare al caldo e al freddo nello stesso istante. Al bianco e al nero, al bene e al male (sotto forma di qualche immagine esemplificativa, magari). Tantissimi concetti possono essere pensati nella loro essenza positiva e anche in quella negativa, simultaneamente. Non è così difficile, davvero.
Allora ho constatato un’altra cosa: che in realtà, pensando a due concetti opposti ne pensiamo anche un terzo, che è quello che li contiene. Ci sono insomma un concetto, il suo opposto e anche l’idea di questi due concetti opposti, che altrimenti non potrebbero stare in relazione l’uno con l’altro. Probabilmente esiste pure l’opposto del concetto che li lega, ma non ce l’ho fatta ad arrivare a quattro concetti contemporanei, o almeno non ancora.
Con ciò non voglio dire di essere intelligente né un master nella meditazione. Non sono nessuna delle due cose. Dico solo che esiste una forma di pensiero più complessa che riesce ad allontanare dal pensiero costante e ossessivo di se stessi. Che, ricordo, è assolutamente lecito e naturale, oltre che esistenziale.
L’idea insomma che si possa superare, anche solo temporaneamente, lo stato di ego-centratura è molto gratificante. È un po’ come accedere a una funzione complessa del proprio cervello che riserva interessanti sviluppi.
Tipo che esistono concetti opposti (e questo lo sa chiunque) ma che possono essere pensati dalla stessa persona. Si pensa comunemente che questo sia moralmente ripugnante ma, ciò facendo, si pone sullo stesso piano intenzione e azione, pensiero e atto. Pensare qualcosa non significa farla, avere un’idea non comporta il realizzarla (altrimenti saremmo i geni della lampada).
Quindi non penso che poter giocare nella mente con concetti opposti abbia un’analogia nel mondo reale: non si può essere se stessi e il contrario di se stessi contemporaneamente. Sapere che però questa tensione può essere pacifica e concepibile nel cervello è confortante e soprattutto tiene occupato il cervello e gli evita di pensare all’Io. Gli fa capire che non esiste una lettura univoca della realtà, ma soprattutto gli fa capire che una cosa e il suo opposto hanno eguale diritto di esistere, e l’esistenza dell’uno non nega quella dell’altro. Anzi: la sostanzia e la rende possibile.
Ripenso alla macchia e la penso sempre più come una possibile rappresentazione del disturbo al tessuto del reale, più che a quello della maglietta. Un disturbo che ha rivelato dettagli che il cervello ha colto, elaborato e riferito ad altro.
Non so se Wallace avesse questo in mente, forse la sua orazione era piuttosto un’esortazione al pensiero libero. Quello che ho inteso è che il monito di questa storiella, se storiella può essere definita, è di far attenzione: indicando, riferendosi e condannando qualcosa, bisogna pensare al suo dritto e al suo rovescio, o almeno al fatto che la realtà è anche il suo opposto, che le persone contengono moltitudini e che ciò che condanniamo negli altri è, molto probabilmente, ciò che non amiamo di noi stessi. È uno specchio che non vogliamo vedere.
Mi guardo allo specchio e noto quella macchia: si vede, eccome, non c’è niente da fare.