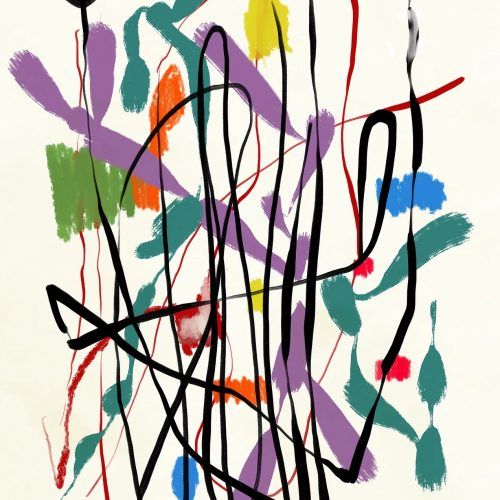Giorni fa ho avuto una conversazione telefonica. A volte accadono eventi che, inaspettatamente, rivelano aspetti nascosti o ne mettono altri in evidenza. La conversazione era professionale e fin qui, niente di particolare. L’aspetto singolare era che fino a un punto abbastanza avanzato del dialogo non riuscivo a capire come il mio interlocutore si rivolgesse a me. Intendo: me ne sta parlando in quanto architetto, fotografo, illustratore, autore o cosa? Poi la questione si è chiarita e non è strano che non lo fosse fino a quel punto dato che l’argomento si prestava a essere affrontato da diversi punti di vista e con diverse professionalità.
Il punto però non è l’argomento in sé, quanto che non riuscissi a capire a quale Martino si rivolgesse. Non era un suo problema e non è nemmeno un problema, a dirla tutta. È legato piuttosto al fatto che spesso le persone non hanno chiaro cosa faccio: magari mi conoscono per un aspetto e non per gli altri, magari sanno tutto quello che faccio e quindi sono ancora più confusi e allora – avendo da risolvere qualcosa, pensano a chi fa solo quello e non altre cinque cose – si rivolgono a chi fa solo quella cosa. È tutto comprensibile e non è nemmeno l’oggetto di queste riflessioni, che potrebbero tradursi nella mia personale difficoltà a essere inquadrato in una professione specifica, restando quindi – come è giusto che sia – un mio problema.
Infatti non mi interessa parlarne. Quello che mi interessa è altro, e cioè: siamo le cose che facciamo, cioè il nostro lavoro ci definisce, almeno in seno alla società. Quindi è un problema di identità, e non è una questione marginale.
La questione dell’identità mi si è presentata diverse volte negli stessi giorni, in modo casuale. In modo casuale? In fondo la mente collega punti che magari si presentano casualmente ma ai quali cerca di dare un senso. Insomma: mi accadevano cose a cui davo una lettura inquadrata in un certo schema, cioè quello dell’identità.
Chi sei, alla fine?
Detta in questi termini, non una questione marginale. Non è “Ti piace di più la margherita o la pizza e funghi?” ma proprio “Chi sei e cosa sei?”
Forse bisognerebbe partire proprio dalla seconda parte della domanda, e cioè “Cosa sei?”.
La prima parte è esistenziale (qual è la tua essenza?) e la seconda è funzionale (cosa fai per la società?). Vista dal punto di vista funzionale, la questione dell’identità si risolve nella collocazione all’interno del grande schema delle funzioni sociali: essere medici, operai, architetti, intellettuali, meccanici, disoccupati.
Ecco: disoccupati, per esempio. Non è casuale che esista una categoria per chi non lavora, cioè per chi non assolve una funzione all’interno della società, o ne svolge una neutra (non contribuisce) o negativa (è a carico del sistema). Viviamo in un gigantesco formicaio e, come noto, ogni formica ha una funzione. Come in un alveare, del resto, e non è un caso che siano due strutture spesso associate per affinità a quella umana per complessità organizzativa. Un’altra cosa che mi è capitato di leggere negli ultimi giorni è che la specie umana è l’unica che ha saputo organizzarsi in forma complessa, gerarchica, articolata. Come le api o le formiche, ma con le dovute differenze.
Insomma, qualsiasi aggregazione di un numero notevole di simili porta alla costruzione di strutture gerarchiche, anche se magari le api “operaie” le chiamiamo solo noi così, tanto per capirci. Loro non si chiamano o si chiamano Clara e Paolo, vai tu a sapere.
Il problema, dicevo, è che una struttura così complessa è tanto più efficiente quanto più sono definite le funzioni delle sue parti, quindi quanto più ognuno sa cosa deve fare e lo fa decentemente bene. È ancora una questione di collocazione, cioè di dove stare nel grande schema delle cose (umane).
Un altro assioma è che, più complessa è la società, più devono essere specifiche le sue parti, specie in ambiti molto vasti come, per esempio, la medicina. Ormai non esiste più l’oncologo generico: esiste quello pediatrico, quello geriatrico e quello in mezzo, che non so come si chiama. Non è un vezzo ed è giusto che sia così perché ogni età e ogni genere hanno particolarità che meritano ed esigono attenzioni particolari che una professionalità generica non può assolvere. L’opposto di questo assioma (controassioma? Boh) è che ogni multiprofessionalità non ha una collocazione ben precisa: chi fa tante cose non ne fa nessuna in particolare e di certo non in maniera eccellente, Jake of all trades, quella roba lì.
Si capirà che è un cruccio esistenziale per me, e poi arrivano certe telefonate che ti fanno capire che alle altre persone – ripeto: comprensibilmente – non è chiaro esattamente quello che fai. A volte vorrei essere quello che nella linea di assemblaggio della Porsche (non scelta a caso) si occupa solo di stringere certe viti e lo deve fare con precisione nanomillimetrica e non deve occuparsi di come funzionano i fari o di quale lega viene usata per il telaio. Chissenefrega, io stringo solo viti.
Non mi è evidentemente capitato di stringere solo viti perché non amo la profondità, cioè non amo affrontare un argomento e capirlo sino alla fine. Che enorme ammissione di superficialità, si dirà e in effetti è così.
Sulla superficie posso spostarmi (cambiare collocazione), nella profondità posso solo scendere, escludendo il resto.
Alla fine è il problema di Matrix e della pillola blu o rossa: quale scegli?
Tutto quanto precede avrebbe senso in una logica binaria, cioè: “sei questo o sei quello, non puoi essere entrambi.” E ci sta, posso capirlo. La logica binaria è facilmente comprensibile, specie perché focalizza l’attenzione su un solo aspetto dei due, rispetto a qualsiasi cosa.
La logica binaria è concettualmente potente perché è elementare e non è un caso che sia così spesso adottata, basti pensare alla politica o al dibattito pubblico o praticamente a qualsiasi aspetto della vita, tipo la preferenza per la Coca Cola o la Pepsi (fortunatamente in questo caso esiste l’opzione “Nessuna delle due”).
Però è anche molto limitata e limitante, perché non tollera le sfumature e azzera la complessità. In quanto esseri umani non siamo solo bianchi o neri ma conteniamo sfumature e declinazioni, particolarità e peculiarità. La classificazione organizza il pensiero e colloca, ma fa strazio di ogni categoria o qualità che non sia collocabile.
Dico tutto questo non per giustificare la mia difficile collocazione ma per capirla un po’ meglio e basta. Per farci pace.
Cercando poi fra i miei appunti per scrivere di essere e identità, ho ritrovato qualcosa che avevo annotato da una conversazione con un amico, cioè il concetto di sonder. Deriva dal suo libro che ha un titolo stupendo: “The Dictionary of Obscure Sorrows”, tradotto bene in “Il dizionario delle tristezze senza nome”, in cui Koenig crea termini per descrivere emozioni complesse e difficili da esprimere. Sonder è il momento di consapevolezza in cui si capisce che ogni persona incontrata, anche solo fugacemente, ha una vita complessa e piena quanto la nostra, fatta di esperienze, emozioni, pensieri e relazioni.
Chiunque si incontri sta vivendo una vita di cui è protagonista, esattamente come capita a te, che pensi che nella tua vita gli altri siano comparse più o meno importanti mentre tu sei il vero protagonista. E le vite sono tutte così ma avere una percezione della tua e delle altre e delle similitudini e del fatto che si è protagonisti della propria ma anche attori o insignificanti comparse di quelle altrui è la condizione del sonder. O della sonder, chissà.
È chiaramente un concetto basato sulla ricerca di empatia e sulla volontà di comprendere gli altri immedesimandovici, assumendo altri punti di vista.
Direi che è appropriato in questa argomentazione, poiché le professioni e il lavoro ci collocano, dicevamo, e forniscono anche un’immediata rappresentazione della nostra identità. Così potente che, almeno nella società, finisce a essere tutto. “Quello è medico, quella è insegnante, quell’altra è ingegnere”, cose così.
Quindi il mio cruccio sul come mi colloco non è tanto una questione funzionale, per tornare all’inizio, ma esistenziale: significa non essere interpretati e collocati precisamente, cioè essere sempre un po’ fuori posto.
Lo si è dal punto di vista sociale, ma in quella dimensioni viviamo, quindi con quella dobbiamo misurarci.
Ovviamente se medito o dormo o guardo un albero e rifletto sulle diramazioni delle sue radici non penso alla società o a come vi si collocano gli individui: penso ad altro, e mi illudo che sia quello che davvero conta (le radici degli alberi, per quanto scontate siano, sono davvero importanti).
Alla fine della telefonata si è chiarito in quale veste volesse parlare con me, cioè come mi vedeva. Fortunatamente andavo bene anche in quella, ed era anche l’unica che lui conoscesse bene o meglio delle altre.
Però il pensiero dell’identità mi ha accompagnato sin qui, e lo farà molto oltre. Credo perché è legato al concetto di essere, di cui il lavoro risolve solo una piccola parte: essere nel senso di avere una funzione. Stabilendolo ci si colloca in un qualche spazio della società e lo si arreda, cercando di renderlo confortevole o almeno tollerabile.
Poi ci si siede davanti al camino acceso e una domanda ci coglie impreparati:
Ma io sono davvero le cose qui attorno? Questo ambiente mi definisce? Chi sono davvero io?
La fiamma brucia e non ha una risposta, se non “Io sono il fuoco, e so di esserlo”.