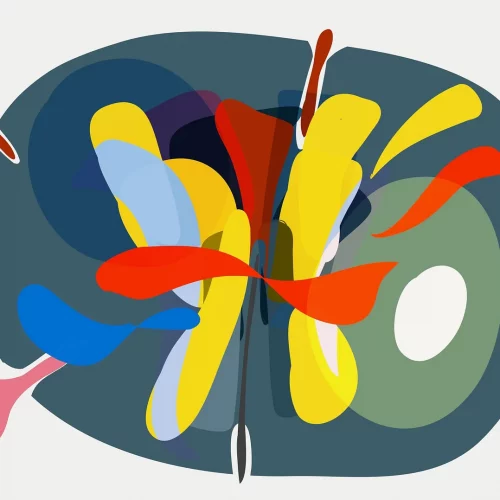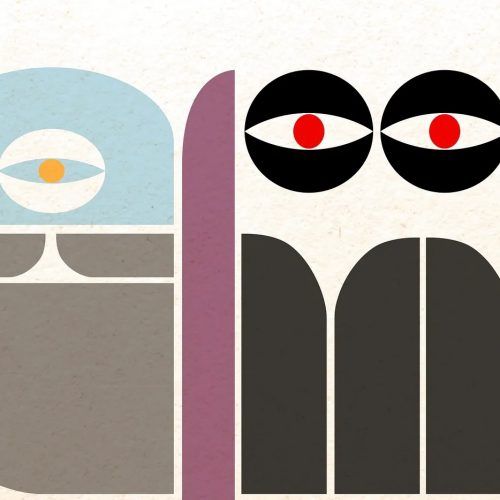Dal giorno in cui lessi che la sfortuna è solo il nome che diamo a una particolare serie di eventi casuali e non correlati, ho smesso di prenderla come un fatto personale. Non sarei mai più stato così stupido da pensare che fosse riferita a me. Pensare che l’universo congiuri contro di te è l’apice dell’egocentrismo: l’universo se ne fotte di te.
Iniziare a pensarsi come irrilevanti è inconcepibile per moltissimi, anche perché l’illusione della rilevanza coincide con quella di avere un senso, che un po’ tutto abbia un senso (che è poi un modo neanche troppo intelligente di celare il reale postulato, ossia che tutto abbia un senso per l’individuo, e che tutti gli altri si strozzino, o si accodino a dare un senso alla mia vita).
La definirei una versione funzionalista dell’esistenza: tutto ha senso in funzione dell’individuo. Che presunzione indecorosa. Non me ne sarei mai macchiato, o almeno non più. Finii l’adolescenza – se mai ne sono uscito – e non pensai più alla sfortuna.
È naturale che la sfortuna abbia un ruolo così centrale all’inizio della nostra vita, specie nella fase di formazione del carattere: le difficoltà nel riuscire a definirlo devono essere giustificate dalle forze avverse del destino (non ce la faccio perché il destino mi è contro) mentre la fortuna è la forma del merito, o il negativo della fatica fatta a sconfiggere gli attacchi della sfortuna.
Fortuna e merito si tengono insieme, nel senso che l’espressione dei talenti non può che condurre alla realizzazione di una vita ricca e piena, di cui la fortuna è il premio. Del resto la fortuna sorride a quelli che ci provano, cioè quelli che hanno il talento per provarci.
Invecchiando poi ti rendi conto che le variabili sono talmente tante e che il talento è solo una di queste. Più tardi – molti decenni dopo quell’adolescenza – annotavo “Crede di meritarsi quello che ha e ha avuto, non lo sfiora il pensiero che si tratti anche di fortuna’ e penso che in fondo nemmeno io dei miei talenti penso che siano un colpo di fortuna. Ce li ho come se li meritassi ma non merito niente, è capitato e basta.”
Non ho idea di chi menzionassi in quella prima parte – non escluderei di aver parlato di me in terza persona, e me ne vergognerei di conseguenza – ma nella seconda recupero, notando che se ho dei talenti sono capitati e basta e non sono un dono del destino né un premio per qualche merito. Semmai i talenti possono fruttare dei meriti, dato che non esiste merito che non derivi da un’espressione individuale di qualche capacità (altrimenti sarebbe solo un caso di fortuna, quello sì, ossia di qualcosa che capita indipendentemente dalla capacità individuale).
Come sempre ritorno all’etimologia e scopro che merito significa guadagno. È insomma un riconoscimento per un’azione o una capacità che ha impiegato tempo e sforzi per esprimersi. Quindi il merito richiede tempo per maturare, anzi il tempo ne è proprio la componente che lo sostanzia, così come una partita di calcio deve essere giocata per tutto il suo tempo regolamentare e non può essere risolta quando una delle due squadre segna il primo gol. Meritarsi qualcosa sottintende il tempo che si è speso a fare quella cosa, e il riconoscimento è quello del risultato e anche del tempo impiegato a ottenerlo.
La sfortuna e la fortuna non impiegano tempo: sono saette che inceneriscono o fanno brillare, che mettono in ombra o in luce ma accadono improvvisamente, non si costruiscono nel tempo.
Questa compressione del tempo, questa sua assenza, rende di per sé la fortuna e la sfortuna come aliene: non sono umane perché non richiedono tempo, invece l’umanità ne è immersa, e a volte ci affoga.
Non essendo umane, ne sfuggono al controllo, quindi originano da qualche parte. Eppure, vedevamo all’inizio, la sfortuna e la fortuna non sono che un nome che si dà a una peculiare concatenazione di eventi casuali che ci appaiono come tali, cioè come appartenenti a un disegno minuzioso. E invece.
Fortuna e sfortuna sono il trasferimento di responsabilità da noi stessi al cosmo, sono una mancata assunzione di dominio sulla realtà. Sono una resa insomma, quantomeno l’affidarvisi.
Quando si fa affidamento all’inaffidabile manifestarsi della fortuna – o si scongiura il simmetrico della sfortuna – si abdica al proprio potere di fare e creare. Anche il proprio destino.
Allo stesso tempo però caso e fortuna non sono la stessa cosa e il dominio (o il tentativo di dominarlo o di gestirlo, almeno) è espressione della volontà individuale, mentre la fortuna è una valutazione, come si vedeva all’’inizio, di una concatenazione di eventi casuali.
Il caso è l’evento, la fortuna e la sfortuna ne sono l’interpretazione.
A un certo punto della mia vita non ho più avuto voglia di affidarmi alla fortuna o di temere la sfortuna. Trasferirvi potere significava perderlo da qualche altra parte, e soprattutto coincideva con l’affidarsi a servi imprevedibili e umorali. Meglio agire in modo da essere responsabili delle proprie azioni e dei propri fallimenti, senza votarsi a divinità pagane o meno e dispensatrici di fortuna.
Liberarmi dalla sfortuna – cioè dalla lettura sfortunata dei casi che mi accadevano – ha anche liberato notevoli energie per elaborare qualche soluzione esistenziale più realistica, cioè per cercare di giocare decentemente con le carte che il caso mi serviva, invece di maledire il banco se me ne dava di pessime o di sentirmene debitore se me ne serviva di buone.
Non credere alla fortuna e alla sfortuna è un affronto: significa non credere a Dio, cioè non credere che il caso abbia un senso e che il libero arbitrio sia un’illusione gentilmente dispensata da una bizzosa divinità, per poi servirci da dietro la schiena la stilettata di una qualche sfortuna.
Fortuna e sfortuna sono poi egoisticamente individuali, cioè sono interpretate come tali: ciò che è sfortuna per uno è una fortuna per un altro, e l’interpretazione stessa del caso è una funzione culturale piuttosto che oggettiva: gli effetti di una calamità naturale – per quanto siano oggettivamente negativi – possono essere trasformati positivamente o negativamente, a seconda di quale lettura se ne dà. Di una catastrofe naturale si può vedere solo la distruzione che produce ma anche rincuorarsi constatando la solidarietà spontanea che può far nascere fra gli esseri umani.
Il fatto è che la realtà è complessa e l’interpretazione individuale ne è solo una possibile lettura. Fortuna e sfortuna mi sembrano più che altro i residui del rapporto che abbiamo avuto con Dio, o che ancora abbiamo. Non è un caso che le sfortune siano – per chi crede – delle prove cui Dio li sottopone e le fortune dei premi per i comportamenti probi.
Chi non crede – o almeno io, che non credo – smette di credere anche alla fortuna e alla sfortuna. Non è semplice perché maledire il destino costa meno fatica che ripercorrere i propri passi a ritroso e capire dove si è sbagliata strada. In compenso ripaga con la constatazione che molto dipende da sé stessi, altrettanto dalle casuali interazioni che intratteniamo col prossimo e infine dal caso. Al quale siamo indifferenti, e che ci concede solo l’arbitrio di giocare le carte che ci serve. Che a volte consideriamo una mano fortunata, o una maledettamente sfortunata. E alla fine, è solo una mano di carte.