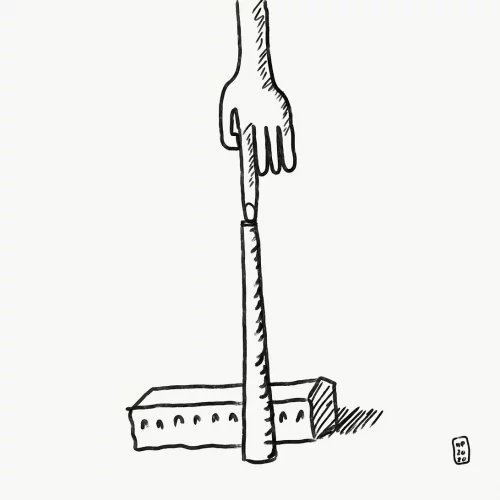Un libro provocatorio come “Bianco” di un provocatore come Bret Easton Ellis non poteva che suscitare reazioni estreme. C’è chi lo considera un testo importante e chi lo bolla come un insieme di farneticazioni di un bravissimo scrittore ormai disallineato coi tempi correnti, livoroso e acido.
La bontà di un libro, il suo valore insomma, può anche essere letta attraverso le reazioni che suscita e se le critiche sono state così veementi significa che qualcosa di lacerante BEE deve averlo toccato.
Quello che trovo più interessante è invece il ruolo che lui ha assunto scrivendolo.Si tratta del suo primo libro di non-fiction e si tratta di un saggio composto di parti diverse che trovano un minimo comune denominatore nel suo attento spirito critico e nella lettura della società contemporanea. Che BEE parli di critica cinematografica (arte nella quale lui è sommo, e non lo conoscevo da questo punto di vista) o di social network o di politica, la strada che percorre gira sempre attorno all’uomo contemporaneo e a come si è evoluto plasmando la società ed essendone a sua volta plasmato.
“Bianco” è autobiografico in diversi passaggi: quando parla della genesi dei suoi libri, quando racconta le sue esperienze come autore cinematografico o televisivo, quando si rilassa svelando il suo lato più viveur alle feste a base di alcol e cocaina. C’è però un patto evidente con il lettore: la sincerità con cui lui si svela. Può essere un artificio, potrebbe non essere fondata ma BEE sembra invece molto serio, disincantato e indifferente a dimostrarsi debole e fallibile. È un patto, appunto: ascolta le parole di chi non ha timore di dimostrarsi una persona reale, che sbaglia, che fallisce, che inciampa, che va avanti.
È altrettanto interessante osservare come le critiche al libro si siano presto spostate dal contenuto all’autore, come a dire che può esserci argomento di discussione nelle sue tesi ma parliamo di BEE e di come ha vissuto negli ultimi dieci anni: senza scrivere un romanzo che sia uno — anzi abbandonando sostanzialmente la scrittura, almeno quel tipo di scrittura — twittando ubriaco di notte, difendendo Trump e attaccando i difensori d’ufficio della libertà, ossia i democratici americani.
Basterebbe invece leggerlo per capire che la sua figura non è più quella dello scrittore ma piuttosto dell’intellettuale e pure della specie più rara: quello poco inquadrabile, né liberal né repubblicano, né tantomeno polemico per partito preso se non quello di se stesso, della sua visione del mondo.
BEE ha la capacità di partire dall’argomento più vacuo ed effimero come i social e il loro chiacchiericcio e non lasciarsene invischiare, librandosi invece molto più in alto per capire i meccanismi che governano i rapporti fra le persone e quindi fra le parti della società fino ad arrivare a una riflessione molto profonda e articolata sulla forma che ha assunto il vivere pubblico. L’immagine delle persone, l’ossessione per la reputazione, la preponderanza che nelle vite individuali ha assunto la dimensione pubblica, fino a portarle a impersonare sempre qualcuno di diverso da sé stessi, più adatto e accettabile dal consesso umano. Chi ha il coraggio di essere fedele alla propria identità, senza cedere alla normalizzazione pur di essere incluso nella società è la persona libera. Ma chi è libero oggi è anche allontanato dal gruppo perché non condivide o rispetta le regole.
BEE si dice poco interessato alla politica. Preferisce parlare di cinema o letteratura eppure alla politica si riconduce inevitabilmente ogni discorso sull’individuo nella società. C’è una sua frase — gliel’ho sentita dire durante un’intervista, forse non c’è nel libro o c’è in forma più estesa — che recita pressapoco così:
L’estetica ha ceduto il passo all’ideologia
In un’era post-crollo del muro di Berlino, in un tempo in cui la storia — si diceva — era finita con la vittoria del consumismo e del capitalismo sul comunismo, in un’era infine in cui le ideologie avevano fallito ed erano state sconfitte, dopo tutto ciò si è tornati a parlare di ideologie. Anzi: le ideologie sono tornate ancora più potenti e prepotenti di prima. Non sono più il capitalismo e il comunismo ma sono state il tecnicismo e ora sono il femminismo, il sovranismo, l’egualitarismo e altri vari -ismi.
Se però le due ideologie secolari del ‘900 avevano campi d’azione definiti nella politica e nella società (ma sempre a livello politico), le ideologie moderne sono molto più capillari e pervasive: invadono il discorso sociale, condizionano i rapporti fra le persone, modificano la visione del mondo annullando l’individuo a favore di una divinità impersonale che promette l’accesso alla società, il successo, la “likeabilità” o anche, più spesso e più semplicemente, la sopravvivenza nell’accettazione di se stessi presso gli altri.
Per sopravvivere, l’individuo deve essere certificato dagli altri, a colpi di like e cuori e approvazioni. Che hanno come contraltare la disapprovazione, la derisione e l’odio. Cosa c’è alla base di un meccanismo così perverso che, nell’ispirazione, dovrebbe portare all’inclusione ma che ottiene l’effetto opposto? La società contemporanea non include perché è giusto di per sé ma perché è buono, o supposto tale.
L’altra potente ideologia contro cui BEE si scaglia è, neanche a dirlo, quella del politically correct. quel coacervo di cose e atteggiamenti che è meglio avere o non avere, quella visione ispirata al rifiuto di tutto ciò che esclude per includere il più possibile ma arrivando a negare la verità e la libera espressione dell’individuo. Nel P.C. non c’è spazio per l’opinione perché la libertà insita nella sua espressione nega la natura stessa del discorso inclusivo. Il paradosso è quindi che per essere inclusi bisogna cedere la propria libertà espressiva.
A ben vedere viviamo in una società che si è strutturata secondo modalità così deliranti da arrivare a negare i propri presupposti: l’intera generazione dei millenials educata a pensare di poter avere tutto dalla vita perché è unica, stupenda, irripetibila, necessaria scopre suo malgrado che c’è una condizione: a patto di non esprimere opinioni, e facendo in modo di essere sempre gradevoli, educati, moderati. Come si può essere unici e preziosi se il prezzo da pagare per essere accettati è rinunciare proprio a essere unici, uniformandosi al pensiero corrente e corretto? Non c’è altra via oltre la rigida violenza dell’ideologia: o ci si uniforma o si è fuori.
L’ideologia ha cambiato forma ma non sostanza: non è più politica ma è sociale e conserva la sua capacità di essere oltre e contro l’individualità. Nessuna variazione e nessuna vibrazione sono concepite dall’ideologia, che si deve realizzare in accordo con un piano che protegge le idee e non le persone.
Scendendo nel consesso umano, vagando per le reti umane reali o virtuali — online o offline — il discorso ideologico incespica e dimostra i suoi limiti: funziona se l’individuo non devia ma osteggia il pensiero indipendente, escludendone il portatore.
Estetica e ideologia, quindi. Nell’ideologia non c’è spazio per l’estetica perché la prima è il regno dell’individualità, del concetto privato di arte e bellezza e soprattutto delle sue espressioni, al di là dell’accettabilità o meno delle stesse.
L’arte non ha regole o non dovrebbe averne mentre l’ideologia trae forza vitale dall’imporne. Ogni deviazione dalla regola indebolisce l’ideologia, ogni cedimento alla dittatura della regola annienta l’estetica, intesa come insieme delle libere espressioni individuali.
In quale mondo vogliamo vivere? In quello estetico in cui siamo liberi di essere noi stessi rischiando di offendere qualcuno con le nostre opinioni o in quello ideologico in cui il premio per la buona condotta è essere accettati in una società che certifica solo la nostra adesione al programma ma ci nega nel contempo la libertà di esprimerci?
Oggi, per molti versi, siamo all’interno di questa nuova, pervasiva e ossessiva ideologia.
Parafrasando BEE di American Psycho, dov’è l’uscita?