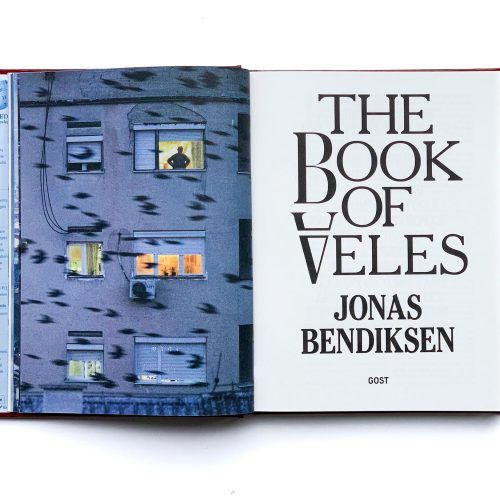Queste sono immagini e impressioni raccolte in un viaggio di due settimane a Chicago e New York, organizzate in maniera incoerente o piuttosto secondo un flusso di coscienza. Sono fotografie, ecco, e non compongono di certo una guida coerente, che di quelle ce ne sono già altre e molto meglio scritte.
Guardo l’auto parcheggiata qui sotto. Sono in un condominio di Greenpoint, a Brooklyn. È piena di polvere e foglie cadute dall’albero che le fa ombra. Sono foglie di più di qualche stagione, quella macchina deve essere ferma da mesi, forse anni. Ce ne sono altre: alcune pulite (una donna sta lucidando la sua, è un colore verde marcio, quantomeno inusuale), altre più o meno trascurate, altre trattate religiosamente. In una società che venera, rispetta e usa moltissimo la macchina, la macchina può dire tantissime cose di quella stessa società. Quelle di questo parcheggio raccontano quanto guadagnano i loro proprietari, quanto vengono usate, quanti in questo condominio hanno la macchina, quanti la considerano uno strumento, quanti un investimento.
La benzina qui costa mediamente 4 dollari al gallone, cioè poco più di un euro al litro. È un prezzo ancora alto, ricordo che poco più di un anno fa costava molto di meno. Lo ricordo perché quando superò una certa soglia gli americani impazzirono, o almeno così la raccontarono i giornali. Impazzirono perché erano abituati a pagarla molto di meno, o quello che gli sembrava giusto. Non sapevano quanto la pagavamo e la paghiamo noi europei, cioè a occhio e croce il doppio. Tutto è relativo e quello che ti sembra normale non lo è più quando il suo valore cambia, cioè quando il sistema di riferimento della normalità si stara e tutto costa troppo poco o troppo.
L’effetto che deve fare il prezzo della benzina europea a un americano è pressapoco quello che fa a noi la roba da mangiare in America: troppo.

Oggi ho fatto la spesa (in Italia) e pensavo avessero sbagliato i prezzi perché certe cose costavano la metà o meno, altre ancora meno. Dopo ho letto un articolo che parlava di “food insecurity” e ho pensato che se non fossi appena stato negli Stati Uniti avrei pensato all’ennesima esagerazione giornalistica e invece dare per scontato che si riuscirà a mangiare qualcosa domani o fra una settimana non è così scontato da quelle parti.
Ad Harlem ho visto una lunga coda di persone lungo un marciapiede. Ero su una strada non lontano dalla Columbia University, una delle università più costose al mondo. Ho visto in fila persone di ogni genere e colore. Ho notato una coppia di giovani con un passeggino e un bambino. Sembravano il ritratto della coppia middle class: vestiti in modo sportivo ma di bell’aspetto e curati. Mi sono girato per capire dove fosse diretta in ordinata fila tutta quella gente: un po’ oltre c’era l’ingresso della Food Bank, cioè del banco alimentare. Non si tratta di una banca ma di un’istituzione che distribuisce pasti gratuiti. Tutti aspettavano il loro turno, se all’inizio di quella fila ci fosse stata la biglietteria dello Yankee Stadium non ci sarebbe stata differenza. Erano tutti in dignitosa attesa. Non c’è niente di cui vergognarsi, forse la normalità è accettare una situazione di disagio come, appunto, normale. Transitoriamente normale, almeno.
Chissà cosa ne pensavano quelli. Forse, da buoni newyorkesi, se ne fregavano di quello che pensavano gli altri, perché anche loro degli altri non pensavano niente.
A New York ci sono storie ovunque.
Ha detto pressapoco così Casey Neistat, in uno dei suoi video. Spiegava, se non ricordo male, la differenza fra New York e Los Angeles, dove ha vissuto per qualche anno tempo fa, scappando da un burnout lavorativo sviluppato con metodo militare nella Grande Mela, e anche per trascorrere più tempo con la famiglia.
A Los Angeles c’è rimasto qualche anno, poi ha dovuto tornare a New York. A caccia di storie, cacciato dalla West Coast dalla noia mortale di un mondo in cui c’è sempre bel tempo e niente è fuori posto, come diceva Marcello Mastroianni intervistato da Dave Letterman. Forse ai suoi tempi era vero, adesso Los Angeles e San Francisco gli piacerebbero di più per il caos che vi regna, o almeno così dicono i giornali (esistono ancora i giornali?)
Il bel tempo c’è ancora, e Marcello non c’è più, però trovo curioso che forse per manierista piaggeria o con sincerità anche lui preferisse New York. E poi Mastroianni poteva dire quello che gli pareva, per dio. Tipo che non ne poteva più del bel tempo perenne e della pulizia eccessiva. Voleva la variazione, l’imprevisto, l’imperfezione (la merda per strada, diceva proprio così in quell’intervista, e Letterman fingeva di non aver capito bene).

Due città non descrivono di certo un paese complesso e vastissimo come gli Stati Uniti ma parlando di America mi riferisco più all’idea che ne abbiamo: quella che ci è pervenuta da quella cultura, quella che ci è stata formata, quella che abbiamo maturato un po’ tutti.
Per la mia generazione l’America era un’esagerazione e un sogno, già dal nome: un paese così gonfio di sé da assumersi l’arbitrio di diventare grande come un continente. Scoprire l’America o Vivere il Sogno Americano sono stati per anni modi per definire una proiezione di futuro possibile e auspicabile, un augurio, un’idea di progresso, libertà, giustizia sociale. Per molti di noi, l’idea di America era monolitica ed era un faro splendente, stagliato su un orizzonte lontano ma visibile.
Gli USA non sono l’America ma sono una declinazione possibile di un continente ben più vasto, eppure per decenni sono stati una sineddoche continentale: il tutto diceva la parte, o la parte si appropriava del tutto.
Quando poi ci vai negli Stati Uniti, il sogno diventa realtà, e diventando tale, smette di essere sogno. Non che si trasformi in una disillusione, affatto. Semplicemente gli USA diventano cioè che sono, e cioè gli USA. Teoria e pratica, illusione e realtà, quelle cose lì.
In viaggio è meglio andarci come vasi vuoti, me lo ripeto ogni volta. Mi do questo consiglio anche per giustificare la mia pigrizia nel leggere prima qualsiasi libro saggio romanzo che parlino dei luoghi dove sto per andare. È per non avere preconcetti, è per essere, appunto, come vasi vuoti che sono pronti a farsi riempire di realtà e storie.
Non avere preconcetti o aspettative è sempre una buona regola di vita e anche un atteggiamento rispettoso nei confronti di ciò che si sta per conoscere: evita di affrontarlo prevenuti, convinti di saper già cosa ci aspetta. L’esperienza, per dire, è più reale. A volte anche più brutale.
Una cosa che si percepisce e si vede è che le persone sono senza pelle. Con questa immagine intendo che tutto è percepito alla massima intensità, non c’è mediazione, non c’è filtro. Il capitalismo negli USA è la massima e più spietata espressione del capitalismo che si possa immaginare. Per essere all’interno della società devi correre forsennatamente, senza sapere nemmeno dove. Se non lo fai sei fuori. Esisti sulle strade ma non ti vedono. Sei uno zombie che vaga perso sui marciapiedi o dorme sullo soglia di un negozio di notte e fai parte del paesaggio, a tal punto che non vieni neanche più notato. Sei normale, come era normale quella fila fuori dalla Food Bank.
Il contraltare è che l’economia statunitense è la più dinamica al mondo. Attualmente il tasso di disoccupazione (che, ricordo, non contempla chi non cerca nemmeno un lavoro) è al 3% e rotti. Una percentuale fisiologica di non impiego, che lo rende praticamente nullo. Se vuoi lavorare, puoi lavorare. Quale lavoro poi è un altro discorso: puoi fare il guidatore per Uber o Lyft, guidare senza sosta e arrivare a pagare un affitto a prezzi folli per una casa che puoi chiamare casa dove andare a dormire qualche ora o puoi fare il cameriere. Puoi fare mille cose, senza tutele, sapendo solo che se perdi il lavoro puoi trovarne un altro molto velocemente. È la mobilità del lavoro, e negli USA è al massimo livello: meno tutele ci sono, più il mercato del lavoro è fluido e permette travasi da un settore all’altro. In Europa non è così anche se è il modello verso cui molte democrazie stanno andando o sono già andate. Promette (e spesso mantiene) soldi per tutti ma senza alcuna tutela.
Ma questo non è un pezzo giornalistico. Non sono un giornalista e non ho l’ambizione o la presunzione di dire cosa sono gli USA avendo visitato due città in due settimane. Sono impressioni, si diceva.
Un’ultima – per ora – impressione è che la dinamicità di quella società è massima. Lo si vede nel come cambiano le città, nelle nuove costruzioni, nei negozi che aprono o chiudono, nelle mode che si avvicendano, nella frenesia che avvinghia chiunque, a parte chi si è chiamato fuori dalla mischia o ne è stato escluso. L’unico biglietto che puoi comprare per partecipare al gioco è lavorare. Fare la tua parte. Per fare soldi, s’intende.

Quello che mi porta al JFK per tornare in Italia parla molto. È indiano, anche se è nato in California e ha vissuto in India, in Inghilterra, in Germania e anche in Italia per un po’. Poi è andato a vivere a New York. Parlo molto con tassisti e guidatori di Uber o Lyft (due servizi che funzionano divinamente e che infatti in Italia non vogliono implementare, perché smaschererebbero l’inefficienza sistemica dei taxi – ma ce ne siamo accorti comunque, grazie) e in genere parlo con chiunque sia disposto a farlo. Il che capita spesso perché una qualità che va riconosciuta agli americani è la disponibilità. Sono curiosi, sono aperti, spesso sono loro a fermarti e a conversare. Questo guidatore mi ha raccontato di quanto costano gli affitti a New York: 2.000 dollari al mese in zone pessime, 5.000 in zone buone, 10.000 a Manhattan. Non era l’istituto di statistiche americano e magari ha semplificato ma, visto il costo della vita lì non stento a crederci. Però dice anche che se se vuoi farcela, quello è il posto giusto. Poi precisa “Beh, un po’ ovunque negli States, ma qui a New York e nello stato in particolare”.
Ci penso un po’ e trovo che non possa che trattarsi dell’incredibile dinamicità di questa società dove tutti fanno e sono affannati, dove l’operosità è palpabile, assieme alla vita. Non la si può di certo definire una società non vitale, anche se resta il dubbio di dove e come si applichi questa vitalità. Qual è il progetto? Come si dà un senso al tutto?
Uno dei più feroci critici (e quindi anche uno dei più sinceri amanti) di questo modello era il comico George Carlin. Una volta gli chiesero qual era il senso della vita e lui rispose “Il senso della vita è la vita stessa”.
Il senso degli Stati Uniti sono gli Stati Uniti stessi, e il fatto è che quell’idea cambia in continuazione, è in continuo aggiornamento. Puoi fermare uno per strada e chiederglielo e magari si stupirà della domanda e ti risponderà che non lo sa, che sa solo che bisogna andare avanti.
Ci sono però anche forze sotterranee e meno evidenti. Segnali, lampi. Forse è una mia speranza più che una realtà e la immagino così: che la narrazione stia cambiando. Che l’insistenza nel dibattito pubblico – al di là delle feroci polarizzazioni politiche – sui temi della salute mentale nascondano un sincero desiderio di superare la divinità del profitto e di esplorare dimensioni più spirituali, più interiori.
Ne ho parlato con un architetto di Chicago che si occupa di architettura applicata ai luoghi per la guarigione attraverso la spiritualità. Non intendo chiese o simili, anche se l’essenza di quei luoghi potrebbe assomigliarci. Parlo della necessità sempre più sentita di prendersi cura di ciò che provoca essere parte di questo dinamismo e non farcela, esserne espulsi. Gli chiedo se forse al profitto si inizia a preferire qualcosa di diverso, di più profondo e curativo. Mi dice che non lo sa, che lo spera, ma che di certo quando anni fa ne parlava non c’era nessuno ad ascoltarlo, mentre ora non è più così.
Cambiano le idee a cui le persone pensano. Quando non si ha l’ossessione del profitto e ci si chiede dove si sta andando allora si capisce che tutto non può ridursi ad accumulare e che bisogna cercare una risposta altrove. Magari dentro di sé, magari negli altri.
Si va avanti, in un modo diverso.

LA TRILOGIA AMERICANA
1. America | 2. America, ancora | 3. America, infine