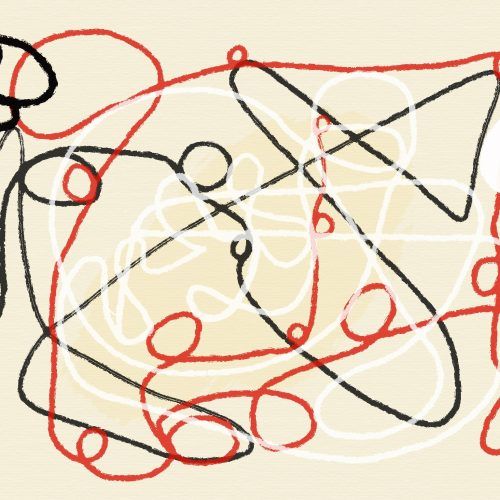I film, la musica, i libri che ho visto, ascoltato e letto da giovane sono meglio di quelli che vedo, ascolto e leggo oggi?
Mi pongo spesso questa domanda ma, a differenza di anni fa, non penso più che la risposta sia importante. Col passare del tempo penso anzi sempre meno che le risposte in genere siano importanti. Una risposta mette un punto e più passa il tempo e meno tempo resta, più voglio avere l’illusione che me ne resti per fare altre domande, e non per avere risposte. È un’illusione ma è anche un’elegante soluzione, e io amo l’eleganza.
Comunque. Questa riflessione nasce da una constatazione, ossia che se penso a film, musiche e libri, i primi che mi vengono in mente hanno raramente meno di 20 o 30 anni. Non voglio dire che in questi decenni non ne siano usciti di memorabili (e probabilmente alcuni di questi avranno fatto o faranno l’effetto che descrivo a chi avrà 50 anni fra 20 anni) ma non posso negare che, consciamente o inconsciamente, quando ne vedo, ascolto o leggo uno nuovo non riesco a non paragonarlo a quelli che per me sono fondamentali.
Ogni volta che vedo un film che cita evidenti riferimenti a pellicole del passato penso “Ho colto la citazione, apprezzo” ma poi invariabilmente finisco a pensare che l’originale era meglio.
Ogni volta torno alle origini e a quei film – soprattutto i film – o le musiche o i libri che costituiscono la mia cultura.
So che una spiegazione è che si tratta di opere incontrate, apprezzate e amate negli anni di formazione e che pertanto diventano i termini di paragone proprio perché “hanno dato una forma” alla mente. Tutto ciò che viene dopo è misurato rispetto a quella precisa forma e molto spesso poco ci si adatta: è troppo grande o troppo piccolo e alla fine non c’entra molto.
Questo argomento mi serve a liberarmi di una cosa che la mia mente si rifiuta di ammettere, perché contraddice un principio in particolare: che tutto è in costante evoluzione e che non sono i tempi e le loro espressioni culturali a imbarbarirsi ma noi e le nostre atrofie e pigrizie mentali a non voler più capire.
I linguaggi si evolvono o semplicemente cambiano e da un certo punto in poi è difficile provare curiosità per una forma che muta e che non si riconosce più. A un certo punto non ci interessano più le risposte e allora torniamo ai punti fermi: ai film, ai libri e alle musiche di una volta. Perché ci pongono in continuazione delle domande e riescono sempre ad apparire sotto una luce diversa. Mi capita con Bach – che cito spessissimo – o con Fellini o Kubrick o Antonioni. Cito i primi tre che mi vengono in mente, perché continuo a tornare a loro, perché sono sempre un termine di paragone e soprattutto perché riescono a produrre significati in qualsiasi decade della mia vita. E non penso solo della mia.
Esercitare curiosità rispetto alle novità non è in contraddizione con il paragonarle a ciò che le ha precedute: è inevitabile, più che altro. Io resto curioso della nuova musica e dei nuovi linguaggi ma torno a ciò che già conosco.
La mia tesi è che non sia un atteggiamento reazionario: lo sarebbe se comportasse il rifiuto di qualsiasi dialogo col contemporaneo e invece io lo frequento e lo voglio capire, o almeno ne sono attratto. In fondo sono linguaggi che evolvono e io amo sempre le evoluzioni, anche se forse amo meno alcuni esiti a cui giungono.
Amo il processo, non amo sempre il risultato.
Questi pensieri nascono dalla morte di Donald Sutherland, che mi ha riportato alla mente Il Casanova di Fellini (che non si chiama “Il Casanova”, di Fellini, ma proprio “Il Casanova di Fellini”, perché si trattava di una sua interpretazione ispirata alla figura del veneziano ma non osservante – o almeno non del tutto – dell’autobiografia). Se non ricordo male ho visto quel film un paio di volte, forse tre. L’ultima tantissimi anni fa. Per non dilungarmi non descrivo ciò che ne conservo ma ne riporto le sensazioni, il sapore che me ne rimase: della pasta del racconto, dell’atmosfera, dell’odore psicologico, della sconfitta e dell’umanità.
Uso quasi tutti i sensi per descriverlo perché la mia mente lo ricorda così: come se avesse avuto e prodotto colori, odori, spigoli e rientranze, superfici da lisciare con i polpastrelli e lame su cui tagliarsi. Le grandi opere d’arte – mi dico – sono totali nel senso che prendono il controllo del cervello, ma in un modo peculiare: montano uno specchio su cui la mente si riflette.
Le grandi opere d’arte restituiscono la vera immagine di chi le osserva. E non è detto che sia una bella immagine, ma è tutto ciò che c’è da vedere.
Quelle di Fellini – soprattutto per la loro scrittura onirica e surreale – riescono a essere vagamente allegoriche e precisamente psicologiche. Cerco di spiegarmi meglio.
Ho rivisto la scena dell’harem di 8½, quella in cui raccoglie tutte le donne della sua vita per una cena in una specie di fienile o di casa rurale dove tutte vivono assieme, dalla moglie all’amante, dalle donne fugacemente incontrate a quelle amate ancora più celatamente. Le ha persino divise per età: chi ne ha una certa abita al primo piano e sa che può vivere solo nei ricordi di Guido Anselmi, perché lui non le cercherà più. Senza descrivere oltre, questa è anche la scena del bagno (il ritorno nel liquido amniotico? Il simbolo della cura materna, che pulisce e monda dai peccati?) e poi della frusta: lui cerca di contenere una improvvisa ribellione di alcune di loro frustandole, mentre indossa un grande asciugamano (è appena uscito dalla tinozza dove è stato purificato) e il cappello che nella forma ma non nelle dimensioni (è molto più contenuto) ricorda quello di un cowboy.
Mentre la riguardavo pensavo che con il dibattito culturale di oggi Fellini probabilmente sarebbe crocifisso per una scena del genere ma per il motivo sbagliato: perché non la si capirebbe. Oggi si penserebbe che sia una manifestazione di dominio e violenza dell’uomo sulla donna mentre è esattamente il contrario: è Guido/Fellini a essere dominato e anzi, persino bisognoso di essere contenuto e accudito tanto da manifestare in modo infantile e disperato quel desiderio primario: quello di ricevere amore.
Alla fine credo che questa e tante altre opere – specie le più somme – cerchino di rispondere a una domanda: sono amato? Che è alternativa a “ho un senso? Ha senso tutto ciò?”
Per tornare all’inizio: oggi non cerco più risposte ma amo di più le domande e queste opere continuano a fornirmene. Non è casuale insomma che le consideri ancora fondanti: hanno dato una forma alla mia mente perché ci si è riconosciuta. L’hanno riflessa e quello che ha visto non sempre le è piaciuto ma ha dovuto ammettere che quell’immagine era quella di lei stessa.
Allora ho capito che nelle opere d’arte ci si riconosce nella propria interezza: sia nella luce che nell’oscurità, sia nel pieno che nel vuoto, sia nel rumore che nel silenzio.
Nelle sue opere Fellini ha sempre raccontato sé stesso, dandone un ritratto psicologico: il suo rapporto con le donne, le sue insicurezze, le sua grandezze, le sue ossessioni. Ogni grande artista lo fa, così come Bach nelle sue Passioni celebrava la grandezza di Dio e la fragilità umana, alla fine intrecciandole così finemente che non si capisce dove finisca l’una e inizi l’altra.
Di fronte a queste opere ci si riflette come in uno specchio che non restituisce solo un’immagine bidimensionale ma anche una profondità: ci si finisce dentro con tutti i sensi e si annusano le nebbie in cui cammina perso Casanova o si resta abbagliati dal sole delle Terme di Chianciano di 8½.
Queste opere – quelle di formazione – provocano vibrazioni sismiche, plasmano e modellano ma non manipolano: trasformano l’anima in ciò che è destinata a essere, o le fanno ritrovare la sua forma eterna che è stata distorta dall’esser diventata terrena entrando in un corpo.
Entrando in contatto con loro, l’anima – o la mente, ma preferisco dire l’anima – riverbera e trova il suo suono, la sua accordatura. Ritrova una collocazione e un senso.
Io non sono Guido Anselmi o Casanova ma una parte di me lo è. Non sono una variazione Goldberg ma una parte di me lo è. Io non so esattamente cosa e come sono ma in quelle opere vedo un’immagine riflessa e capisco che è la mia.
Certe opere d’arte sono una casa a cui amiamo tornare: conserva ricordi buoni o meno piacevoli ma è una casa e ci accoglie. Senza darci risposte e senza aspettarsi niente in cambio se non un’altra domanda: l’ennesima, prima di un’altra ancora, senza fine.