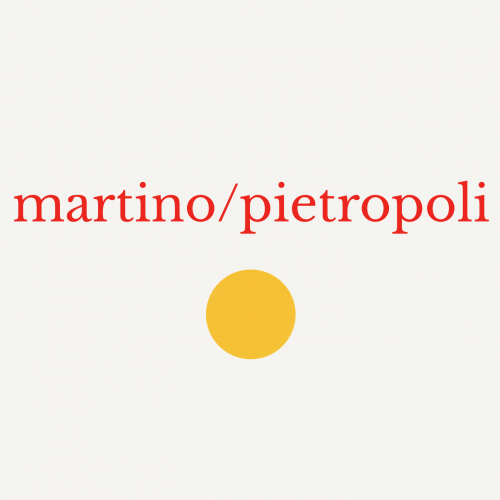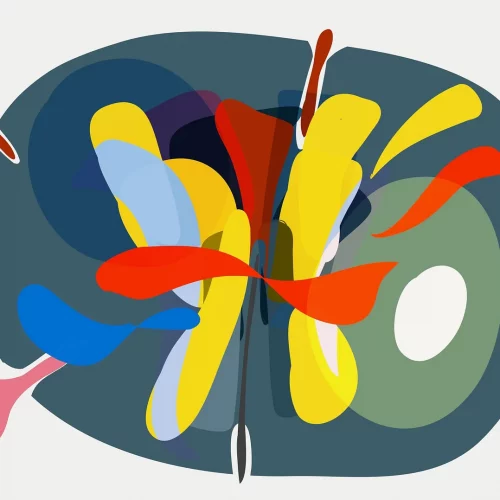Per passare il tempo nella metro mi metto a guardare le pubblicità. Ce ne sono di avvocati che promettono risarcimenti importanti, di app per cercare case o per capire se paghi troppo o troppo poco di affitto, di scuole o università. Le pubblicità – penso – rispondono a delle esigenze contingenti delle persone che viaggiano sui vagoni della metro: parlano di cosa vedere in tv, di uno show di Broadway, di un’opportunità di lavoro o di studio. Tutte cose che, statisticamente, possono interessare.
Ce n’è una che attira la mia attenzione. Parla di un test per il fentanyl. Escludendo che un tossico voglia testare la droga che deve assumere, non capisco nemmeno se forse si rivolga a chi vede qualcuno in overdose. Non mi pare la spiegazione più plausibile, dubito che uno che vuole aiutare una persona in overdose si metta a fare il sommelier della droga per capire di quale si tratta: chiama il 911 e semmai aspetta che arrivino i soccorsi.
E invece il test serve proprio ai tossicodipendenti, lo capisco poi informandomi. Le possibilità di comprare droga tagliata male o con dosi eccessive di fentanyl può causare overdose letali. Un articolo di marzo del 2023 sul New York Times parla di 2.100 morti accidentali per overdose nel 2021 solo a New York. 2.100 persone che pensavano di assumere qualche altra droga o proprio il fentanyl ma non aveva idea di quale percentuale ne contenesse la dose acquistata. Il fentanyl è letale se assunto in dosi eccessive (e una dose eccessiva può essere anche modestissima in quantità, da questo punto di vista non perdona) e con questi test si può capire cosa è contenuto nella dose e in che percentuali. Si chiamano strips, e sono delle strisce che si acquistano a un dollaro.
Quindi: se la pubblicità che vedi nella metro esprime esigenze, desideri e bisogni di chi la usa, la droga rientra in una di queste categorie, o almeno in un’altra: quella delle emergenze.
Questo tipo di comunicazione non tradisce una caratteristica degli americani, ossia il senso pratico: se c’è un problema sociale del genere è meglio riconoscerlo, informare e prevenire piuttosto che considerarlo un vulnus che imbarazza e del quale è meglio non fare cenno. Almeno dal punto oltre il quale un problema individuale e circoscritto diventa endemico, e quello degli oppioidi è decisamente endemico negli USA.
Del resto loro hanno sempre fatto dell’iperbole un modo di comunicare, come se per mostrare ciò che sono (o pensano di essere) ci sia sempre bisogno di esagerare. Non hanno mai fatto nemmeno mistero di certe loro debolezze o difficoltà, né gli si può addebitare d’essere ipocriti. Riconoscendosi come società in buona dose violenta, hanno sempre esportato l’immagine di un popolo – o di gente, un popolo ha un’omogeneità che gli americani non hanno, essendo molto eterogenei – che cura la violenza con la violenza.
E anche con l’ironia e l’arte, ma la trasmissione della cultura popolare è spesso avvenuta usando la chiave della violenza.
Questo è stato vero fino a 10-15 anni fa. Come dicevo, ora gli USA sono una cultura decadente e certe loro produzioni artistiche sono fra le cose più interessanti e profonde che si possano vedere, leggere o ascoltare. Rimosso l’elemento dell’autocompiacimento, sopravvive l’introspezione o l’osservazione scientifica di ciò che accade all’animo umano. Con ciò intendo che film, libri e musica – almeno quelli di una certa qualità – non spiegano ma osservano e riportano. Non assolvono né condannano e, credo intimamente, una società che non assolve né condanna è una società che si sta evolvendo.

Parlando di condanna, il pensiero va alle carceri. Il sistema penitenziario americano è uno dei più affollati del mondo (forse il più affollato). Un sistema carcerario affollato può dimostrare che le forze dell’ordine lavorano molto e bene oppure che la percentuale di popolazione criminale è elevata. Nessuno dei due casi è vero, o almeno non totalmente vero. Stupirà constatarlo ma ciò che è criminale non è universalmente oggettivo. Vi sono attività considerate criminali in alcuni paesi e lecite in altri, oppure gli stessi crimini non hanno eguale pena in diverse parti del mondo. Ma il discorso sulle carceri è troppo gigante per parlarne qui e ora. Mi serviva per parlare di una cosa che era criminale fino a pochi anni fa e ora non lo è più, e ha a che fare con il consumo delle droghe leggere.
Prima di tornare nel 2022 a New York, vi mancavo da quasi 10 anni. La prima differenza che colsi fu l’aroma che sentivo passeggiando per strada, praticamente per qualsiasi strada. Era inconfondibile ed era ovunque, senza distinzione fra zone ricche e meno ricche. Era l’aroma della marijuana. Ormai ovunque si passeggi se ne sente l’odore, con una frequenza che fa impallidire Amsterdam, dove anzi fumare per strada non è visto di buon occhio.
Si potrebbero dare molte letture di questo fenomeno: che ha avuto il merito di legalizzare (e, quindi, non criminalizzare) un uso piuttosto diffuso delle droghe leggere, facendolo emergere e rendendolo visibile, senza stigma sociale; che ha riconosciuto uno stato di fatto e che ha infine formalizzato un atteggiamento maturo, e cioè quello di accettazione del consumo di certe sostanze.
C’è anche una lettura psicologica più complicata da sostanziare ma che trovo coerente con lo spirito americano. È mia e me ne assumo paternità e responsabilità. Dice che questa liberalizzazione è la conseguenza di un tratto tipico di questa gente ed è la mancanza di ipocrisia. Non significa che la società americana non conosca ipocrisia, ma che rispetto a certi temi sociali è capace, appunto, di non essere ipocrita. È una società, si diceva, che affronta pubblicamente certe debolezze, esportandole pure (e capitalizzando su di esse, particolare non trascurabile). Me ne sono accorto quando – ormai da qualche anno a questa parte – i temi della salute mentale sono diventati sempre più discussi e centrali. Ho notato che molti che ne avevano avuto esperienza ne hanno poi parlato pubblicamente: per condividere e aiutare, certo, ma anche diventandone esperti, parlandone in conferenze e simposi e scrivendoci libri. Guadagnandoci.
Gli americani trovano sempre un modo per capitalizzare. Qualsiasi cosa.
Guardo sempre con atteggiamento misto questi fenomeni: da un lato io sono il risultato di una cultura che ha pudore anche quando non ne dovrebbe avere (specie quando il pudore allontana dalla soluzione dei problemi, relegando all’esperienza individuale traumi che potrebbero essere più serenamente risolti stemperandoli nella collettività) e dall’altro non riuscirei mai a trasformare una difficoltà temporanea in un’occasione di lucro, o la interpreterei come un’immeritata ricompensa. Evidentemente non è così per molti americani che, attraversate situazioni di sconforto, ne mettono l’esperienza a reddito.

In fondo che se ne possa ricavare qualcosa è il minore dei problemi quando, facendolo, si aiutano altre persone, no? Immagino sia così ma lo ascrivo allo stesso tempo alla capacità che hanno di non lasciare niente di intentato, forse perché sono sempre sull’orlo di perdere tutto. Dipende ovviamente dal reddito e dall’animo delle persone ma non escludo che accada lo stesso anche per chi ha una certa solidità finanziaria.
Gli USA sono il paese della transitorietà. Le cose oggi sono così e domani cambieranno.
Questa visione del mondo gli deve essere stata inoculata sin da piccoli o la imparano vivendo ma si ha l’impressione che si tratti del popolo più abituato ai rovesci della fortuna e, probabilmente anche per questo, più reattivo e capace di riprendersi.
C’è forse anche un altro motivo che giustifica l’apparente leggerezza con cui gli americani assumono sostanze psicotrope (e, in questo caso, alla marijuana aggiungo anche gli psicofarmaci) ed è la volontà di eliminare qualsiasi ostacolo si frapponga fra loro e la massima espressione performativa individuale. La ricchezza e la sua ricerca sono la Chiesa Americana, e il perseguire un ideale di stabilità economica e di collocazione sociale è una possibile risposta alla domanda esistenziale sul senso della vita. Il senso è trovare un luogo dove stare, cioè occupare una posizione sociale o una qualsiasi posizione che collochi l’individuo in un luogo, fisico o mentale. Non è casuale che gli americani siano anche assai poco stanziali e abituati a spostarsi nel loro paese con una frequenza inusitata. Alla ricerca di un riscatto o di una posizione più alta nella scala sociale. O anche solo cercando di stare a galla.
Non riesco insomma a leggere questo trasporto per il consumo di droghe leggere come si fa normalmente, ossia come di fuga dalla realtà. Secondo me è un modo per abbassare il volume della vita e concentrarsi su altri obiettivi, per avere meno distrazioni. Non in ogni caso (le droghe ricreative sono anche evasive, non si discute) ma molto spesso, sì.
Quest’anno gli americani che hanno richiesto un passaporto non sono mai stati così numerosi. Gli USA, curiosamente, erano un paese i cui abitanti avevano percentualmente meno passaporti che in molti altri paesi sviluppati. È come se prima si fossero risolti e conclusi in sé e ora invece cercassero altrove stimoli e risposte. Anche questa è una tesi non dimostrabile (è dimostrabile solo che abbiano richiesto più passaporti di una volta) ma può indicare una certa curiosità o necessità di guardare altrove, convinti – forse inconsciamente – che nei loro territori e nelle loro città non vi sia una risposta. Che il loro paese non li contenga più o non contenga la risposta. È un’idea.
Comunque li si guardi e valuti, gli americani sono costantemente alla ricerca di qualcosa di nuovo e diverso. Il mito della frontiera non è tramontato.
Delle tre parti di una trilogia, questa è l’ultima. La decisione è, come ogni decisione, arbitraria. Per naturale e non pianificata evoluzione ho deciso che le parti dovessero essere tre, e basta. Tre è anche la ripartizione del tempo, tre sono le fasi del fluire delle cose: passato, presente e futuro. Non so se di questo mio trittico il primo pannello sia il passato, il secondo il presente e questo il futuro. Dovrei sforzarmi di vedere un po’ oltre e cercare nel presente segnali che alludano al futuro ma non amo le previsioni né chi le fa.
Nel tragitto della mia vita sin qui ho potuto osservare che nel mio passato l’America era il futuro e la si guardava come una nave più avanti di noi, come un’avanguardia che mandava dispacci alle retrovie e ci raccontava cosa vedeva sulla linea dell’orizzonte. Noi saremmo arrivati, dopo.

Se posso vedere un futuro dalla sue tracce lasciate nel presente, oggi non colgo più questa visione. È come se l’Occidente si fosse scisso in due o più Occidenti: uno è quello degli USA e uno è il nostro, o quello degli altri, altri Occidenti. È chiaramente una semplificazione brutale e non tiene conto di una miriade di variazioni e casi particolari.
Poi mi è capitato di leggere Quando abbiamo smesso di capire il mondo di Benjamin Labatut e, poco dopo, di meditare. Nel mezzo (fra la fine del libro e la meditazione) ho annotato “Il momento in cui chiudi un libro che ti è piaciuto e guardi un punto all’infinito è l’inizio di una nostalgia.”
La fine è un punto di partenza, e quando un libro termina – se ha avuto un senso per noi – ha piantato un seme, quindi è un inizio che porta in sé la radice di un tempo, cioè una nostalgia: del tempo trascorso a leggerlo, dei sedimenti che ha lasciato.
La meditazione ha invece lasciato una traccia diversa (normalmente medito per immagini, questa notte ho meditato per concetti o questo si è appalesato): quella del tempo circolare e di quello lineare.
In Occidente viviamo in un tempo lineare, o nella sua illusione: sappiamo di avere il passato alle spalle e un futuro di fronte. Nel mentre occupiamo un punto che è il presente.
(È giusto specificare che il libro di Labatut narra storie di matematici e fisici e culmina con il congresso di fisici “Electrons et photons” a Bruxelles, nel 1927, quello in cui nacque ufficialmente – anche se era ovviamente già nata – la fisica quantistica. Lo dico perché può darsi che la meditazione ne sia stata influenzata)
E se invece occupassimo un tempo circolare? Le implicazioni non sono marginali: oltre alle ricorsività degli eventi, un altro portato sarebbe quello della sostanziale impossibilità di collocare passato prima e futuro dopo. Un cerchio non ha un senso di lettura, o entrambi valgono. Si può stare su un suo punto (il presente) e avere qualcosa davanti e dietro, e viceversa. In quest’ottica passato e futuro sarebbero intercambiabili e l’uno varrebbe come l’altro: potremmo aver già vissuto il futuro e non avere ancora vissuto il passato, o potremmo ingannarci inconsapevolmente e pensare che il passato sia ciò che dobbiamo ancora vivere e il futuro il suo opposto.
Il nostro rapporto con gli USA – e qui ne do una lettura quantistica e quindi influenzata da quel libro – non è più quello che vede in loro il nostro futuro ma un presente alternativo, o insieme siamo due presenti contemporaneamente attuali e plausibili.
Gli USA – ammesso che lo siano mai stati e non si siano solo voluti rappresentare così, illudendoci di esserlo – erano un futuro e ora sono un altro possibile presente.
La foto di copertina per questo articolo è la spirale del Guggenheim di Frank Lloyd Wright. Un edificio che si articola su, appunto, una spirale ascendente lungo la quale sono esposte le opere dell’omonima collezione. Un controsenso poiché, trattandosi di una rampa, i quadri appesi risultano sempre inclinati rispetto al pavimento (o viceversa) e un affronto polemico in sé poiché inserisce nella trama ortogonale di Manhattan un corpo circolare.
Si diceva che Wright non amasse New York perché vi dominava l’angolo retto e allora vi introdusse questo corpo alieno. Le grandi culture contengono i propri opposti, il tempo contiene ogni dimensione di sé (passato presente futuro) e New York alla fine ha integrato il Guggenheim nel suo grembo, facendolo anzi diventare uno dei suoi edifici più iconici.
Visitiamo un paese e le sue città e ne osserviamo le culture, cercando di penetrarle. È impossibile capirle in due settimane e forse nemmeno in due vite, quindi questa trilogia non è una risposta perché non ho risposte ma è solo un insieme di frammenti e pensieri annotati qua e là.
La città è un organismo, è un corpo: ha testa, mani, braccia, gambe, sistema circolatorio, organi interni.
All’inizio di questo viaggio parlavo delle persone che si vedono qui, che sono senza pelle, che sembrano sentire tutto più vividamente di altre. Poi ho pensato che quando si viaggia con la metropolitana si entra in uno dei sistemi circolatori di una città. Mi piaceva l’immagine e mi ha anche fatto pensare che il viaggiatore raccoglie solo impressioni e immagini ma non per questo è meno esposto a ciò che vede, anzi. A volte ha ancora meno pelle di chi ci vive poiché è esposto a tutto, contemporaneamente. L’abitudine di chi ci vive seleziona ciò che uno vede: le stesse strade e lo stesso tipo di persone, ogni giorno, andando e tornando dal lavoro, per esempio. Alla fine tutto compone uno schema chiuso, ripetitivo e rassicurante.
Il viaggiatore vede queste scene familiari per chi vi abita ma le vede tutte insieme. L’impatto può essere molto violento perché lo espone a dosi massicce di realtà, sempre che abbia la sensibilità di coglierle.

Visti i principali monumenti e i luoghi più importanti, amo osservare le città nella loro onesta essenza, oltre l’apparenza. Mi piace vedere ciò che non mostrerebbero per rappresentarsi nella loro bellezza e che, per tanto, tendono a oscurare. Vicoli, quartieri trascurati, marciapiedi rotti, umanità instabile sulle proprie gambe ma, proprio per questo, più sincera e vera.
È come leggere un romanzo che contiene tutto, anche le parti stralciate. È un’immagine tridimensionale e più completa e, come tale, contiene numerosissimi dati. Li contiene tutti.
Quando cammini per Manhattan questo romanzo ha un volume, a tratti – quasi sempre – insopportabile. Manhattan ha un volume intollerabile, sembra che tutti ti parlino contemporaneamente, gridandoti nelle orecchie. Ho ripensato alla composizione 4’33’’ di John Cage: quattrominutietrentatre secondi di silenzio. Fu composta nel 1952 con precise indicazioni rispetto agli strumenti musicali con cui eseguirla: qualsiasi strumento, dato che consiste in 4 minuti e 33 secondi di silenzio. Ma non di semplice silenzio, altrimenti chiunque se la potrebbe ascoltare semplicemente ascoltando il silenzio a casa propria. Gli esecutori fanno parte dell’esecuzione perché sono presenti sul palco e non suonano. Il pubblico stesso è parte dell’esecuzione perché il suo ascoltare il silenzio lo rende presente, lo rende “ascoltato”.
A New York ho ascoltato il silenzio o c’ho almeno pensato, l’ho bramato. Tutta la città urlava ed era un teatro in continuo movimento. Chiunque sapeva apparentemente dove andare, ognuno aveva un obiettivo. Ogni tanto vedevo qualcuno emarginato da questo flusso: senza una direzione, senza niente da fare. Queste persone stanno, non si muovono. Sono l’immagine del silenzio e, restando ferme, sono più visibili delle comparse che appaiono e scompaiono ai margini del campo visivo. Ho cercato di vederli. C’ho provato, almeno.
L’America intanto cambiava e cambia, ancora, incessantemente, attorno a loro, attorno a me.
LA TRILOGIA AMERICANA
1. America | 2. America, ancora | 3. America, infine