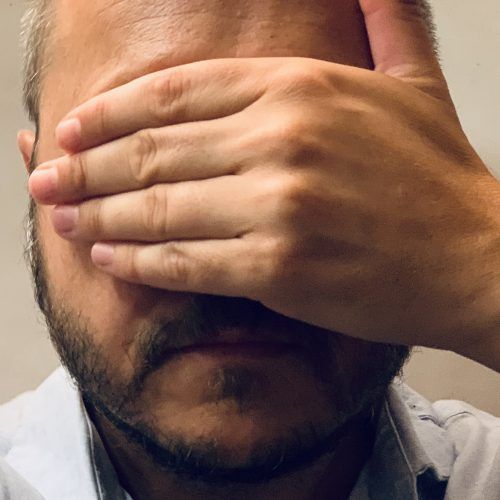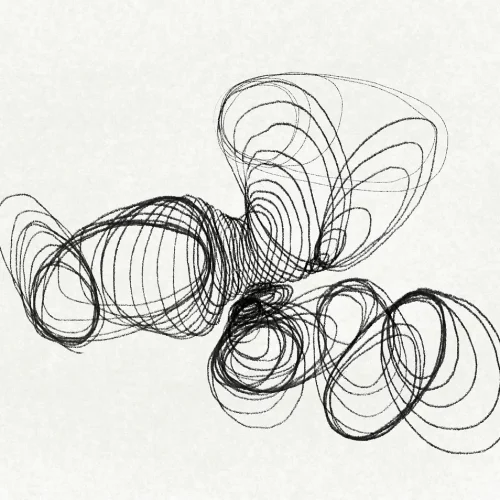Lo psicologo Jacques Lacan a volte usava una modalità terapeutica che consisteva in sedute di durata ridotta. Mentre una seduta tradizionale dura dai 45 ai 60 minuti, alcune sue duravano anche solo 15 secondi. Erano definite “a tempo variabile”, nel senso che decideva lui quanto dovessero durare, in genere in funzione del grado di consapevolezza del paziente. Lo scopo di quelle da 15 secondi era di concentrare l’azione terapeutica in un lasso di tempo che permetteva solo di pronunciare poche parole.
Quando il paziente – consapevolmente o meno – giungeva a un punto nodale del discorso, Lacan lo interrompeva, congedandolo. Facile immaginare che questo restasse appeso a quanto aveva appena detto, chiedendosi perché fossero così importanti le parole pronunciate.
Perché proprio su quelle Lacan l’aveva interrotto? Dovevano essere davvero fondanti, e su quelle Lacan voleva che i suoi assistiti fossero portati a riflettere. Vi sono poi altri motivi che giustificavano quella modalità terapeutica ma non è questo il punto.
Dire le cose con il minor numero di parole è la definizione più lineare di sintesi.
La sintesi del discorso è la sua forma economica: né una parola di troppo, né una parola in meno. Solo quelle che servono a dire qualcosa.
C’è un esercizio che si può fare quando si vuole esprimere sinteticamente un concetto. Non ricordo se l’avesse inventato qualcuno o se l’avessi rielaborato io, indipendentemente. Non vorrei mai dire che è mio ciò che è di altri.
Comunque: l’esercizio consiste in questo, e cioè nel dire con pochissime parole qualcosa di grande, importante, anche complicato. È formulato così:
Sei appeso a un precipizio e una persona ti può salvare. Lo farà però solo se riuscirai a spiegargli nel minor tempo possibile perché è importante che ti salvi.
La condizione di urgenza generata da questo esercizio porta l’attenzione solo sui fatti salienti, e allo stesso tempo comporta l’eliminazione di ciò che è superfluo. Chi può salvarti dal precipizio deve capire perché valga la pena farlo, non vuole sentirsi raccontare una storia né che venga stimolata la sua compassione.
È un ottimo sistema per essere convincenti quando si deve arrivare al nocciolo della questione, che molto spesso – sempre, direi – è descritto da poche parole.
Intesa in questo senso estremo, la sintesi è l’essenziale, il concetto centrale, ciò che è imprescindibile.
La sintesi è difficile perché non si tratta solo di dire di meno, anzi. Si tratta di dire tutto, con meno. Anzi: si tratta di dire tutto con il numero giusto di parole.
Allora mi sono chiesto perché ne aggiungiamo così spesso tante, evidentemente di inutili (come l’avverbio “evidentemente”, che potevo anche evitare).
Mi fa tornare in mente il gioco della vendita della penna in The Wolf of Wall Street, quando Di Caprio chiede ai suoi amici di vedergli un oggetto umile e di nessun valore economico come una penna. L’abilità sta ovviamente nel riuscirvi, e non tanto nel minor tempo possibile. Il successo della vendita (anche convincere quello che ti può salvare dal precipizio è una vendita) si fonda sulla capacità di creare un bisogno. Di Caprio allunga la penna all’amico e gli dice “Vendimela” e quello gli fa “Fammi un favore, scrivi il tuo nome su quel fazzoletto” “Non ho la penna” “Eccotela. Boom: domanda e offerta”.
Lo scambio di battute è talmente fulmineo che ci si impiega un attimo a capire cosa è successo. È successo che la sintesi ha messo a nudo il meccanismo: non servivano parole che descrivessero i pregi di una penna da pochi cent, bastava creare il bisogno di averla, per fare qualcosa, tipo firmare un fazzoletto di carta.
Ma questa non è una lezione di economia, che non sarei neanche in grado di fare poi. Quello che è più interessante è invece l’economia, nel senso dell’utilizzo ottimale delle parole. Quelle che servono, quelle che bastano.
Non è difficile capire perché mi interessi così tanto la sintesi: perché non ce l’ho, o ce l’ho a tratti. Ma ora non voglio essere sintetico, voglio solo dire cose che riguardano la sintesi, voglio ragionarci attorno.
Credo che la sintesi non sia solo un possibile tipo di comunicazione – un vascello di informazioni – ma sia il più efficace modo per depositare un seme.
Mi spiego. La sintesi di un discorso sono i punti salienti, ammesso che esistano. L’Ai sintetizza bene perché è capace di coglierli e restituirli. L’intelligenza umana incapsula i concetti in matasse di parole che servono a specificare, dettagliare, puntualizzare, nascondere, confondere, distrarre.
Mi sono chiesto quale sia il contrario della sintesi. Il dizionario dei sinonimi e dei contrari direbbe che è l’analisi, la scomposizione o la divergenza. L’analisi è l’esplosione e l’approfondimento di un concetto: serve ad aggiungere dettagli che sostanziano la natura della sintesi. Ci sta.
La scomposizione è l’atto di dividere gli elementi, mentre la sintesi è l’esito dell’unirli. Anche questa è interessante.
La divergenza mi piace particolarmente: se la sintesi è la convergenza verso un’unità di significato, la divergenza è il suo opposto.
Non so se la si possa a questo punto definire attraverso i suoi contrari ma la sostanza è che la sintesi è la freccia e l’analisi è l’aria che questa sposta, una volta scoccata. La sintesi è la materia e l’analisi (o la divergenza) è il vuoto che le sta attorno.
Dei discorsi, dicevo, ricordiamo i punti nodali. Del resto delle parole dette in certe occasioni non conserviamo memoria: sarebbe impossibile e anche inutile. Quello che ricordiamo è ciò che ci interessa ricordare, ciò che per noi ha senso ricordare. La sintesi è la forma del bisogno che abbiamo di ricordare qualcosa.
La sintesi è una funzione della memoria.
La memoria. Lo sapevo che andavo a finire lì (quando scrivo non so mai dove vado a parare, per quello scrivo: per stupirmi). La memoria non è statica, per quanto ci piaccia pensarlo.
I ricordi non sono parole scolpite nella roccia e non sono nemmeno file che possono essere letti e conservarsi immutati nei secoli. Ogni volta che si richiama alla mente un ricordo, lo si filtra attraverso le esperienze vissute tra la formazione dei quel ricordo e l’esperienza di riviverlo.
Un aspetto paradossale del rapporto con i ricordi è che più spesso vengono evocati, più vengono modificati. A ogni evento (di richiamo alla mente) la loro forma subisce una modifica: si aggiungono dettagli che non esistevano e se ne omettono inconsciamente o meno altri che non si ritengono interessanti. Una volta archiviato dopo la consultazione, il file della memoria è modificato. L’uso dei ricordi (il rievocarli) li logora, o almeno ne cambia la forma.
La sintesi è ciò che resta di quei ricordi, è il nome del file, è la sua collocazione e i fatti o le parole salienti accaduti o pronunciate in quel frammento di passato.
Per questo è ancora più importante. La sintesi è l’unità minima di informazione.
Questa che ho raccontato è la sintesi funzionale, nel senso che ha la forma e la sostanza che serve a dire o ricordare qualcosa.
C’è poi la sintesi poetica, altrimenti detta poesia.
Io non leggo molta poesia eppure amo la poesia. Un po’ come la danza: non la guardo mai ma quando mi capita penso che sia una cosa stupenda. E poi me ne dimentico.
La poesia è la forma più sublime di sintesi. La buona poesia è un’esperienza lisergica perché riesce ad accendere nella mente sequenze pirotecniche di immagini e ricordi e mondi. Ma è faticosa: fa godere la mente ma la obbliga a gorgogliare di un magma di immagini e concetti che si fanno azione, di definizioni che diventano origami colorati che si trasformano in uccelli che volano via, spostando masse d’aria profumata e calda.
A me la poesia fa questo effetto ma dopo un po’ che la leggo mi sento esausto.
La poesia è sintesi suprema perché dice solo quello che deve dire, è solo se stessa, eppure allude ad altre immagini e ad altre dimensioni. La buona poesia è come una lama che divide l’essenziale dal superfluo. È quel che c’è da dire e nulla di più.
Se fossi appeso a quel precipizio potrei dire una poesia, e magari mi salverei. O mi salverebbe quello che mi tiene per un polso. Direbbe “Ho capito”. Lo spero, almeno.