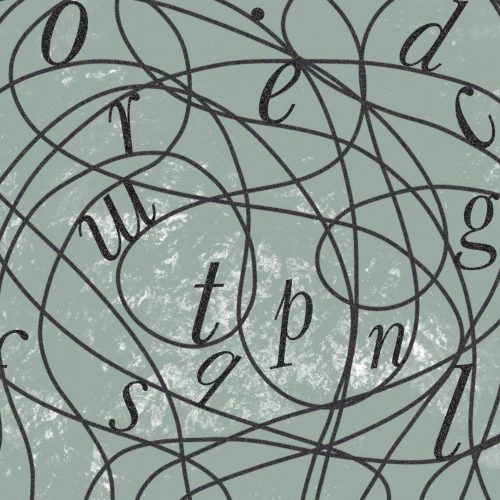Oggi, mentre tagliavo lo scalogno per il soffritto, stavo ascoltando il Concierto de Aranjuez, la prima traccia di Sketches Of Spain di Miles Davis. Pensavo fosse un pezzo originale e invece ho scoperto – mentre mi documentavo per scrivere queste righe – che si tratta in realtà di un’interpretazione dell’omonimo di Joaquin Rodrigo, che risale al 1939. Miles Davis se n’era innamorato e volle eseguirlo.
Non saprei dire se nell’esecuzione di un classico vi sia una volontà di appropriazione o di comprensione dell’esecutore. Probabilmente entrambe. Miles Davis voleva capirlo e poi farlo proprio e per riuscirci doveva eseguirlo, cioè esprimerlo. Forse i passaggi logici sono questi, anche se il jazz è noto come un genere musicale molto più libero di altri, e infatti viene spesso interpretato come sprovvisto di regole.
Mi piace citare ancora Miles Davis che diceva che:
It’s not the note you play that’s the wrong note – it’s the note you play afterwards that makes it right or wrong.
Che è un modo di dire che non esistono note giuste o sbagliate, ma che è il contesto che le rende tali o meno.
Il jazz è libero non perché non abbia regole ma perché ha una struttura fluida, che si adatta. Adattarsi significa riconoscere l’errore e integrarlo nel processo creativo. Accettarlo e, attorno a esso, costruire il resto dell’edificio musicale: la nota successiva. E poi le altre ancora.
Ho letto un bel ragionamento (non lo chiamo solo articolo perché è, appunto, un limpido modo di mettere in fila elementi) che riguarda un argomento apparentemente distante, ossia il modo in cui dovremmo rapportarci all’Ai, e citava John Coltrane e una delle sue più celebri e rivoluzionarie composizioni, ossia Giant Steps.
Scrivono Paolo Gervasi e Matteo Roversi in Futuri Preferibili:
Coltrane aveva creato un algoritmo perfetto, un sistema strutturato e inattaccabile. Flanagan, invece, si muoveva con il linguaggio umano dell’errore, della ricerca, della vulnerabilità. E quella vulnerabilità è rimasta nella registrazione, come una traccia di resistenza.
Nell’esempio che portano, Coltrane è la macchina – cioè l’Ai – che ragiona a una velocità inusitata per la mente umana e il pianista Flanagan siamo noi, che, attoniti di fronte al potere di calcolo (cioè, il potere esecutivo di Coltrane) restiamo interdetti, non capiamo, ci limitiamo ad accompagnare la musica, cercando di starle dietro.
Ma non volevo parlare di Ai. Volevo parlare di scrittura, perché mi sono chiesto quale sia un modo di scrivere jazz. Che poi, a dirla tutta, parlare di scrittura significa parlare di LLM e quindi di Ai. Ma torniamo a noi.
Se dovessi riferirmi alle regole (o non regole, o regole lasche) del jazz, dovrei pensare che l’errore è contemplato e anzi ben accetto, e che dovremmo indugiarvi nello scrivere jazzisticamente.
Dovremmo considerare che non esistono note sbagliate – ne esistono solo di inaspettate, diceva sempre Davis – ma solo note in determinati contesti che, nell’insieme, sono giusti o sbagliati. O “suonano” giusti o sbagliati. Per quanto il jazz suoni in modo strano e incomprensibile a molte orecchie. O noioso.
Com’è quindi una scrittura jazz? L’ho immaginata come un collage o forse come un film, montato in maniera molto libera, con inversioni cronologiche, con accelerazioni e decelerazioni continue, con cambi di ritmo, con espansioni e contrazioni.
Non so esattamente che forma letteraria potrebbe avere: forse è fatto di ragionamenti e immagini, di ricordi e di scatti in avanti, di riflessioni e descrizioni.
Di certo lo immagino imprevedibile, come la vita. Mi piace essere stupito, non mi piace riuscire a prevedere. La noia è prevedibile e il jazz ti allena a non prevedere niente. Dopo una nota giusta non ce n’è necessariamente un’altra giusta. Ce n’è un’altra e basta.
Non ricordo chi diceva che è difficile fare previsioni, specie se riguardano il futuro.
In questi giorni sto leggendo lo straordinario Solaris di Stanisław Lem (introduco una variazione, un cambio di ritmo, uno scarto. Sto scrivendo jazz? Non lo so: scrivo).
Avevo visto almeno due versioni cinematografiche del medesimo, ossia quella celeberrima (meritatamente) del 1972 di Andrey Tarkovsky e quella del 2002 di Steven Soderbergh. Non so se ne esistano altre ma quello che più mi sta affascinando del libro è la qualità superlativa della scrittura (e delle descrizioni del paesaggio di Solaris, e in particolare del suo oceano e della sua mutevole morfologia) e la metafora che, appunto, è rappresentata da questo oceano. Che non è fatto di acqua ma piuttosto di una materia gelatinosa e mutante, di un colore indefinito che muta con la luce e – sembra di poter immaginare – anche con l’umore di chi lo guarda.
È un oceano che è in se stesso un umore, una creatura sensibile che capta le energie mentali attorno a sé e risponde, reagendo e creando realtà che sono fatte della materia della memoria degli uomini che vivono lì. Solaris è una creatura che genera creature fatte di incubi e di aspettative deluse, è un oceano sferico molle e passivo che riflette il lato oscuro di chi lo abita, rendendolo evidente e inevitabile.
Ci sono lunghissime descrizioni delle conformazioni che è capace di creare, dei corpi tettonici e organici che plasma sulla sua superficie. Non è una presenza né minacciosa né benigna: è incomprensibile da occhi scientifici ma soprattutto è, e basta. Esiste.
Non è chiaro se sia il responsabile delle vivide allucinazioni che gli abitanti della stazione spaziale sperimentano ma l’origine dei visitatori – come li chiamano – che li vengono a trovare comparendo dal nulla pare essere collocata da qualche parte, in quell’oceano. Non so se in verità sia davvero così, ho superato da poco la metà, magari verrò smentito.
Quello che conta è che i visitatori sono personali per chi, involontariamente, li evoca. Kris Kelvin, lo psicologo che narra in prima persona, viene visitato dalla sua compagna, suicidatasi sulla Terra e ora riapparsa amorevole ma senza memoria, accondiscendente e remissiva in questa nuova dimensione.
Mi sono chiesto se l’oceano non sia una oceanica metafora del passato o del peso che ognuno porta con sé: quello delle aspettative deluse e delle delusioni vere e proprie, dei fallimenti, delle proiezioni di possibili futuri che sono diventati passati sghembi e sgorbi, memorie di fallimenti e sacche di resistenza di possibili riscatti. O forse Solaris è la parte oscura, ma illuminata. Voglio pensare che il suo nome suggerisca questo, anche se deriva dalla presenza del suo sole, o così lo immagino. È un sole che cambia i colori, violentissimo e accecante in certe ore, ed è una presenza ostile, da cui difendersi.
Ci si deve difendere però anche dall’oceano. Allora bisogna cercare di capirlo. In questa ricerca, che diventa una epica e tragica allegoria della costruzione del sapere, gli scienziati della stazione si chiedono:
Dovresti sapere che la scienza si occupa esclusivamente del come avvengano certi processi, e non del perché.
È un indizio, ed è la domanda di fronte a cui li pone l’oceano silenzioso e mutevole, minaccioso e piatto: perché succedono le cose?
E allora ho capito che non esiste una scrittura jazz ma che la scrittura è jazz: la scrittura è lo strumento che permette di raccogliere e legare ragionamenti, pensieri, suggestioni, direzioni e deviazioni lungo un percorso che non si sa, appena intrapreso, dove condurrà. Il senso della scrittura, come ogni viaggio che si rispetti, non è la destinazione e la chiusura del ragionamento (quella è affidata alla scienza, ed è transeunte) ma è la scrittura in sé. La scrittura chiede scrittura per procedere, e ricambia illuminando i tratti di percorso.
Non sono capace di suonare nessuno strumento ma ascolto il jazz. Non è semplice farlo: il buon jazz ti porta sempre dove non ti aspetti, ti mette sempre un po’ a disagio. Però ricambia con un’intuizione, con la vista di un nuovo luogo mentale che non sapevi esistesse. Il jazz ti chiede ascolto e restituisce un’immagine di chi ascolta: non è l’immagine reale ma è quella possibile, nel senso che è fatta di tutte le possibili variazioni e ramificazioni della vita.
È tutte le memorie (le forme del passato) e tutte le possibilità (quelle del futuro) insieme. È tutte le note conosciute e le loro combinazioni possibili e sbagliate, che diventano magicamente giuste.
Non so se l’oceano di Solaris sia jazz. Di certo è il luogo delle memorie che i personaggi di quel libro non vogliono visitare, è un passato che vogliono distruggere o almeno neutralizzare. È la parte della loro anima che non possono ignorare e che li definisce, attraverso le paure, i ricordi e gli errori.
Quell’oceano costruisce in pochi minuti architetture di bellezza sublime e terribile, che distrugge poco dopo, inghiottendole nelle sue viscere. Alcune di queste si chiamano simmetriadi.
Il simmetriade […] era per definizione «l’inimmaginabile».
Prima di iniziare a suonare – ogni volta che lo facevano, non la prima in assoluto – Miles o Coltrane non immaginavano. Poi procedevano a costruire non solo sulla memoria (quella serve per le regole, mentre fare jazz vuol dire conoscerle e negarle, anche) ma sullo scarto imprevedibile, sulla deviazione, sull’errore. Così scoprivano nuovi mondi, nuovi suoni, nuove realtà.
La scrittura si basa su regole ma non è un martello alla ricerca di chiodi. Per ora i LLM e l’Ai lo sono – martelli per piantare chiodi – che però finiscono per essere involontariamente jazz: associano idee distanti e non visibili a occhio umano e sono vascelli capaci di spingersi ai confini dell’oceano della conoscenza per tornare in porto con storie e creature inimmaginabili.
La scrittura umana gli dà ordine e li colloca, o cerca legami. Scopre che non c’è un errore nel tagliare lo scalogno e nell’ascoltare del jazz, che le cose sono collegate, anche se i legami sono flebili, anche se non sembrano esistere.
Tutto è legato e l’incongruenza non è un errore ma è piuttosto una connessione debole, un segnale appena percepibile.
Che può essere scritto, per creare una nuova memoria e per cercare di capire non come avviene la vita, ma perché avviene.