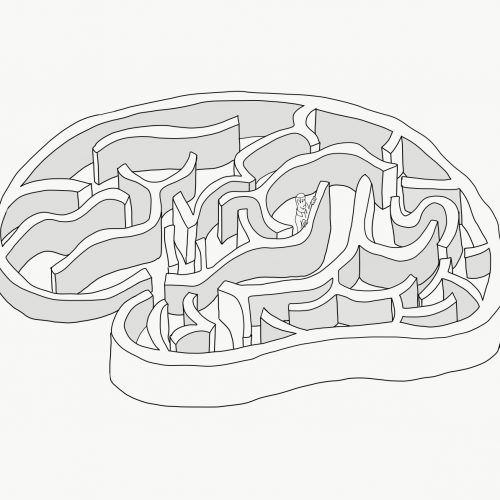Nel mio diario quotidiano appunto sempre più spesso che ho notato una foglia. Non la stessa, mai la stessa. Però c’è sempre più spesso una foglia. Penso che sia il dettaglio più minimo e irrilevante che si possa notare ogni giorno, e forse per quello la noto.
Una foglia bagnata dalla rugiada notturna, una foglia secca chissà da quanto su quel marciapiede, una foglia che è caduta giorni fa, una che è appena caduta.
Le foglie, mentre se ne stanno sui rami, sono foglie di un fogliame, sono elementi meno importanti del tutto (il fogliame) ma quando planano dolcemente a terra – e lo fanno per mesi, da quando iniziano a cadere – acquistano una diversa dignità: sono singole foglie meritevoli di essere notate, l’una diversa dall’altra, ognuna con una sua storia e una sua forma e una sua decomposizione.
La decomposizione lascia qualcosa, è più importante ciò che rimane di ciò che se ne va, che scompare. Le foglie che si accumulano sui marciapiedi a un certo punto scompaiono. Le hanno rimosse o si sono decomposte: sono diventate altro. A volte penso di conoscerne una per una. Le noto al mattino presto quando – ogni tanto – mi capita di prendere un treno. O più tardi, quando ne vedo una che è sfuggita alle pulizie del mattino, alla rimozione dell’eccesso, del non pertinente. È sfuggita alla scopa o alle spazzole rotanti del mezzo meccanico che la scosta, la avvinghia, la inghiotte. Resiste, come un’idea. Era un elemento del fogliame e ora è una foglia, anche se è nella sua ultima palpitazione vitale. Cambia colore, inscurisce, diventa fragile come carta. Eppure è: una foglia.
Le foglie sono come idee: prese insieme sono tante idee indistinte, considerate nella loro singolarità sono idee. Buone, brutte, splendenti, oscure, bagnate, secche. A un’idea si possono applicare gli attributi di una foglia, ecco perché dico che le idee sono foglie, e viceversa. Sono fragili, leggere, sanno volare.
Ascoltavo una conferenza. La relatrice diceva “Di questa cosa [un fatto, i cui dettagli non sono importanti, ora] s’è raccontata solo una parte della storia. Di come poi è finita nel nulla ed è anzi stata sovvertita e annullata se ne parla di meno o per niente”. E invece di pensare che fosse odioso che una bella idea fosse stata negata e sovvertita, ho pensato che aveva un senso – era pure meglio, molto meglio – che non si sapesse che quell’idea era morta e che qualcuno l’aveva uccisa.
A essa era sopravvissuta l’illusione che avesse funzionato, che l’avessero adottata anche altri, altrove, distante migliaia di chilometri. Quello contava della storia. Di ogni storia conserviamo le parole che ci parlano. Della fine di quella storia, di cosa sia diventata, se sia diventata una storia diversa possiamo anche non curarci. Le idee galleggiano sulle onde delle storie, e alcuni le notano e le portano in salvo.
Alcune persone ne vedono il decadere e il morire, altri ne conservano un ricordo che genera altre idee. Non sanno come è finita quella storia, ma una parte del racconto – quello che precedeva il tracollo – le ha rapite ed è entrato nel circolo di quei ragionamenti.
Per questo si può guardare una foglia sul selciato e non trovarla interessante, oppure vederla e iniziare a ragionarci attorno.
Un altro dei pensieri che mi accompagnano da sempre è quello della consequenzialità delle scelte che facciamo. Se adesso sto scrivendo queste parole è perché tutta la mia vita e le scelte che ho fatto mi han condotto esattamente in questo punto, a scrivere queste cose. È un esempio molto potente che mi è tornato alla mente giorni fa quando ho visto un meme che diceva pressapoco questo:
Ogni decisione che hai preso nella tua vita ti ha condotto a guardare questa immagine oggi.
E l’immagine era quella di Bombur, un personaggio del Signore degli Anelli che osservava famelico una pila di formaggi. Puoi trovarti a fare la cosa più stupida o più epica del mondo e il senso della tua vita fino a quel momento era arrivare esattamente in quel punto della storia, alto o basso, sacro o profano che sia. Deprimente ma anche entusiasmante.
La differenza, come succede con la foglia, la fa l’accorgersene. Ridere di quel meme e non pensare che sia poca cosa (o anche deprimente il farlo) rispetto ai magnifici programmi che si avevano. Non è poca cosa: dice quanto si sa cogliere l’ironia, il lato divertente delle cose, la delicata leggerezza di una foglia.
A me non pare cosa da poco ed è di ognuno, basta esercitarla. Osservare, annotare, vedere le cose e non attraversare la vita prendendosi i pugni del destino in testa restando quieti.
E soprattutto: vedere anche quello che è non esplicito ed evidente: la volontà della foglia di essere, la forza di una idea che sopravvive alla distruzione di ciò che ha generato.
E questa osservazione conduce a tre (quattro, anzi) considerazioni finali, un po’ più globali ed estese. Mi è capitato di farle in questi giorni, assistendo all’accelerazione cui è sottoposta la realtà politica (che nasconde, più che rivelare la sua forza di cambiamento – anzi, rivela semmai la debolezza intellettuale di chi la mette in pratica).
1. La crisi della responsabilità
Non entro nel dettaglio politico perché è noto e non mi interessa approfondirlo o aggiungere rumore al rumore. Noto gli effetti sistemici: l’annunciare cose, il farne mille uccidendo nel frattempo qualsiasi forma – anche minima – di empatia, non curarsi di niente se non di un programma di distra(u)zione di massa giustificato da un mandato popolare impugnato come una clava.
Il fatto che si possa fare qualcosa non significa che la si debba fare.
Il che conduce alla seguente considerazione.
2. La mancanza di idee
Prima o poi il fatto di non avere idee si nota. All’inizio il sospetto che vi sia una strategia aiuta a confondere, ammantando l’implacabile avanzare del programma come, appunto, aderente alla strategia. Quale, non è molto chiaro o forse è meglio che non sia chiaro.
I politici odierni – specie quelli di destra, quelli di sinistra sono ancora là a commentarsi l’ombelico e chi ce l’ha più bello – sono come molti libri di saggistica americani: una sola idea (un paio, quando va bene) ripetuta all’infinito. Ne capisco il motivo: per la soglia di attenzione media oggi, anche una sola idea è troppo, e se ha la forma di una clava è pure meglio, si capisce con più facilità.
Le ideologie non hanno reso un buon servizio alle idee, e il peggiore è stato confondere ideologie e idee, che non sono la stessa cosa.
3. Cos’è l’intelligenza
L’esistenza di una strategia è sempre più letta come un’evidente dimostrazione di intelligenza. Chi ha una strategia è anche intelligente, o almeno così si pensa. Ora: non è scontato averne una e il più delle volte si è talmente occupati a restare a galla che l’unica strategia è, appunto, restare a galla. In questo mondo di sommersi, avere un piano sembra già qualcosa.
Esplicito o meno, quelli che hanno il potere sembrano averne uno, e un piano è la forma di una strategia. Parte della confusione imperante – al di là della velocità con cui fanno avvenire le cose (che è una tattica, se vogliamo scomodare ancora Sun Tzu) deriva dal fatto che la strategia non è esplicita, o pare puntare ad altro, o adombra il sospetto che non vi sia strategia, se non rompere tutto – ops, pardon, disrupt – e vedere cosa resta in piedi. L’assunto è, immagino, constatare che quello che rimane in piedi è quello che serve. Che è un po’ come segare un pilastro alla volta a un grattacielo per vedere quanti ne servivano alla fine. Auguri.
Il fatto è che nessuno con un minimo di intelligenza sa davvero che forma ha il futuro e, altrettanto, sa che immaginarlo è un modo per dargli forma, pur conservando una dose abbondante di aleatorietà. Non è che più ci pensi, più quello prende la forma che vuoi. Non funziona così. Poi c’è quella cosa dei sistemi complessi e del fatto che governarli è impossibile e, insomma: non è facile, è quasi impossibile.
L’intelligenza significa sapere di non sapere, e agire partendo da questo presupposto. Quelli considerati intelligenti sono solo furbi e astuti, che è anche una forma di intelligenza – non discuto – ma di qualità un po’ più spiccia, diciamo.
In sintesi: essere astuti non significa essere intelligenti. Il che non toglie che si possa essere intelligenti e anche astuti, ma l’astuto pensa sempre di saperne una in più della volpe, o pensa di essere la volpe. La volpe invece è intelligente, e sa che sei astuto, ed è talmente più astuta da far credere di essere stupida. Ma basta con Esopo.
4. Il ragionamento socratico
L’ironia, la confutazione, il dialogo, la maieutica. Si potrebbe partire dall’ironia per capire quanto i tempi correnti – o i potenti dei tempi correnti – ne siano privi. Socrate partiva da quella e dall’ingenuità (vecchia volpe) per poi giungere – o tentare di – a una forma di verità condivisa, attraverso la confutazione e il dialogo.
Non mi pare si usi molto più, specie in un’era storica appropriatamente definita “della post-verità” o dell’ipnocrazia (come la chiamerebbe Jianwei Xun, e come la descrive magnificamente nel suo omonimo libro). Oggi Socrate sarebbe impegnato a discutere della validità di infinite definizioni alternative della verità, e impazzirebbe. Figurati noi.
Ma torno sull’ironia, che è una parte del metodo socratico: fingersi ignoranti, fare domande apparentemente stupide, cercare in fondo di capire. A me pare che di domande se ne facciano sempre di meno e che le persone siano sempre meno disposte a dare risposte.
Ho pensato insomma che l’ironia è un’arma e una salvezza, ed è particolarmente potente verso chi non la possiede. Non sarà definitiva, non sarà risolutiva ma promette di far divertire. Farli impazzire, prima che facciano impazzire te. Gli intelligenti lo sanno fare, gli astuti meno.
Guardo la foglia, annoto che l’ho guardata. È più importante il fatto che esista o che io scriva di averla notata? Sono indifferente alla natura (la natura non si cura di me, come di tutti) e la foglia sta, incurante.
Mi ha parlato, a modo suo. E tant’è.