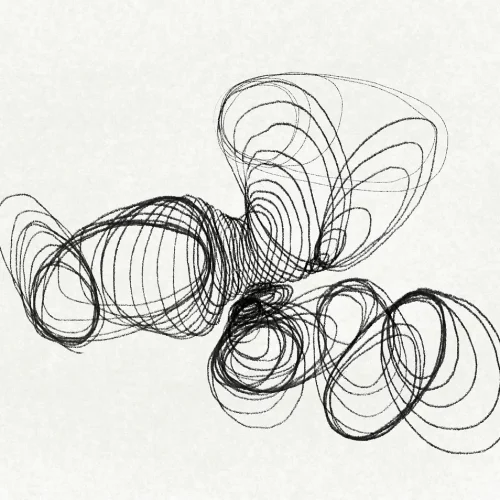Anni fa ero a Urbino. A Urbino passeggi e ti inerpichi o discendi, guardi le colline che la cingono dai cannocchiali naturali che le sue vie formano e poi sali a Palazzo Ducale. Mentre lo fai – di salire a Palazzo Ducale – mediti sul fatto che quelle colline lì attorno non sono affatto diverse da quelle che dipinsero gli illustri pittori del Rinascimento, anzi: sono proprio quelle. Si sono conservate immutate: i calanchi, gli orridi, le cime dolci e rotonde, i crepacci, i prati e i boschi. Pare tutto uguale. (“orrido” è un’altra parola interessante).
Mentre passeggiavo per le sue sale, a un certo punto mi trovai di fronte alla Flagellazione di Piero della Francesca. Non ricordavo né sapevo che fosse custodita lì, quindi lo stupore fu eguagliato dall’ammirazione di quell’opera sublime, tanto che non saprei dire se fossi più deliziato dal contemplarla che dalla sorpresa di trovarmela di fronte, improvvisamente.
La Flagellazione è in realtà una tavola di piccole dimensioni: misura 58,4×81,5 cm. Ho controllato perché non lo so a memoria, anche se avrei indovinato bene o male quanto grande fosse: non tanto, o non di certo tanto quanto la meritata fama che ha.

Vi rimasi di fronte a meditare per un bel po’ e pensai diverse cose.
La prima fu che aveva una forma irregolare, vagamente trapezoidale. Il lato sinistro è inclinato a formare una base più corta rispetto al lato superiore, quindi si tratta di un trapezio rovesciato.
Non che conti, se non per il fatto che mi fece ricordare quando con mio padre misuravamo assieme a compìti storici dei disegni di Carlo Scarpa. Mio padre misurava e declamava i numeri relativi e questo storico li annotava. Il fatto è che a volte glieli comunicava scambiando l’ordine della base e dell’altezza. Lo storico gli disse che esisteva una regola scientifica, e che la base veniva sempre per prima, che quindi gli dicesse prima quella. “E se i lati non sono uguali?” disse mio padre, “In che senso?” chiese quello, “Nel senso che questo (e indicò una velina strappata in modo impreciso, probabilmente nella foga della creazione) è un trapezio”. “Comunque si misurano base e altezza, considerando la lunghezza del lato maggiore in caso siano diseguali”, rispose quello stizzito. “Quindi non si annota il lato minore”, incalzò mio padre “Non mi sembra molto scientifico come metodo”, e ridacchiò divertito. Lo studioso non rise.
Ci ripensavo, appunto, perché la misura ufficiale della Flagellazione non dice che in realtà si tratta vagamente di un trapezio, anche se il dipinto in sé sta in un rettangolo regolare. Questione di supporto, poco male.
Allora capii che stavo vivendo un’esperienza un po’ diversa dalla pura contemplazione di un’opera somma. Ero di fronte a un varco spazio-temporale perché di fronte a quel quadro, alla stessa distanza a cui mi trovavo io osservandolo, 570 anni prima, c’era Piero della Francesca. Esattamente dove sostavo io, pensando a quella forma irregolare, alla minuzia del tratto e alla ricchezza di dettagli, cercando di cogliere il simbolismo che di certo mi sfuggiva in molte parti, ecco, proprio lì per un certo periodo del 1450 c’era lui.
Ogni quadro ha un autore, ogni quadro deve essere eseguito da qualcuno, quindi l’esperienza può essere rivissuta da chiunque si trovi in presenza di un’opera manuale.
Questo miracolo della compressione del tempo avviene in forma mediata e meno potente nella riproduzione di un’opera: una copia meccanica può assomigliare più o meno precisamente all’originale ma di certo non si può dire che di fronte a essa vi sia mai stato il suo autore o la sua autrice. Quel filo che collega le dimensioni temporali e non si esaurisce mai fintanto che l’opera esiste si rinnova a ogni osservazione. C’è sempre.
Piero della Francesca continua a vivere di fronte alla sua opera, anche se è trasparente, non fisico. Eppure c’è, perché c’è stato.
Questo è un potere dell’originale: è un’energia che continua a emanare perché la pagina scritta a mano da uno scrittore ne conserva la pressione del pennino e la tavola o la tela ricordano ogni pennellata, ogni stesura di colore, ogni istante impiegato per dipingere proprio quel segno, proprio quella sfumatura.
L’opera d’arte cattura il tempo e non lo lascia più sfuggire, ecco cosa stavo osservando.
Non è una cosa da poco e non mi vengono in mente molte altre esperienze che ne siano capaci. È un potere dell’arte, suppongo.
In questi giorni riguardavo anche foto personali, fatte ormai più di 10 anni fa. Questa volta ero io Piero della Francesca, non nel senso del talento ma in quanto autore. Ho osservato che ne davo una lettura diversa da quella che intendevo al tempo, quando le feci. A volte non ricordavo di averle fatte, a volte cercavo di ricordare lo stato d’animo che avevo quando le scattai. Non lo ricordavo quasi mai, né ricordavo esattamente il momento. E allora mi sono chiesto che tempo catturavano quelle immagini, e se erano in grado di imprigionarlo come la Flagellazione. Ripeto: non è un paragone, mi interessa solo capire se la forza di un’immagine è tale da sconfiggere il tempo, o almeno da sottometterlo.
Da quelle immagini affiorava ciò che non immaginavo al tempo, quando le scattai. La memoria non ricostruiva l’esatto momento e quindi il loro significato – quando ne avevano uno – era indipendente dalla mia mente: viveva di propria energia, era ciò che aveva deciso di essere. Eppure quelli erano i miei ricordi, ma in un certo senso erano diventati ricordi di un’altra persona, pur se indefinita.
E allora ho pensato che con la fotografia o con l’arte scriviamo lettere al nostro Io futuro. Non lo conosciamo né possiamo sapere cosa mai penserà ma gli diciamo cose che forse riuscirà a capire, anche se nel presente non le capiamo.
Cerchiamo – cerco – tutti i modi possibili per fottere il tempo.
Rivedendo certe mie foto, mi dico che le ho fatte perché vi riconosco qualcosa, perché hanno un significato per me. E non è detto che mi sia chiaro ma ce l’hanno, anche se lo scoprirò solo nel futuro, se mai lo scoprirò.
Onore al merito all’immagine, e non all’autore, quantomeno nel mio caso.
Nel caso di Piero della Francesca il merito mi pare indiscutibile, e infatti la sua capacità resiste e si rinnova nei secoli dei secoli.
Si tratta dell’aura, della potenza evocativa dell’originale, come dicevo prima e come diceva Walter Benjamin. Che è quella persa nella riproduzione o nelle mostre immersive che si fanno spesso negli ultimi anni, che mi sembrano un modo per cercare un’identificazione fra l’osservatore e l’opera rendendola apparentemente più comprensibile (esplorabile!), ma tradendo così la sua essenza, che è di essere unica.
Un’opera si può riprodurre perfettamente, salvo nel suo essere un originale.
È una constatazione ovvia eppure è ciò che decreta la superiorità dell’originale sulla sua copia: davanti a quello c’era chi l’ha fatto, davanti alla copia non c’è mai stato nessuno.
Il che farebbe pensare che l’originale evochi una precisa dimensione, o spieghi un costrutto non banale: il tempo esiste solo quando lo si può esperire.
Il tempo umano almeno, cioè quello subìto e quello applicato all’esistenza, esiste solo perché viene percepito e all’interno di esso si vive. Altrimenti non esisterebbe, o non sarebbe così rilevante.
Del resto ci si pensa e lo si subisce o sfrutta o teme perché c’è la morte a dargli una dimensione.
Il tempo ha una dimensione perché ha un’ inizio e una fine. Il tempo del cosmo non esiste, o il cosmo è indifferente al tempo.
L’aura di cui scriveva Benjamin è insomma – oltre che la forza che scaturisce da un originale, rendendolo insostituibile – una condizione che si crea solo quando l’opera originale e l’osservatore si ritrovano nello stesso spazio. Al di là della capacità democratizzante della riproduzione, che è sempre benvenuta.
E si ritorna a una dimensione fisica e metafisica insieme. Fisica poiché unisce spazio (quello in cui l’opera è osservata da occhi umani) e tempo, che è duplice: è quello in cui si compie l’atto dell’osservazione ed è quello catturato dall’opera stessa. E metafisica poiché si eleva al di sopra del contingente, rendendo superflui spazio e tempo. Nella dimensione matafisica spazio e tempo non contano, sono annullati.
Inoltre, e infine, il miracolo del tempo fermato è possibile solo quando qualcuno osserva: durante la notte, la Flagellazione torna a essere un quadro dipinto su una tavola vagamente trapezoidale, in una sala del Palazzo Ducale di Urbino. Il flusso del tempo può essere fermato solo quando un osservatore la osserva, immagina Piero della Francesca a dipingerla cinque secoli e mezzo prima e, al suo fianco, rievoca quel tempo passato e ne collega i lembi a quello presente.
Il varco è aperto e ci si trova di fianco a Piero della Francesca a osservarlo. Si guarda nell’abisso dell’arte, si respira mentre tutto attorno smette di danzare e fare ed essere. Si respira, mentre il tempo trattiene il respiro.