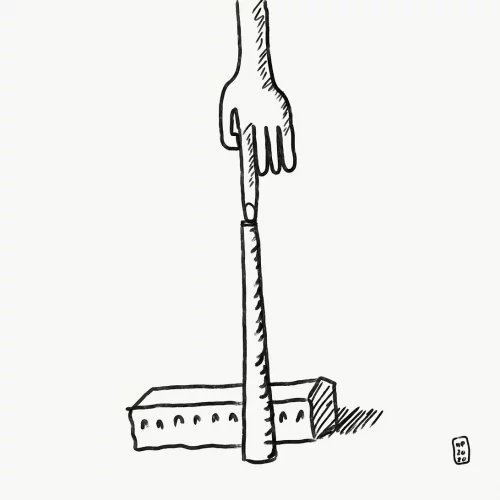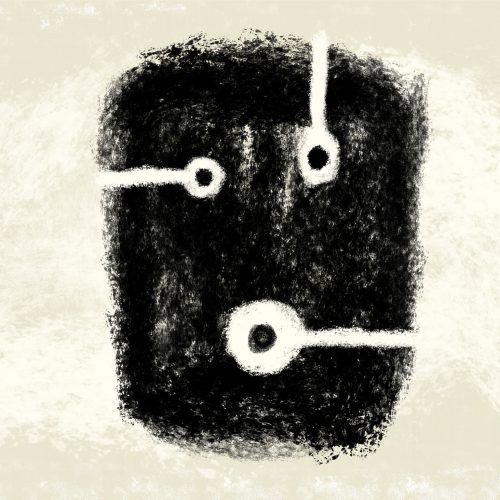Nel 1970 John Baldessari bruciò tutta la sua produzione, o almeno quella dal 1953 al 1966. Poi raccolse le ceneri di tutte le opere e ci fece dei biscotti. Di tutta la sua arte – fino a quel punto – fece un’opera d’arte chiamata “Cremation Project”, che consisteva in foto della cremazione (delle opere), in una targa che ricordava la nascita e la morte dell’artista che era stato fino a quel punto – o almeno in quella fase della sua vita – e nella ricetta dei biscotti.
Dall’arte ricavò arte, che parrebbe anche un po’ cinico o opportunistico magari. Ma era anche una specie di ecologia dell’arte, nel senso che da arte ne ricavò arte, che non buttò via niente.
Insomma, ne fece una cosa molto interessante.
A dispetto dell’ironia scanzonata del personaggio – ben narrata nel brevissimo e geniale documentario letto dalla voce dell’amico Tom Waits (“John Baldessari ha voluto che questo documentario fosse narrato da me, Tom Waits”), la sua arte è molto concettuale e non particolarmente penetrabile, almeno all’inizio. Usa molto la fotografia e soprattutto – specie dopo la celeberrima cremazione – i dots, cioè i bolli adesivi da cancelleria, colorati e gioiosi, con cui obliterava le facce dei personaggi nelle sue composizioni. Se potesse tracciarsi un parallelo ( lo sto facendo ora) fra lui e Isgrò, potremmo dire che questo oblitera le parole (le sue famose cancellature) mentre Baldessari cancella i volti.
Ma questa è la declinazione che ha preso la sua arte dopo la cremazione, che oltre che un’ottima e audace performance artistica, gli permise anche di morire e rinascere, almeno artisticamente. Molti artisti attraversano diverse fasi evolutive – molti altri rimangono incastrati nella stessa che magari ha dato loro notorietà e danaro, e non vi si scollano più. Lui invece non solo superò una sua fase ma la incenerì, letteralmente. Facendone a sua volta arte, ma questo l’ho già detto.
Quello che è più interessante di quel gesto – al di là dell’averne fatto un’opera d’arte in sé (generare arte dalla distruzione dell’arte) è che non solo rappresenta un tipo di morte ma è, a tutti gli effetti, un decesso: la fine di un filone espressivo e delle opere che lo rappresentano e anche la fine simbolica di un artista, almeno fino a un certo punto temporale.
Baldessari insomma fece della morte un’espressione artistica, cioè la governò. La usò, decidendo di farci quel che voleva. In un certo senso vinse sulla morte. Poi, con l’ironia che di certo non gli mancava, ne fece dei biscotti.
Si può decidere di morire in pochi casi: fisicamente suicidandosi o praticando (o facendosi praticare) l’eutanasia e, artisticamente, distruggendo ciò che si è prodotto. Del resto non è stato neanche il primo a farlo, semmai è stato il primo (non lo so con esattezza) a far diventare quel gesto un’opera d’arte.
Ricordo che anche Munch aveva un rapporto un po’ conflittuale con le sue opere: le lasciava all’aperto, a prendere polvere e aria e pioggia. Una forma di morte diluita, una lenta distruzione per incuria programmatica. Era anche convinto che il tempo – il deposito del tempo in forma di polvere, pioggia, detriti – le modificasse e vi aggiungesse qualcosa. Coinvolgeva il caso e il tempo nel processo creativo, aumentando il livello di casualità: il risultato finale non era prevedibile e proprio quello cercava, voleva insomma incorporare nelle sue tele più elementi casuali possibili, attribuendo loro una responsabilità artistica che esulava dalla sua volontà. Quella che praticava era una specie di morte per procura, o almeno un anticipo di morte.
Ma non credo abbia mai pensato di farsi fotografare mentre lo faceva. Le lasciava all’aperto a marcire, lasciava che la natura facesse il suo corso.
Il caso di Baldessari mi sembra diverso: lui decise come inscenare la morte e come coreografarla. Alla cerimonia c’erano i suoi amici. Dalle ceneri di tanti anni di pittura – che ormai rifiutava poiché si stava orientando sempre più verso l’arte concettuale – ricavò i biscotti, conservati nella sua prima opera concettuale vera e propria: un’urna di vetro.
Insomma, era qualcosa di diverso.
Sarebbe interessante poi capire quanto la morte dell’opera sia anche la morte del suo autore. E se è egli stesso a praticarla? È una violenza domestica? Quanto c’è di un artista nelle sue opere? Tutto, direi. E quel Baldessari non esisteva più. Quello nuovo nasceva con un’opera concettuale: una performance che metteva in scena morte e rinascita, sotto forma di biscotti, di un’urna e di una targa commemorativa.
Ma non è nemmeno questo il punto. Il punto è – credo – che l’arte superi la morte, o quantomeno la domini. Può metterla in scena, praticarla e risolverla, facendola diventare un principio creativo, e questo mi sembra che dica la performance di Baldessari: morire per rinascere, come e quando decide l’artista.
È anche un principio di volontà non trascurabile: l’essere umano attraversa molte fasi ma sono spesso subite più che pianificate, o vengono modellate dai casi e dagli accidenti. Si cambia lavoro, si cambiano le relazioni, si cambia direzione ma senza un piano preciso. O magari esiste e lo si segue inconsciamente, mentre Baldessari lo mise in atto. Aveva una visione, e delle contingenze: doveva trasferirsi a insegnare altrove e non sapeva dove mettere tutto quanto fatto fin lì, che poi ormai non lo rappresentava nemmeno più.
Mise in atto una piece teatrale nata probabilmente da un’ironica intuizione (l’ironia, ripeto, non gli mancava): liberarsi di tutto, ma facendone arte.
A quel punto poteva decidere di fare qualsiasi cosa di quelle ceneri: una statuetta votiva, un busto al sé stesso del passato, una croce, l’urna stessa. Invece ci fece dei biscotti. Ironico e irriverente (verso l’arte forse, ma era la sua arte, poteva decidere di farci qualsiasi cosa, specie dopo averla bruciata) ma anche simbolico: ne fece cibo. Il fatto che non fosse commestibile è trascurabile: è il significato che conta, non la funzione.
L’arte, del resto, non ha una specifica funzione, o è autoreferenziale, direi anzi autofunzionale. In sé raccoglie il suo stesso significato e quei biscotti erano non solo un concetto ma anche la sostanza.
Dandosi la morte (per quanto artistica), infine, si decide anche di rinascere. Cosa impossibile da fare nel caso di morte di sé, ovviamente. Però insegna anche che l’ego artistico può essere eliminato e rinascere, che può cambiare.
Più penso al Cremation Project e più lo vedo come un progetto esistenziale e non solo artistico. Come una celebrazione della vita e delle mutazioni possibili. E anche come la capacità di camminare lontani da sé, di vedersi da distante, nella nostra irrilevanza. Il passato può essere distrutto ma l’atto (e il passato) ha senso solo se si trasforma in cibo. Deve alimentare il nuovo Io.
È una trasformazione, o la sua celebrazione, e deve concludersi con il sostentamento necessario per cominciare la nuova vita: il cibo.
Dopo quel progetto Baldessari diventò concettuale: usava video, foto, fotogrammi. Applicava i suoi dot, obliterava, cancellava e faceva così emergere significati nascosti. Scomponeva i gesti (il lancio di un peso, un golfista nell’atto di colpire la palla). Analizzava ed esponeva. Aveva – mi piace pensare – la curiosità di un bambino che smonta un giocattolo e cerca di capire come funziona. Il risultato è a volte incomprensibile: di un gesto vediamo l’inizio e la fine ma quello che c’è in mezzo – la storia vera e propria – è meno esplicita.
Baldessari scelse di raccontare quelle storie, portando l’attenzione su ciò che è trascurato o invisibile. Del resto i concetti lo sono per natura: sono astratti, sono calligrafie applicate sull’aria. Bisogna smontare, capire, mostrare. E ogni tanto metterci un punto colorato sopra, a nascondere, per rivelare.