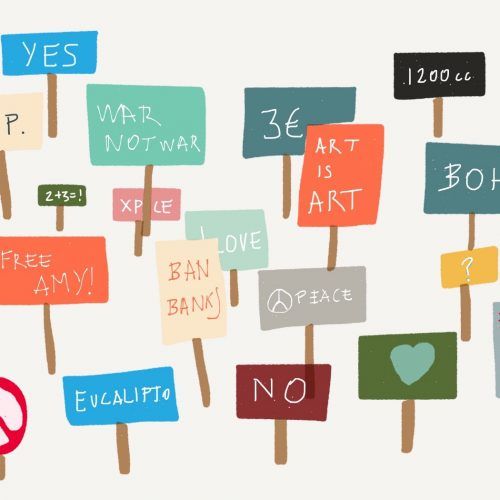“Con una delle mie studentesse di Harvard, Loralyn Thompson, decidemmo di fare un esperimento: distribuimmo ai pazienti un foglio che riportava un centinaio circa di descrittori di comportamenti e chiedemmo loro di cerchiare quelli che avrebbero voluto cambiare ma non ci riuscivano. Sull’altro lato del foglio, in un ordine diverso, c’erano le versioni positive di ciascuno di quei comportamenti. I pazienti dovevano cerchiare ciò che apprezzavano di se stessi. Così, da un lato c’erano parole come: incoerente, impulsivo, ingenuo, rigido e malinconico, e dall’altro: flessibile, spontaneo, fiducioso, stabile e serio. Come vi sarete già immaginati, per lo più gli aspetti che i nostri pazienti tentavano di cambiare senza riuscirvi, erano gli stessi che – se messi sotto una luce positiva – apprezzavano di se stessi.”
Ellen J. Langer descrive così in “Il corpo consapevole” un esperimento che aveva lo scopo di dimostrare – o almeno così l’ho letto io e lo conservo nella memoria – la dualità delle persone e quanto spesso, per non dire sempre, noi stessi non riusciamo a vederci altro che monodimensionali. Manchiamo insomma di cogliere la nostra profondità.
Se ci dovessimo descrivere, a ben pensarci, finiremmo per fornire di noi stessi una definizione che in parte è mutuata da come gli altri ci descrivono, cioè dall’immagine che proiettiamo e che vediamo riflessa di noi stessi.
A prescindere dal fatto che – per citare per l’ennesima volta David Foster Wallace – di noi agli altri non gliene frega molto, è interessante notare un sottotesto poco espresso di questo assunto: non siamo interessati a ciò che gli altri pensano di noi ma al loro giudizio. Non cerchiamo insomma negli altri una dimensione riflessa che possa fornirci indizi sulla nostra vera natura ma solo il giudizio che la società ha su di noi.
Pensiero e giudizio sono due cose molto diverse, ma è comodo o pratico confonderle.
Per ritornare all’esperimento iniziale: ciò che le persone riconoscevano in se stesse come difetto era anche definito come una qualità. L’unica differenza era il nome con cui queste caratteristiche erano chiamate. Chi si riconosce come poco istintivo e troppo riflessivo può altrimenti definirsi come un ottimo osservatore, chi è poco espansivo può altrimenti considerarsi rispettoso dei confini altrui.
Abbiamo diversi lati o forse è meglio dire più opposti: i difetti sono quelli immediatamente visibili nel riflesso sociale (cioè in come gli altri ci vedono o pensiamo che ci vedano) mentre i pregi emergono solo dopo una lettura più articolata, che giunge a sostenere che:
- L’opposto di un difetto può essere un pregio
- Conteniamo opposti
- Il negativo è un’immagine riflessa, e per di più filtrata attraverso il giudizio personale (che non è ciò che gli altri pensano ma ciò che pensiamo che gli altri pensino, cioè una specie di inception del giudizio, per di più presupposto).
Riporto questi ragionamenti perché ci ho riflettuto ultimamente e non nego che l’idea che i difetti siano pregi è un ottimo esercizio per l’autostima. L’unico difetto è che non funziona in tutti i casi e può non incontrare l’accordo e la comprensione altrui ma per il bene della scienza e di queste parole qui dette immaginiamo che funzioni alla perfezione.
La parte più interessante mi pare essere quella del giudizio sociale. Ricostruendo il ragionamento:
- L’immagine che abbiamo di noi è un’immagine ma non siamo noi
- L’immagine rappresenta noi, riflessi nel contesto sociale
- L’essenza individuale è libera dalla componente sociale.
Ora: come è possibile annullare il contributo della dimensione sociale alla percezione di noi stessi?
Una delle forme di conoscenza innate è quella per affinità, che è contraria a quella per differenza. Ci si identifica e riconosce in altri caratteri (persone) simili o ci si definisce in quanto diversi da altri.
C’è però un’altra forma di conoscenza più emotiva e profonda che supera (o non attinge) alla dimensione razionale e al confronto. Esistono persone o condizioni che mettono in vibrazione il corpo psicologico (con questa espressione intendo un insieme più ampio della sola mente, come se la mente non fosse solo contenuta nella scatola cranica ma avesse un’intelligenza che si espande a tutti i sensi del corpo). Non è detto che sia scontato incontrarle né tantomeno inevitabile: si potrebbe vivere una vita intera pensando che l’unica dimensione sia quella sociale e che l’essenza individuale si risolva nel riflesso in questo unico ambito.
Quando però capita di intercettare questi altri corpi psicologici si entra in risonanza e si percepisce una natura intima più complessa e profonda cui la superficialità del contesto sociale non può attingere.
Non è una risonanza razionale o almeno non è percepita come tale. Non si esprime in un lampo di chiarezza inequivocabile. Direi piuttosto che emana bagliori di colori quasi violenti e impossibili da ignorare. Cose non usuali.
Anche se il contatto di queste orbite esistenziali potrebbe far pensare che si tratti comunque di un’esperienza sociale, non è esattamente così: può accadere anche con uno spazio o una musica. Sono esperienze che provocano reazioni e che manifestano una natura dell’individuo che la sintesi della società non può cogliere. È una condizione in cui non valgono le regole della convivenza e dell’opportunità, e precede la razionalità. È animale e innata, appunto.
Innesca un riverbero, una vibrazione.
Giorni fa mi sono ritrovato davanti a un quadro specchiante di Pistoletto. La figura ritratta era quella di un uomo di spalle. Queste opere concettuali – come la buona arte contemporanea sa fare – richiedono la presenza dell’osservatore giacché lo portano dentro l’opera stessa. Osservando questo specchio ci si ritrova riflessi e quindi si fa parte dell’opera d’arte. Si potrebbe dire che essa non esisterebbe o non esaurirebbe la sua funzione se non la attivasse l’osservatore. Un aspetto interessante di quest’opera è che l’uomo di spalle non è riflesso: di lui non si vede il volto ma solo ciò che lo specchio non fa mai vedere: la schiena. Lo specchio può riflettere solo un lato e quindi una sola dimensione. Lo specchio non ha profondità. L’unica figura riflessa è quella dell’osservatore.
Mi sono guardato riflesso in quello specchio e ho capito che quello che la persona di spalle stava osservando ero io, mentre io potevo osservare solo la sua schiena. Si tratta insomma di un curioso specchio che non riflette una figura e ne riflette solo un’altra (quella dell’osservatore, che inoltre vede il lato oscuro della luna, cioè quello che lo specchio non può vedere).
L’arte contemporanea riesce a tradurre in un’immagine quanto ho detto in molte parole sin qui: che siamo corpi (psicologici) con più dimensioni e con almeno due facce opposte. Che non siamo definiti da un’unica dimensione. Che, infine, più che il giudizio o il pensiero della società, dovremmo cercare ciò che fa riverberare questo corpo impalpabile che conteniamo. E che difficilmente possiamo conoscere. Un modo è pensare di essere composti da opposti. Un altro è vibrare, cercando di vedere la nostra stessa schiena.