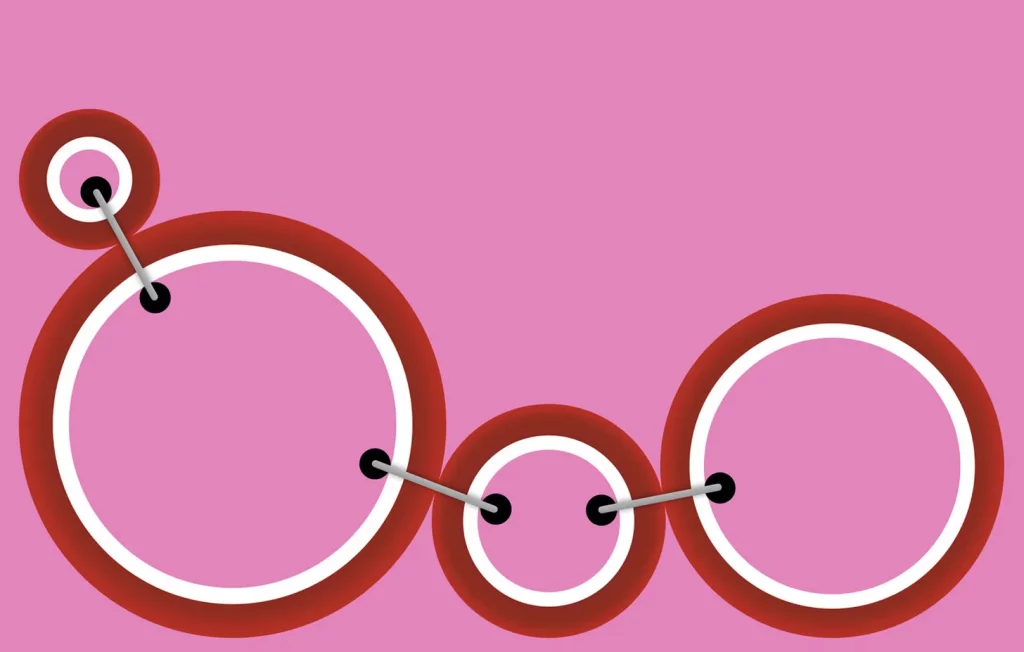Quando si legge Design per il mondo reale di Victor Papanek bisogna spesso controllare la data di pubblicazione. Sembra un libro scritto qualche mese fa e invece è stato pubblicato la prima volta nel 1971. Lo sembra sia per la qualità della prosa e l’acutezza di Papanek ma soprattutto per gli argomenti che tratta, molto spesso riguardanti l’ecologia e la sostenibilità della vita umana sul pianeta, inquadrati nell’ottica del ruolo sociale del design.
Questi argomenti fanno parte da anni del dibattito pubblico e tutti – compresi i negazionisti, anzi, a maggior ragione proprio loro – non possono fingere che il problema non esista. La capacità di Papanek di prevedere con così largo anticipo l’importanza di questi temi può testimoniare della sua brillantezza intellettuale ma anche della difficoltà o trascuratezza con cui sono stati trattati negli ultimi decenni. Se insomma se ne parla ancora dopo cinque decenni, significa quantomeno che i problemi non sono stati risolti e che solo oggi – finalmente – tutti o quasi capiscono quanto sia importante parlarne.
E questa non è nemmeno la qualità più importante di questo testo. Lo è molto di più l’approccio di Papanek alla professione e all’insegnamento del design, affrontato con profondità tale da far emergere quanto per lui sia integrato nell’esistenza umana. Per capirlo meglio vorrei parlare di cos’è il design e di cosa è diventato oggi, almeno in determinati ambiti.
Comunemente si considera il design come quello industriale, cioè la progettazione di “oggetti di design”: sedie, tavoli, divani, luci, oggetti per la casa, automobili. Questa convinzione – in verità frutto di una certa pigrizia intellettuale aiutata da una narrazione pluridecennale che solo quello ha voluto comunicare del design – riduce all’oggetto disegnato il dominio del design.
Il design serve a creare oggetti.
In questo senso non stupisce che Il Salone del Mobile di Milano sia ormai diventato la Milano Design Week, perdendo la connotazione limitante al solo design dell’arredo: in altre parole, dicendo “Mobile” si dice “Design” e viceversa (chi fa parte dell’ambiente dirà che questo discorso è sbagliato, non ne dubito ma il mio punto è un altro: il punto è come viene percepito il design oltre l’ambito del design stesso, cioè come comunica o è comunicato). Qualsiasi cosa vi venga esposta ha sempre più a che fare con un tipo di design e soprattutto con l’idea – che è puramente commerciale – che ne hanno le aziende, ossia di un’attività ancellare alle loro esigenze, che sono commerciali e basta. Il design serve a vendere il design stesso e quindi deve servire le aziende, e non gli utenti.
La verità è invece che il design è ovunque, e ciò che comunemente consideriamo design è una microscopica parte di ciò che è il design davvero, e nemmeno la più importante (si crede molto importante ma non lo è).
Un modo che ha trovato la Milano Design Week per mascherare la propria rilevanza marginale (ma totalizzante, nell’ottica di chi opera in quel settore) nel design è quello di fondersi sempre di più con l’arte. Basta infatti osservare quanto gli eventi più frequentati non siano quelli dove si presentano nuovi prodotti ma piuttosto quelli dove ci sono installazioni e apparizioni effimere. Non dico che non esista anche la parte di Salone/Milan Design Week più aderente all’idea classica di design (cioè di quello di prodotto) ma dico che è quella con meno risonanza mediatica, e che quindi incide di meno nel dibattito pubblico. È infine giusto specificare che mi riferisco in particolare al Fuorisalone, cioè all’insieme di eventi nati come alternativi al Salone principale (ora alla Fiera di Rho) e che in origine aveva una natura indipendente e artisticamente analoga, finché non è stato inglobato e normalizzato, mantenendo una parvenza alternativa. Per farlo ha dovuto diventare sempre più artistico, effimero appunto, “famolostranolo”, per usare questo neologismo inventato ora.
È infine inevitabile parlare di questo evento perché è forse il più importante al mondo, quindi lo faccio considerandolo in forma sineddochica (cit. Treccani), cioè usando la parte per parlare del tutto.
Sto esasperando un po’ i termini della questione per arrivare a dimostrare la mia tesi e ritornare al libro di Papanek. Non c’è niente di sbagliato nell’indulgere in certe sembianze artistiche: uso il termine solo per contrapporlo alla natura commerciale e utilitaristica del design di prodotto, laddove l’arte è tutto ciò che non è seriale. Se è artistico, insomma, può non avere alcuna utilità, mentre il design di prodotto deve rispondere a una logica pratica e a un bisogno.
Questo, per tornare alle basi, dovrebbe essere un fondamento del design: che risolva dei bisogni delle persone e lo faccia immaginando un futuro che non esiste ancora e che in certi casi non ha nemmeno radici nel presente. “Design”, del resto, è il termine anglosassone per l’atto del progettare che in italiano – grazie alle sue radici latine – ha un significato ben più evocativo: significa “gettare avanti”, proiettarsi in avanti, e quindi immaginare una realtà che ancora non c’è.
Si comprende lo sforzo necessario e anche quanto molto del design che viene celebrato abbia tradito questi fondamenti. Lo notava “(ecco che torno a lui) proprio Papanek, sostenendo che lo scopo del design è quello di rispondere alle esigenze dell’utente e non a quelle dell’azienda che commissiona un oggetto, anche perché lo scopo di questa è comprensibilmente quello di venderlo e il relativo profitto, quasi a lasciare sullo sfondo l’importanza della sua utilità per chi lo acquista.
L’impressione che si ha considerando molto del design attuale è che sia concepito per far parlare di sé più che per risolvere qualche problema espresso o inespresso. Non è un caso che lo si ammanti di un’aura artistica: perché così si può omettere di spiegarne il significato e l’utilità, oltre al fatto che si può dimenticarsi, volutamente, di spiegare a cosa serva.
Due considerazioni lo possono spiegare meglio.
- Che senso ha disegnare una nuova sedia, l’ennesima sedia, oggi? Non ho una risposta, o sì: nessuno. Vi sono così tante sedie che si può pensare che il numero totale delle loro varianti sia ormai esaurito. È un concetto ben espresso anni fa da Martino Gamper che ne disegnò 100 in 100 giorni, usando oggetti di recupero e ricombinandoli. Volutamente o meno, quello era un gesto artistico più che di design e, proprio grazie all’esorbitante numero di pezzi singoli prodotti, dimostrava la sua inutilità nell’ambito del design. Insomma: dichiarava l’appartenenza al domino dell’arte più che al design.
- Un evento come la Milano Design Week (ancora una volta: come sineddoche, non ce l’ho con lei ma la uso come simbolo e semplificazione) non prevede molto che esuli dal design di prodotto, eppure – come si diceva – il design è infinite altre cose. Il design è un po’ tutto ed è ovunque.
Riguardo al punto 2. faccio un esempio: non mi risulta che il calendario di eventi del genere preveda alcun cenno, per esempio, al design dei servizi. Posso capirne il motivo: non è molto instagrammabile, non è cool, tratta di cose spesso noiose e più difficili da mostrare. Questo tipo di design ha, per far capire, più a che fare con la pianificazione dell’esperienza utente di chi affitta una casa su AirBnb o con quella di chi acquista un biglietto per la metropolitana e come lo fa. Insomma: molto spesso coincide con il design di ciò che non si vede se non quando non funziona. Se non riesci a prenotare un posto in treno maledici il design di quel servizio, se ci riesci non ti poni minimamente il problema che vi sia del design dietro quell’esperienza.
Un altro esempio ancora più quotidiano di design? La posizione del tasto di invio in una mail: in basso a destra? In alto a sinistra? E di quale colore? Ecco, tutti questi sono esempi di design che non viene considerato come tale e che invece ha una diffusione molto più vasta e riguarda miliardi di persone. Specifico meglio: non viene considerato come design a livello del design di prodotto, non che in un’università qualcuno si sognerebbe mai di non considerarlo a tutti gli effetti “design”.
Papanek non parlava (ancora) del design di un’app: come biasimarlo, le app non esistevano nemmeno come concetto nel 1971. Eppure non mi stupirei se le annovererebbe a tutti gli effetti come una questione di design, se solo oggi fosse vivo. Perché lo sono, per concludere? Perché riguardano la risoluzione di bisogni delle persone, molto semplicemente.
Un altro bisogno che dovrebbe e potrebbe essere risolto è quello del costo degli oggetti di design, se vogliamo restare in quell’ambito. Un discrimine che colloca l’oggetto A nel dominio del design è il suo costo: se costa più di un certo limite è design, se costa di più di un prodotto B analogo è di design. È un criterio tassonometrico un po’ discutibile ma efficace: stabilisce che un oggetto è di design solo per il suo valore (percepito, e per il quale si è disposti a una transazione economica – cioè il concetto di valore nell’economia classica) e non per la sua utilità. Facile comprendere dove porti una logica del genere: a produrre oggetti sempre più costosi, perché sì. Si prenda a esempio sintomatico della questione un settore molto preciso della moda: quello delle sneaker, che hanno un valore percepito legato solo al brand e una qualità e utilità reali inferiori a quelle di scarpe da lavoro (ci sono scarpe da 6-700 euro che chiunque non conosca il brand che portano sul dorso potrebbe scambiare per scarpe antinfortunistiche, e trovo la cosa molto ironica). Eppure nel concetto corrente di design nessuno si sognerebbe di dire che non sono prodotti di design: anzi, lo sono proprio perché costano come un affitto di un monolocale a San Donato Milanese (ormai).
Che il design debba essere utile è evidentemente un concetto che fa inorridire, e allora gli oggetti disegnati (o di design, anche se di design hanno ormai poco o niente) vengono valutati per il loro significato estetico e il loro valore percepito. Che non dovrebbe essere prioritario o quantomeno non l’unico discrimine. Se l’estetica prende il sopravvento sulla funzionalità c’è qualcosa che non va ma a ben vedere quell’estetica a cui si fa riferimento è una veste piuttosto corta o trasparente: chiamarla così è una distrazione per dire che lo sguardo deve posarsi su quella più che sulla funzionalità e ciò è particolarmente vero in un’era in cui di estetiche ve ne sono infinite, senza che nessuna sia dominante. Se ci sono mille estetiche, alla fine non ce n’è alcuna, o vanno bene tutte.
Parlando di estetica si finirebbe a parlare di gusti e non se ne uscirebbe più. Io ho il mio e gli altri hanno il loro. Parlando di utilità invece ci si muove su un terreno più solido e dove le sfumature decidono di meno: una cosa è utile o non è utile, e se lo è, lo decide solo chi la usa.
Ormai si ironizza sul fatto che “design” sia un’etichetta che si appiccica ovunque per nobilitare una professione. Allora il pasticcere diventa “cake designer”, l’operatore di viaggi “travel designer” e chi traduce visivamente dati è “information designer”. Ho messo sullo stesso piano tre categorie professionali di designer che il design classico (industriale, di prodotto) inorridirebbe a considerare come appartenenti alla stessa famiglia. Credo che concederebbe questo status solo all’information designer, e posso capire anche perché. Invece voglio provocare, sostenendo che tutte e tre – e molte altre, delle più bizzarre – hanno dignità per essere chiamate “design”. Perché rispondono a un bisogno, che sia una torta o un viaggio o come e dove mettere i faretti nel guardaroba.
Concludo con una considerazione di Papanek, ironica come molto spesso gli capita(va). Nel secolo scorso il MoMA raccolse in cataloghi prodotti in diverse decadi ciò che reputavano esemplare del miglior design. Ciò che, in altre parole, era destinato a sopravvivere. Papanek parlò dei tre cataloghi che vennero pubblicati fino al 1971 e notò che dei più di 500 oggetti considerati come determinanti per il design dal MoMA, solo 10 sono sopravvissuti: non un buon segno per chi si fregia del titolo di arbitro del gusto (ma non, evidentemente, dell’utilità).
Questo non per dire che il MoMA non possa decidere in autonomia cosa è design e cosa non lo è, né tantomeno che non possa o potesse fare classifiche o liste, ma per dire che, specie nel design, cosa è tale lo decide chi lo usa perché gli serve a qualcosa, così come decide se è buono o cattivo design.
Se sopravvive è buon design. Se costa il giusto è buon design. Se risolve un problema è buon design. Altrimenti è qualcosa di diverso: a volte è arte, a volte è speculazione commerciale, a volte è un segno sulla sabbia, che resiste giusto il tempo che arrivi un’onda e lo cancelli.