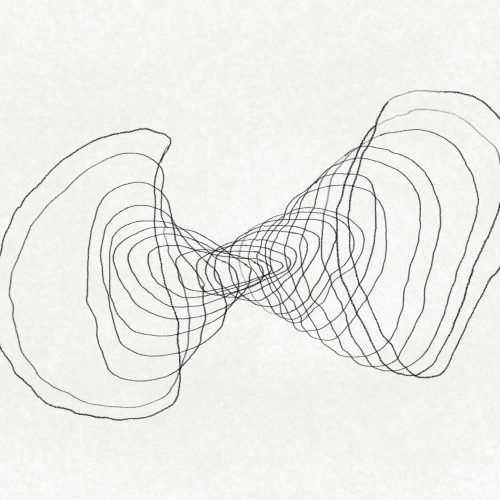Potrei partire dal non avere molto da scrivere e arrivare al non scrivere poi molto, ma poi alla fine potrei scrivere anche troppo, o a lungo.
Come ripeto sempre, so dove parto e non so dove finisco. O dove arrivo.
Per dire: ho iniziato a scrivere queste righe avendo in mente un titolo, che è come sempre una parola: alluminio. Non so perché l’avessi in mente. Mi piace l’alluminio, forse più di un metallo cromato. Le superfici satinate sembrano più consapevoli della loro bellezza estetica rispetto a quelle cromate, che han bisogno di riflettere l’esterno per credersi importanti, per sentirsi ciò che non sono. Sono semplici metalli, ma cromati. L’alluminio invece è consapevole di sé, è economico, è elegante. Non riflette e quindi accoglie sotto la sua superficie il riflesso dell’esterno, trattenendolo e non restituendolo più.
La cromatura protegge e non lascia penetrare, e solo ciò che è debole deve essere protetto.
Ho pensato alla debolezza esposta – e quindi umana, e quindi delicata e lodevole – qualche giorno fa, ascoltando un’intervista a Ben Stiller. Parlava dello stupendo Severance. A un certo punto dice che le critiche che la serie ha ricevuto – che oscillano quasi universalmente dal positivo all’entusiastico – l’hanno stupito perché non c’era abituato. E non era finta modestia la sua: pur essendo uno degli attori comici più famosi della sua generazione, è sempre stato abbastanza massacrato dalla critica, nonostante sia giustamente popolare e amato dalle masse. Sentirsi elogiato per una serie che ha diretto e prodotto è stata un’esperienza mai provata per lui.
Mi ha fatto pensare a quanto l’ironia sia un abito dell’intelligenza, e quanto colto possa essere il cervello comico. Saper fare ridere è una sapienza rara: significa saper mescolare piani semantici diversi, incrociare i significati, abbassare l’elevato ed ergere l’infimo.
Una delle qualità della battuta – oltre al beneficio liberatorio che dona – è che di per sé è inerte ma diventa materia viva quando incontra la mente di chi l’ascolta. Una battuta non è un oggetto assoluto ma ha bisogno di chi la dice e di chi l’ascolta. Deve essere tradotta e capita nella mente di chi la riceve. La magia non è nemmeno nella battuta in sé (anche in quello ma non solo) ma nel fatto che richiede un orecchio ricevente e un cervello che la elabora. Chi ascolta gode di una buona battuta perché l’ha capita, e, facendolo, se ne sente parte. La battuta deve essere “attivata” da chi l’ascolta.
Si gode a percepire di essere parte di un gioco mentale di cui si è un necessario attore.
Ben Stiller ha fatto battute più o meno sagaci per tutta la sua vita e poi ha fatto una serie TV incredibile e i critici si sono accorti di lui. Forse perché ha parlato per la prima volta il linguaggio che questi amano ascoltare: quello colto e polimorfo. Quello che ha una latitudine di comprensione molto estesa, perché può essere letto sulla superficie (una bella serie il cui meccanismo narrativo è così semplice da poter essere reso in poche parole, e cioè “i protagonisti sono persone comuni che vivono una scissione volontaria tra vita privata e lavorativa, e quando vestono i rispettivi panni non ricordano quanto accade all’altro sé”) ma anche in profondità: nella fotografia superlativa, nei riferimenti culturali, nel messaggio sociale o nella difficoltà di pronunciarne uno. O anche, forse, nella volontà di essere sfuggenti, ambigui, inafferrabili.
C’è differenza fra il Ben Stiller comico e il regista. Il comico porge battute che sono equazioni con una sola possibile soluzione mentre il regista racconta una storia più complessa, che può avere elementi di comicità o ironia ma che ha diversi livelli di lettura.
Una battuta è come una chiave che gira dentro una serratura: se funziona quella si apre, altrimenti non succede niente. Un’opera stratificata come Severance ha diverse voci e molteplici codici visivi. Lo dimostra il fatto che ognuno vi legge cose diverse e che il messaggio che porge è un solido a molte facce, e ognuna riflette il volto diverso di chi lo osserva. C’è chi vi vede una critica del capitalismo, chi del futuro, chi delle radici del presente. Ogni orecchio la sente parlare con una lingua familiare, e forse questa è una caratteristica delle più riuscite opere dell’ingegno: essere chiare ed inequivocabili per molti, suscitare qualcosa e pur sempre cose diverse negli animi di chi vi si trova al cospetto.
Ma non voglio parlare solo di Severance. Mi serviva più che altro come pretesto per parlare di una peculiarità di certe opere, ossia dell’alternanza energetica che innescano nell’osservatore. Questa definizione, che ho appena coniato, definisce il potere che hanno di evocare un’immediata identificazione (nella comprensione dei riferimenti, nella forza evocativa delle immagini, anche nella potenza visiva dell’iconografia) e anche un vuoto: soddisfano insomma l’esigenza manifesta di trovarsi di fronte a un messaggio e di capirlo, così come creano spazio per l’esplorazione mentale.
Certe opere d’arte, insomma, sono capaci di dare risposte ma anche di generare domande, non necessariamente riferite a se stesse.
Pensando ai riferimenti culturali, colti o meno, delle opere d’arte non posso non riferirmi ai simboli e alle allegorie dei cicli pittorici di secoli addietro. Chissà – mi chiedo – se la chiamavano o intendevano come arte già allora, o se erano opere descritte per ciò che erano: tele, pale, affreschi, sculture. È possibile che l’arte sia un concetto moderno o siamo (sono) così egoriferiti da pensarlo, come se il pensiero fosse un’invenzione tutto sommato recente? Eppure pensavano già – ed eccellentemente – i filosofi dell’antichità.
In verità mi chiedo se i riferimenti culturali e simbolici che un rinascimentale (nel senso di “vissuto” in quel periodo) sapeva cogliere dei cicli pittorici del tempo sono diventati i riferimenti a opere contemporanee e culturali nel presente.
Forse il processo manifesto è lo stesso: ciò che si vede non si esaurisce in se stesso ma rimanda sempre ad altro: a frammenti più o meno complessi di altre opere, letture e scritture. Un’opera d’arte non è mai solo quello che appare o che se ne vede: è essa stessa e anche tutte le altre opere a cui rimanda.
Una battuta è invece solo se stessa: ha il potere di innescare una reazione in chi la ascolta e di risolversi nell’incontro con una mente (la chiave che apre la serratura) ma per sua natura non evoca altro, non lascia spazio al vuoto della speculazione mentale: è un divertimento che soddisfa la mente che la decifra.
Forse ho paragonato due cose – battuta e opera d’arte – che non hanno niente in comune. La battuta spiega, l’opera d’arte suscita identificazione o meno ma fa anche spazio, lascia entrare, allarga la mente.
Sono due cose diverse. Ne volevo solo parlare rispetto a Ben Stiller perché è come se avesse compiuto un’evoluzione che l’ha portato dal far ridere a far riflettere, perché la battuta spiega ma l’arte avvia una conversazione che porta in regioni inesplorate e mostra scenari possibili.
C’è infine un altro modo di definire questo improprio paragone: la battuta è presente, l’opera d’arte è futuro poiché inizia una conversazione che a volte lo anticipa.
Gli artisti – spesso intesi come incomprensibili e quindi inutili nella logica produttiva corrente – sono messaggeri che hanno visitato il futuro e che lo raccontano nel presente. Per questo bisognerebbe ascoltarli e far spazio nella propria mente per accogliere quel vuoto creativo che porta altrove.
Bisognerebbe ascoltare i pensieri che un’opera d’arte genera, anche se sembrano incoerenti. Bisognerebbe educare l’anima a espandersi oltre la realtà, a indugiare in quel vuoto e a esplorarlo.
Ben Stiller l’ha fatto creando un’opera che non è altro che se stessa ma che riesce anche a fare spazio, e a riempirlo con domande. Raccontando una storia, ne ha raccontate altre che non si mostrano ma che germogliano nelle menti di chi osserva.