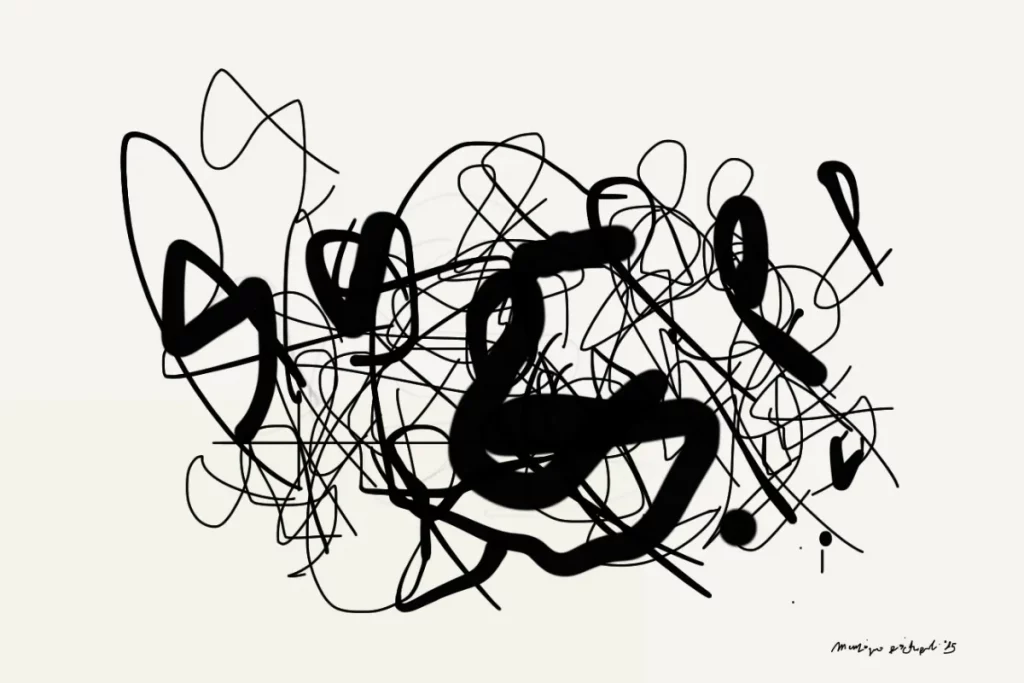L’@ è facile da scrivere: si fa una a e ne prolunghi la grazia, inscrivendola in un cerchio. La & è più difficile. Non la si usa frequentemente e il gesto per scriverla non è quindi automatico. Deriva dalla legatura di e e t di origine latina ma oggi è nota come E commerciale. Significa e.
In inglese si chiama ampersand, forma contratta e storpiata di per se and, cioè, presa singolarmente, and, o “di per sé and”. La formula “per se” deriva a sua volta dall’usanza di recitare le lettere dell’alfabeto precedute dal “per sé”, a indicare che la loro enunciazione fosse riferita alle lettere in sé, prese singolarmente.
Una volta, nelle culture anglosassoni, era l’ultima lettera dell’alfabeto, il che spiega anche la forma storpiata con cui è oggi indicata: ampersand sta per “and per se and”, cioè la congiunzione “and”, considerata singolarmente in quanto tale.
È curioso che una congiunzione sia stata considerata per molto tempo una lettera dell’alfabeto, per quanto composta da due lettere. La cosa ancora più curiosa è che l’alfabeto terminasse con il suggerimento che qualcosa continuasse. L’alfabeto è comunemente considerato un’insieme finito: contiene un certo numero di elementi e non di più. Questi elementi sono le cellule base del linguaggio e niente più. Fine.
Eccetto che per l’&, che ha occupato per molto tempo una posizione quasi filosofica, quasi a suggerire che l’insieme non fosse affatto finito, e che potesse alludere ad altro.
La scrittrice Kathryn Shultz è stata la prima a farmi riflettere sulla &. Nel suo libro Lost & Found: a Memoir, conclude la sua lunga riflessione sulla perdita del padre, la morte e l’amore trovato casualmente per la moglie proprio con una riflessione sul valore dell’and, cioè di una congiunzione che è additiva. È anche, azzardo, la prima congiunzione che si impara, anche perché è foneticamente più semplice da pronunciare ed è definita da un suono che qualsiasi infante sa produrre. Non è un caso, credo, che sia anche la base della struttura delle storie raccontate dai bambini, che costruiscono il pensiero con logica cronologica e additiva, mettendo in fila i fatti da narrare, senza curarne l’intreccio, anzi, evitandolo proprio perché appartenente a un livello narrativo più complesso e adulto.
I bambini hanno una visione lineare del tempo anche perché per loro tutto è nuovo e tutto egualmente importante e stupefacente. Nell’età adulta, si comprendere o subisce il dominio del tempo, e si riescono a mettere in relazione cause ed effetti, che è un altro modo per intrecciare piani temporali diversi e distanti.
Eppure, nota Kathryn Shultz, c’è qualcosa di generativo in questa congiunzione: la e stabilisce una relazione temporale (qualcosa viene dopo qualcosa che lo precede) o valoriale (qualcosa è allo stesso livello di qualcos’altro) ma è anche capace di creare relazioni imprevedibili fra oggetti mentali e significati diversi.
Mentre le altre congiunzioni implicano relazioni più strette e vincolanti fra ciò che legano (“succede qualcosa ma nel frattempo succede dell’altro”, e l’insieme delle congiunzioni non copulative – come la e – ma avversative, conclusive ecc.) la e ha un maggior grado di libertà, non ultimo quello di creare significati non logici. Si prendano per esempio due oggetti distinti, come l’elefante e il petrolio. Non vi è alcuna relazione fra di loro ma proprio la presenza della e, magicamente, libera un possibile significato, e anzi più di uno: quello della relazione inedita fra elefante e petrolio e quello dell’elefante assieme al petrolio.
Ora, queste potrebbero sembrare oziose speculazioni linguistiche, se non fosse che, osserva sempre Kathryn Shultz, la vita è esattamente così:
La vita è un insieme di attimi che si sommano l’uno all’altro, e messi in fila fanno l’arco di un’esistenza.
Della vita si vorrebbe avere una visione coerente, e questa è l’educazione in cui bene o male chiunque è stato formato, cioè che essa debba dipanarsi lungo una linea evolutiva che, si spera, porti alla fine in uno stato di saggezza più elevata di quella di partenza. Questa è almeno l’evoluzione auspicata e, grossomodo, anche la spina dorsale del pensiero occidentale.
Specifico “occidentale” perché in Oriente – e mi riferisco in particolare alle culture buddiste e induiste – il concetto di tempo è circolare e non lineare, e l’eventuale evoluzione è vista come esito dell’alternarsi di cicli costruttivi e distruttivi (del resto Shiva è il dio distruttore, meno noto è che sia anche il costruttore, o almeno quello che distrugge per dare modo di ricostruire).
Osservare la propria vita come un insieme di sviluppi coerenti e di azioni e decisioni che hanno portato a snodi evolutivi (o involutivi) è un modo per costruire una narrazione coerente, una storia di se stessi. Ma è anche – e questo è un aspetto più sottovalutato ma insidioso – un modo per giustificare a posteriori il motivo per cui ci si trova dove ci si trova.
Se ora sto scrivendo queste parole è perché ogni azione gesto decisione incontro libro letto pasto consumato emozione aspettativa delusa gioia dolore, tutto insomma quel che mi è successo sino a questo momento mi ha condotto esattamente qui. Se si potesse decostruire a posteriori uno sviluppo del genere e ripercorrere la vita a ritroso si potrebbero individuare certamente degli snodi della narrazione ma si trascurerebbe che queste tensioni – poi sfociate in decisioni o non-decisioni – sono composte da unità, da momenti insignificanti di per sé eppure significativi nel loro insieme.
In questo senso, l’e è una congiunzione filosofica, è l’operatore linguistico ed esistenziale che lega tutti questi momenti e li accumula, costruendo una relazione fra di loro ed edificando una singola esistenza. L’aspetto più sottile del suo modo di funzionare è però che non vi è coerenza fra questi momenti, esattamente come la vita è fatta di attimi che non sono necessariamente consequenziali ma sono, appunto, incoerenti. Eppure proprio nel loro accumulo sta il loro senso:
Senza la somma dei singoli, insignificanti momenti della vita, non vi sarebbe alcuna evoluzione.
Se questa sembra l’apologia dell’insignificanza, è perché lo è. O meglio: è l’apologia di ciò che è considerato insignificante, salvo esserlo, eccome.
Ciò che unisce questi momenti è una semplice congiunzione: prima succede qualcosa, poi succede un’altra cosa. L’unica relazione fra le due e poi fra queste e quelle che le precedono o le seguono è il fatto di essere legate dalla congiunzione e. Esistendo fra momenti disposti lungo una linea temporale, questa semplice coniugazione crea oggetti e significati diversi. Un attimo e quello dopo sono frammenti di vita slegati, ma una volta legati da e diventano qualcosa di diverso, sino a creare episodi e storie che confluiscono nei nodi esistenziali.
Eppure di questo svolgimento frammentato e dispersivo conserviamo solo i momenti significativi, quelle particolari accumulazioni di significato che cogliamo come fondanti, le articolazioni dell’esistenza.
Non è ovviamente possibile avere contezza e contabilità di tutti questi frammenti, anche perché non v’è logica e conseguenza di uno con l’altro ma è innegabile che, se essi non esistessero, non esisterebbero nemmeno le più ampie narrazioni e le pagine memorabili delle vite.
E tutto sta in una e, nel suo potere accumulativo, e nella memoria di una lettera di un alfabeto che a un certo punto è decaduta, e qui la si voleva celebrare.