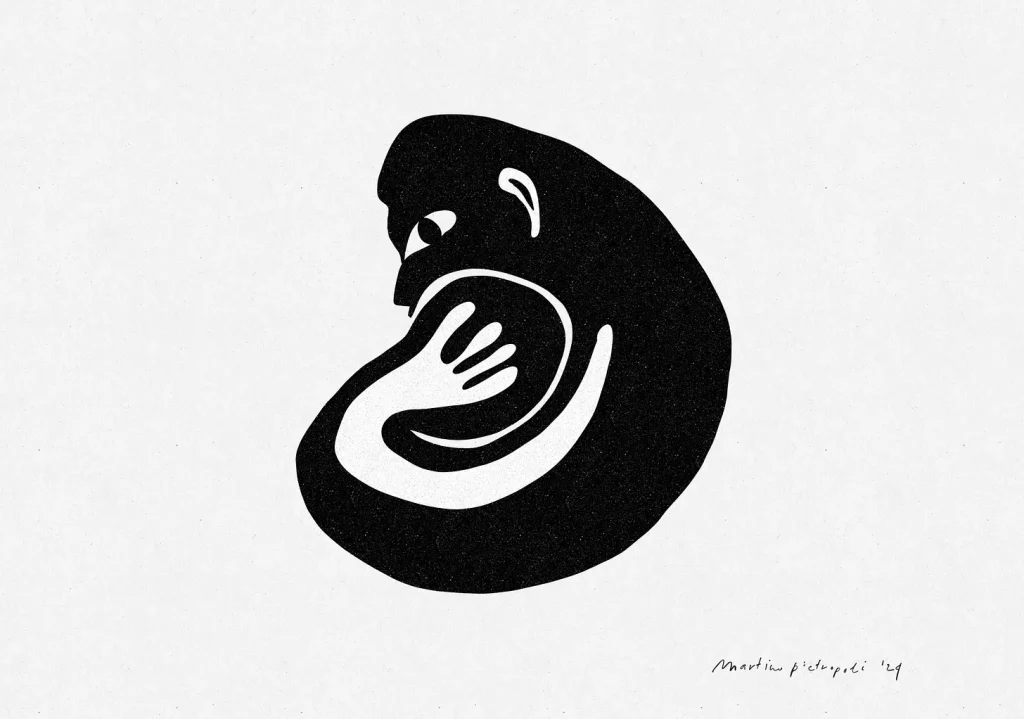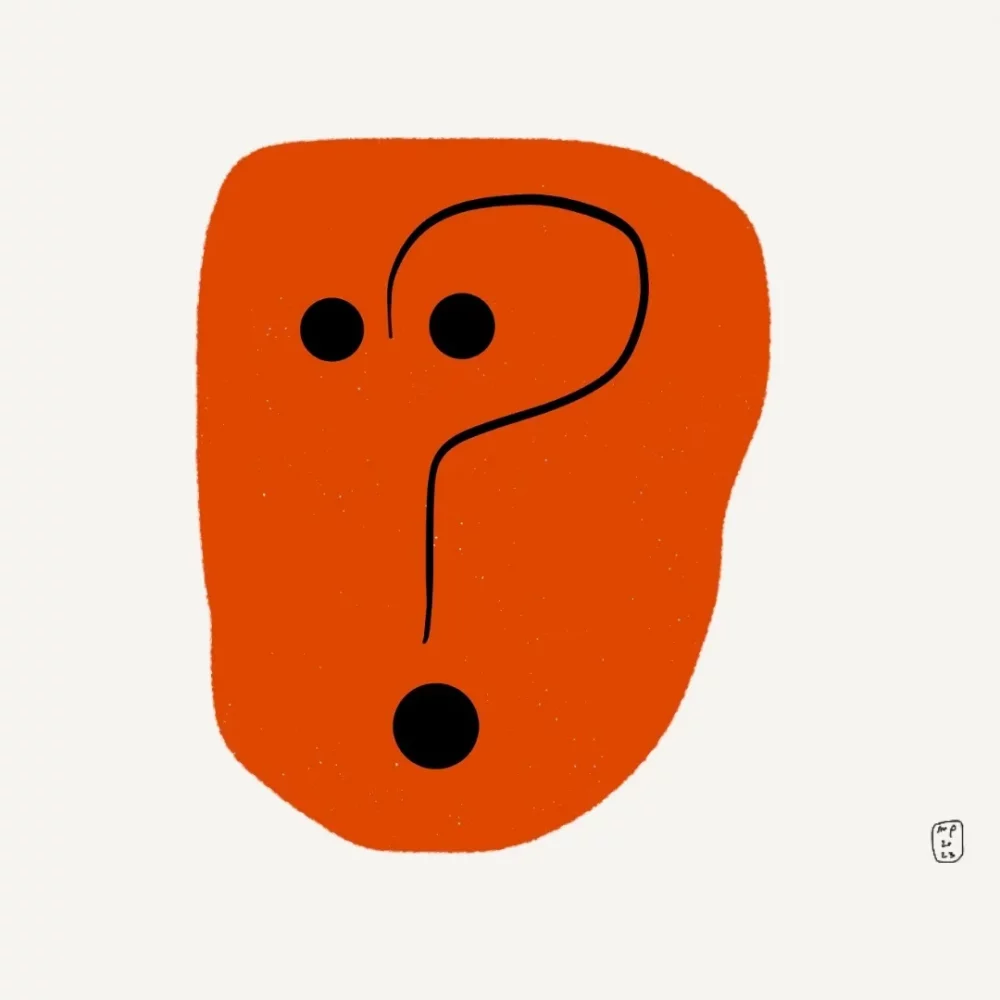Questa settimana ho partecipato a un seminario. Ero fra filosofi e sociologi. Mentre ero lì pensavo ovviamente a cosa ci stessi facendo (ma non conta) ma soprattutto pensavo alla mia ossessione per il linguaggio. I sociologi parlano per astrazioni, o almeno quelli che ogni tanto mi capita di frequentare. Mi affascina il loro modo di parlare anche se confesso di capirne a malapena un 20%. Non usano solo astrazioni ma anche molte espressioni che evidentemente sono chiare solo a loro. È logico e pratico: un concetto noto a un gruppo di persone può essere richiamato da una precisa combinazione di parole.
A un certo punto uno ha detto “Questo è un oggetto di frontiera”, allora ho chiesto “Cosa intendi per ‘oggetto di frontiera’?”. Me l’ha spiegato e ho capito. Un concetto interessante riassunto in un’espressione elegante. “Oggetto di frontiera”, bello.
Allora ho pensato all’”orizzonte degli eventi”, che invece è un’espressione astrofisica che ha qualcosa di ancora più poetico. I linguaggi specialistici hanno a volte qualcosa di particolarmente raffinato, anche se magari non vi era questa intenzione in chi li ha inventati. Ecco perché mi ossessiona il linguaggio: perché suscita immagini diverse nella mente di chi lo elabora, in funzione della conoscenza o come del contenuto che richiama. Un oggetto è un oggetto (e chiunque può pensare a qualsiasi oggetto o al concetto di oggetto” quando sente la parola “oggetto”) ma un oggetto di frontiera ha una semantica molto diversa, pur essendo un’espressione sintetica: rimanda ad altro, di più ampio.
Allora ho pensato alle rane.
A dirla tutta, questa settimana ho imparato un’altra espressione. In realtà l’avevo già sentita ma finalmente ho capito cosa significa. L’espressione è “referente assente” e indica la mancanza di qualcosa che è presente in una sua parte, o anche la presenza di qualcosa che proviene da qualcosa che è assente. L’ambito da cui è nata l’espressione – cioè quello dell’attivismo vegetariano e femminista, in particolare espresso da Carol J. Adams – spiega meglio di cosa si tratta.
Una bistecca è ciò che resta di un referente (la mucca) che è assente (nella sua interezza). La naturalezza con cui molti la mangiano è legata al fatto che la mente non collega l’oggetto-bistecca all’animale. Sa da dove proviene ma non la colloca nell’oggetto-mucca, né probabilmente sa da quale parte dell’animale proviene, anche perché nel frattempo l’animale è morto. L’interruzione della catena di collegamenti fra le parti permette di superare il disgusto che si potrebbe provare all’idea di mangiare un animale, o almeno lo rende trascurabile. A un certo livello di elaborazione gastro-mentale, la parte dell’animale non è l’animale. La decontestualizzazione rende lecito consumare animali e contemporaneamente risolve anche l’idea di morte dell’animale da cui proviene e, in senso più lato, anche l’idea della morte stessa. La bistecca è viva, è nel piatto, esiste. L’animale da cui proviene non esiste più poiché è morto ed è eventualmente altrove, dove per altro non è visibile.
Tagliando una bistecca ci si può concentrare sul tutto-animale e immaginarlo nella sua interezza ma si tratta pur sempre di un’evocazione: una bistecca proviene da un’animale ma non è l’animale, che è assente. Pertanto è tollerabile il cibarsene. O trascurabile, poiché mangiare una parte di animale non evoca l’intero animale.
Il referente assente mi ha fatto ricordare che non avevo mai mangiato rane prima di una sera, più di due decenni fa, in Vietnam.
Ne avevo ordinate un piatto intero: ricordo che erano fritte, una specialità locale di una cittadina di cui non ricordo il nome lungo il Mekong. Le attendevo con ansia e una certa fame.
Quando posarono il piatto di fronte a me pensai “Sono proprio rane”. Erano intere, erano fritte, erano rane. O erano state rane.
Erano ancora rane? Erano di certo cibo che proveniva da un animale che prima era stato vivo e ora era morto. Oggi capisco che il referente era presente, vivo o morto che fosse (decisamente morto, a dire il vero).
Ero così incuriosito dal provare a cibarmene che ne staccai una zampa posteriore e la addentai. Mangiare una rana è come mangiare un piccolo pollo: la carne ha un sapore molto simile, anche se le dimensioni sono molto più contenute. Mentre lo masticavo pensavo che effettivamente assomigliava moltissimo al pollo. Poi provai una nausea sempre più innegabile. Mentre continuavo a masticare una delle rane che erano nel mio piatto vedevo le altre, intere ancora per un po’. Ma già morte, decisamente morte. Le lasciai quasi tutte nel piatto.
Non riuscivo a non pensare all’animale intero, anche perché ce l’avevo di fronte a me.
Ci si può chiedere perché non abbia mai provato la stessa sgradevole sensazione per un pollo che, come una rana, viene servito intero.
Ho un paio di spiegazioni e sono personali (nel senso che non so se la scienza le confermi o meno).
- Mangiare un pollo è un’esperienza più comune ed è probabile che moltissime persone abbiano visto e mangiato un pollo sin da bambini, e quindi non ci trovino niente di strano. La mente ha già risolto molti anni addietro che quello è un animale ma non se ne cura.
- Un pollo non ha la testa, quindi è privato di una parte che ne definisce l’identità, che lo rende una creatura completa. Un pollo decapitato è un pollo decapitato, nel senso che non è più un pollo intero. Ogni parte sottratta all’animale intero aggiunge distanza emotiva fra chi se ne ciba e l’animale vivo. Fino all’estremo esempio della bistecca, che non ha nemmeno una forma che evochi l’animale di provenienza. Ma la rana no: quella è intera.
Si potrebbe avanzare la stessa osservazione anche per i pesci e infatti vi sono persone che non ne mangiano perché razionalmente o irrazionalmente infastidite dal vederli interi. Non nel mio caso e credo per un motivo preciso: gli animali terrestri hanno arti e parti riconducibili a un’unità antropomorfa. Hanno braccia e gambe e testa, anche se si chiamano diversamente. Un pesce ha una forma senza riferimenti che possano evocare parti del corpo umano.
Come accennato prima, l’assenza cui si riferisce il referente assente è la morte stessa: essendo assente non viene suscitata nella mente di chi si ciba di carne o pesce. Mangiando animali morti si può non pensare alla morte poiché, trasformati dal processo di cottura e dall’essere ridotti in parti non fan venire in mente la morte.
Ho ripensato inevitabilmente a Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante di Greenaway. Il banchetto finale si conclude con un piatto molto particolare: l’amante della moglie del criminale protagonista, cotto. L’idea di servirlo all’odiato marito viene alla moglie dopo che, scoperto il tradimento, lui l’ha fatto uccidere.
Vidi questo film tantissimi anni fa eppure si è sedimentato nella memoria. Bisognerebbe sempre prestare attenzione alle memorie perché seguono una logica di archiviazione molto precisa: ci si ricorda solo ciò che ha importanza e significato, e quel film evidentemente ce l’aveva, o almeno per me. Solo che l’ho scoperto molto tempo dopo, e cioè oggi.
Quel film risolve l’enigma del referente assente, trasformandolo nel referente presente: di fronte al marito c’è il corpo dell’amante, è intero, è riconoscibile come tale ed è morto. Eppure esiste in una forma diversa e lui è costretto dalla moglie che gli punta una pistola addosso a cibarsene.
Il cannibalismo è inaccettabile non solo socialmente ma anche geneticamente, nel senso che è scritto nel nostro stesso codice. Mangiare un corpo umano significa mangiare se stessi ma mangiando se stessi ci si dà anche la morte. Si mangia la morte e non si riesce contemporaneamente a sconfiggerla.
Se il cibo è vitale poiché necessario alla sopravvivenza, mangiare se stessi significa garantirsi la vita e la morte allo stesso tempo, giungendo all’elisione dei due opposti, cioè al nulla.
Allora la scelta è fra la morte e il nulla, ed è ardua: la prima allude alla vita che l’ha preceduta (non si potrebbe essere morti senza prima essere stati vivi), mentre il secondo può esistere in assoluto, senza bisogno di misurarsi con un opposto. Il nulla riempie ogni spazio e non ha bisogno di altre per esistere: non della vita, non del tutto. Il nulla è ovunque ma non contempla la vita. Nel nulla non si può esistere né tantomeno morire.