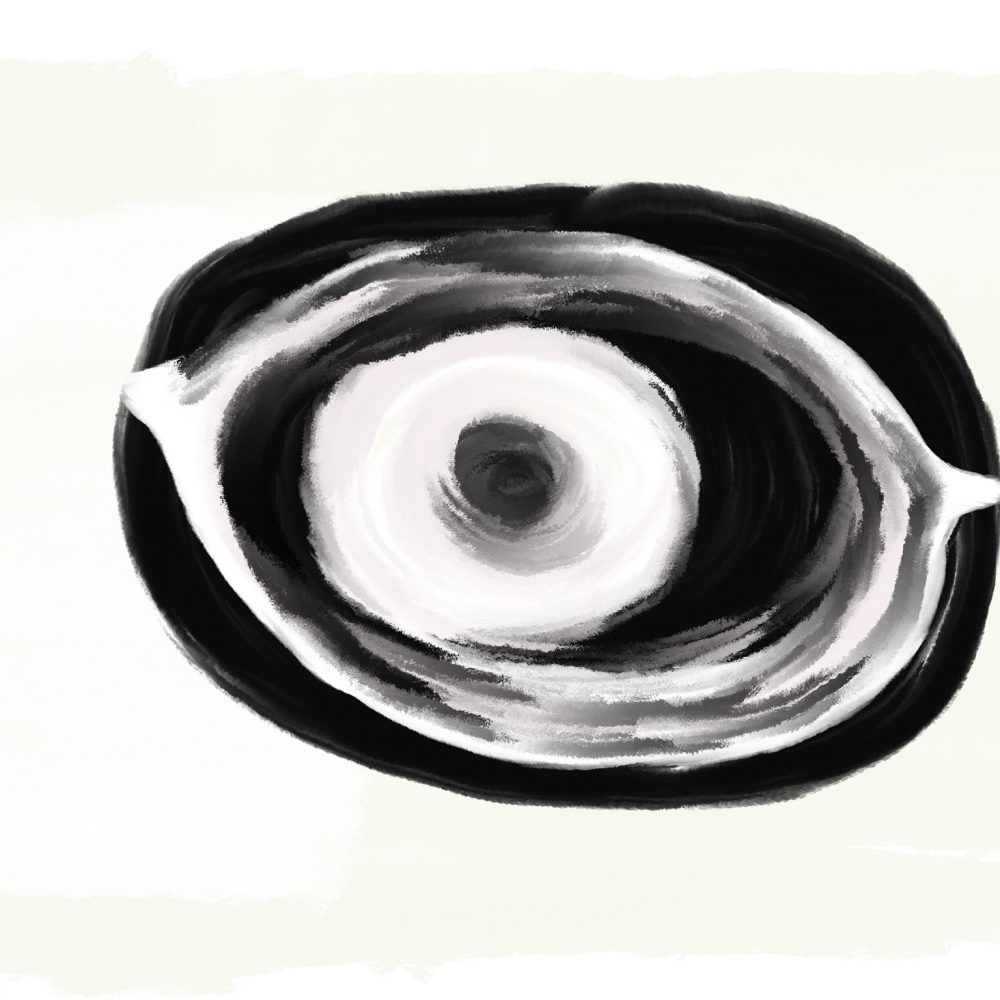Direi che fermarsi al primo movimento della Quinta di Beethoven è un peccato. È il più celebre per l’incedere perentorio e inconfondibile, eppure potrà stupire sapere che è forse il meno interessante dell’intera sinfonia. Questa potrebbe essere una metafora della pigrizia o dell’apparenza: del fermarsi alla superficie delle cose, ammesso che il primo movimento della Quinta sia solo la sua superficie. Diciamo che la Quinta è molto altro, per esempio è composta da un secondo movimento – l’Adagio – che è uno dei più belli che si possano sentire.
Come sempre non ho un’idea ben definita di cosa scrivere, ma questo è un esercizio, è la mia disciplina settimanale: è un esercizio di scrittura, è un flusso. L’importante è farlo, da qualche parte saprà condurre. Dove, non si sa.
Ascoltavo la Quinta camminando, ovviamente non partendo dal primo movimento. Troppo inflazionato, troppo ascoltato: credo di non poter più trarre alcuno stupore dal suo ascolto. Prima avevo ascoltato la Passione secondo Matteo di Bach. Ho pensato che non c’è musica che esprima più precisamente in note l’architettura: non nel senso di un edificio (quello, anche) ma nel senso della costruzione. Se la si ascolta a occhi chiusi si intuisce facilmente come Bach stia costruendo l’edificio di quella Passione. Matematica, musica, materia, costruzione.
Bach racconta una storia. E mi si perdoni l’accostarlo a Steve Jobs (che non credo se ne avrebbe avuto a male) ma ho ripensato anche a cosa diceva quando era alla Pixar, e cioè che la persona più potente al mondo è colui che è capace di raccontare storie, perché è in grado di comunicare una visione e dei valori e di dare forma a come penseranno intere generazioni. Lo disse alla Pixar e per capire quanto accurata fosse questa affermazione basta pensare a quale immaginario collettivo hanno saputo formare i suoi film. “Formare”, proprio nel senso di dargli forma. Esattamente come fece Walt Disney (sul quale ho diverse riserve che non esporrò in questa sede).
Non mi dilungherò (lo dico sempre quando poi mi dilungo) ma non avendo un pensiero sistematico, questa volta metto su un tavolo immaginario dei foglietti mentali su cui ho annotato cose, confidando che l’averlo fatto – cioè avendole trovate interessanti tanto da annotarle – indichi un qualche legame fra di loro.
Una di queste cose è legata alla capacità di raccontare storie: non si tratta né della storia in sé e forse nemmeno tanto nella tecnica con cui queste son narrate ma nella capacità evocativa. Jobs non avrebbe parlato di “visione e valori” e solo di quelli se non avesse pensato che erano proprio quelli il centro gravitazionale della questione. Lo svolgimento della storia è strumentale alla sua forza evocativa ma ciò che conta è, appunto, cosa è capace di evocare.
Questo potere è così importante da poter emanare solo da chi possiede la capacità di esprimerlo. Cosa significa? Significa che l’autorità e il ruolo non garantiscono il potere di saper evocare alcunché. In un altro foglietto mentale ho annotato – dopo aver assistito a una convenzionale omelia di un vescovo – che l’autorità non corrisponde all’autorevolezza o che, in altri termini, è data anche autorità senza potere. Specifico meglio: un certo potere è garantito dal ruolo sociale e istituzionale (di certo un vescovo, in un determinato ambito, ne ha più di me) ma chi è capace di raccontare storie – cioè di evocare valori e visioni – ha molto più potere di chi si esprime per astrazioni e principi.
Non ho mai amato molto le prediche in chiesa. Probabilmente ho incontrato raramente chi le sapesse fare. Mi pareva che riguardassero sempre altri, che non c’entrassero con la mia vita.
Mentre ascoltavo questa ennesima di un vescovo ho guardato la luce che entrava da un’alta finestra della chiesa. Ho notato che guardo soprattutto quei dettagli: come la luce entra in una chiesa. È più raro che osservi i mille altri particolari ma quella la noto sempre. Le buone chiese sono sempre fatte di ottima luce e di sapienza nel saperla attrarre verso l’interno.
Allora ho pensato che frequento poco le chiese perché quando mi capita ci sono esseri umani dentro. Non ho niente contro di loro: ho solo pensato che forse dovrei andare in chiesa un mercoledì mattina qualsiasi o un venerdì dopo pranzo. Ci troverei qualche vecchietta o forse nessuno e potrei sedermi a guardare quella luce particolare.
Le chiese sono anche ricolme di storie che non capisco. Dell’apparato iconografico di una qualsiasi chiesa storica so cogliere forse un 5%. Riconosco le figure chiave ma non di certo i santi e le sante. So a malapena le storie della Bibbia, dubito di saperle indovinare dipinte alle pareti o scolpite su un pulpito. La luce però la capisco sempre: come si modula, come appare e scompare al passaggio di una nuvola, come trova la sua via verso l’interno, per stagliarsi lassù in alto.
Ogni volta che vado in chiesa ripenso a molte delle chiese che ho visitato. Se indugio a riflettere devo ammettere che a ogni chiesa è legata una storia. Una mia storia: una funzione a cui ho assistito, un viaggio durante il quale ho visto proprio quella chiesa.
Alle chiese mi legano (o ci legano) delle storie. Personali o collettive ma pur sempre frammenti di ricordi e quindi storie.
Il potere delle storie è visibile quando pare che parlino solo a te. È un punto di contatto fra il tempo in cui quella storia è successa e il presente individuale. Un portale fra passato e presente che si apre.
Non sono credente ma sono spirituale e colgo certe vibrazioni. Almeno le colgo nelle chiese. Nella Passione secondo Matteo di Bach o nell’Adagio della Quinta di Beethoven.
C’è un ultimo frammento ed è un’osservazione che ha fatto un amico a qualcosa che avevo scritto. Ha detto “La musica è l’unica arte che non tenta di imitare la realtà”. La pittura – non quella astratta, ovviamente – o la scultura lo fanno ma la musica ha un linguaggio che non rappresenta niente di umano. O almeno non ha forma antropomorfa. Ha quella dell’anima, forse, ammesso che si possa intuire quale forma ha.
Dubito ne abbia una (sarebbe limitante ne avesse una) però credo ne possa avere una mediata, allusa: quella dell’edificio che Bach costruisce con la sua musica, quella della luce che entra da una finestra di una chiesa. Non è la luce del sole e del cielo ma è la forma che ha attraversato il telaio e il disegno della vetrata. È una luce con una forma che allude alla fonte che l’ha generata, cioè quella del sole o della volta celeste.
Penetra in un edificio che uomini hanno costruito, che contiene storie, che genera altre storie. Forse il silenzio delle chiese è più eloquente delle parole umane che vi si pronunciano all’interno.